|

PASQUA - ROMA PASQUA
2011 - UOVA DI PASQUA - COLOMBA PASQUALE - QUARESIMA
|
LE ORIGINI DELLA
PASQUA... |
| |
|
Festa di Pasqua: scopriamo le origini
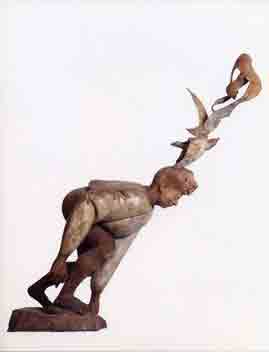 La
parola Pasqua deriva dall’aramaico “paschà” e dall’ebraico “pesach”.
Nell’antico Testamento sta ad indicare il rito che si svolgeva in
occasione del primo plenilunio di primavera e l’agnello che durante
questa festa veniva immolato. Il suo significato doveva essere
legato anche alla danza, ossia al saltare rituale che veniva
effettuato all’interno della celebrazione. Questo perché in
coincidenza con una festa primaverile - riportano le antiche
scritture - Jahve “saltò oltre” e risparmiò le case israelitiche
segnate dal sangue dell’agnello sacrificato. La
parola Pasqua deriva dall’aramaico “paschà” e dall’ebraico “pesach”.
Nell’antico Testamento sta ad indicare il rito che si svolgeva in
occasione del primo plenilunio di primavera e l’agnello che durante
questa festa veniva immolato. Il suo significato doveva essere
legato anche alla danza, ossia al saltare rituale che veniva
effettuato all’interno della celebrazione. Questo perché in
coincidenza con una festa primaverile - riportano le antiche
scritture - Jahve “saltò oltre” e risparmiò le case israelitiche
segnate dal sangue dell’agnello sacrificato.
E’ evidente che la Pasqua giudaica, all’inizio, si presentava dunque
come una festa nomade di primavera, collegata alla transumanza dei
pastori della terra di Canaan. A questa prima concezione ben presto
se ne aggiunse una seconda, la più nota: la Pasqua come celebrazione
dell’Esodo degli ebrei dall’Egitto. Ovvero, la liberazione del
popolo di Israele dalla schiavitù del Faraone, avvenuta - secondo
alcuni - alla mezzanotte del 14° giorno del mese di Nissan del 1445
a. C.
Gesù morì in occasione di una Pasqua giudaica e ciò, naturalmente,
influì su quella che sarebbe poi diventata la tradizione pasquale
cristiana. Alla base di tale processo è la lettura dell’Antico
Testamento come prefigurazione del Nuovo. Il Concilio ecumenico di
Nicea del 325 impose a tutte le Chiese di celebrare la Pasqua di
Resurrezione la prima domenica dopo la prima luna piena che segue
l’equinozio di primavera (21 marzo). E’ questo il motivo per cui la
Pasqua cristiana è una festa “mobile”, “alta” o “bassa” a secondo
degli anni.
di Annalisa Venditti |
|
SPECCHIO
ROMANO - SPECIALE PASQUA 2011 |
| |
|
La
Quaresima dei primi cristiani:
addio alla carne e ai suoi piaceri
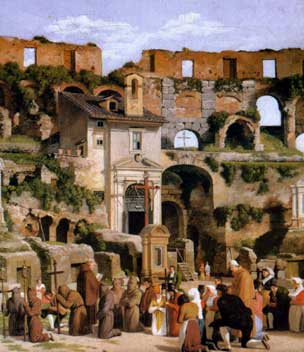 Il
diario di viaggio di Egeria, una pellegrina spagnola che tra il 381
ed il 384 si recò nei luoghi santi della Palestina, ci ha lasciato
una dettagliata descrizione delle celebrazioni pasquali nei primi
anni della Chiesa. I suoi appunti, compilati come una vera e propria
cronaca, sono il primo resoconto completo in cui il ciclo pasquale
compare strutturato in Quaresima, Settimana Santa, Ottava di Pasqua
(ossia gli otto giorni che seguono la Resurrezione), Ascensione (il
quarantesimo giorno dopo la Pasqua) e Pentecoste (i cinquanta giorni
successivi). Il
diario di viaggio di Egeria, una pellegrina spagnola che tra il 381
ed il 384 si recò nei luoghi santi della Palestina, ci ha lasciato
una dettagliata descrizione delle celebrazioni pasquali nei primi
anni della Chiesa. I suoi appunti, compilati come una vera e propria
cronaca, sono il primo resoconto completo in cui il ciclo pasquale
compare strutturato in Quaresima, Settimana Santa, Ottava di Pasqua
(ossia gli otto giorni che seguono la Resurrezione), Ascensione (il
quarantesimo giorno dopo la Pasqua) e Pentecoste (i cinquanta giorni
successivi).
La Quaresima, periodo di preparazione e digiuno che i fedeli
osservavano in memoria dello stesso tempo in cui Cristo era stato
nel deserto, precedeva la celebrazione pasquale. In occidente si
protraeva per quaranta giorni. A Gerusalemme, invece, era più lungo:
venivano, infatti, esclusi dal computo sia il sabato che la
domenica, giorni in cui non era permesso digiunare. All’astinenza,
diversificata secondo i contesti e la volontà dei singoli, si univa
la preghiera comunitaria e liturgica.
Sappiamo che ai primi cristiani era vietato consumare la carne ed
alimenti di natura animale come le uova e i latticini. Il digiuno
comprendeva anche l'astinenza dal vino. Lo testimoniano gli scritti
di S. Cirillo di Gerusalemme, S. Basilio, S. Giovanni Crisostomo e
Teofilo d'Alessandria. Ma non tutti riuscivano a sopportare le
“torture” della penitenza. E, spesso, ci si poteva smarrire sulla
via della santità. Anche se si era animati da un fervido sentimento
religioso. Un fatto piuttosto curioso è quello che tra la metà del
IV e gli inizi del V secolo vide come illustre protagonista il
pastore Massimo di Torino. Esasperato dalla diffusa e ai suoi occhi
deprecabile abitudine di non rispettare il digiuno, così
rimproverava quanti, ed erano molti, non lo osservavano: “è
vergognoso dirlo, ma i vecchi e le vecchiette fanno la quaresima,
mentre i giovani e ricchi non la fanno!”. Il periodo di penitenza,
tutto sommato, rendeva anche più buoni. Così gli imperatori Graziano
e Teodosio, in vena di gesti misericordiosi, promossero nel 380 una
legge che prevedeva durante questo periodo la sospensione di tutti
gli atti giudiziari. Era una forma di indulgenza sociale, introdotta
anche da Valentiniano II (375-392) con il rilascio di detenuti.
Potremmo definirla una sorta di “pulizia” pasquale delle carceri.
Dal canto suo, Sant’Agostino (354-430) invitava i cristiani non solo
al digiuno alimentare, ma soprattutto ad evitare liti e contese, a
praticare l’elemosina e la sospensione dei piaceri coniugali.
Insomma, se penitenza doveva essere, che lo fosse “in” e “per” tutti
i sensi.
di Annalisa Venditti |
|
SPECCHIO
ROMANO - SPECIALE PASQUA 2011 |
|
NELLA ROMA
DI UNA VOLTA AL BANDO CARNE, UOVA, FORMAGGIO E DIVERTIMENTI |
|
Le proibizioni della Quaresima
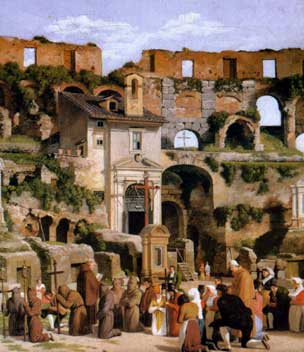 Con
la solennità delle Ceneri è cominciata per i cattolici la Quaresima,
periodo di penitenza in preparazione della Pasqua, molto osservato
nei secoli passati, quando le autorità pontificie rinnovavano ogni
anno i provvedimenti per disciplinare il digiuno. Per circa quaranta
giorni non era consentito mangiare uova, formaggio e carne, a meno
che non si fosse anziani e malati o non si ottenesse un permesso
scritto. Non mancavano severi moniti ai medici, affinché non
redigessero finti certificati di malattia, a meno che non volessero
incorrere non solo nei castighi celesti, ma anche in quelli terreni,
più sicuri e immediati. Secondo Giggi Zanazzo, però, c’erano "bbône
ddispense p'er magnà dde grasso, che sse ponno co' ppochi sòrdi
ottiene’ ddar curato de la parocchia". Con
la solennità delle Ceneri è cominciata per i cattolici la Quaresima,
periodo di penitenza in preparazione della Pasqua, molto osservato
nei secoli passati, quando le autorità pontificie rinnovavano ogni
anno i provvedimenti per disciplinare il digiuno. Per circa quaranta
giorni non era consentito mangiare uova, formaggio e carne, a meno
che non si fosse anziani e malati o non si ottenesse un permesso
scritto. Non mancavano severi moniti ai medici, affinché non
redigessero finti certificati di malattia, a meno che non volessero
incorrere non solo nei castighi celesti, ma anche in quelli terreni,
più sicuri e immediati. Secondo Giggi Zanazzo, però, c’erano "bbône
ddispense p'er magnà dde grasso, che sse ponno co' ppochi sòrdi
ottiene’ ddar curato de la parocchia".
A chi
non voleva contravvenire alle regole restavano pane, verdure,
legumi, baccalà e... maritozzi. "In quaresima pe' ddivuzzione –
continuava Zanazzo - se magneno li maritozzi, anzi c'è cchi è ttanto
divoto pe' mmagnalli, che a ccapo ar giorno se ne strozza nun se sa
quanti".
Dagli
editti era anche vietato "fare disordini, schiamazzi e scandali",
soprattutto durante le frequenti cerimonie religiose. Anche perché a
quanto pare le visite alle chiese per impetrare le indulgenze
diventavano troppo spesso occasioni di incontri galanti.
Durante
la Settimana Santa alle prostitute era proibito apparire in
pubblico: non potevano circolare per le strade o ricevere uomini a
casa, ma nemmeno recarsi alle stazioni quaresimali o ai sepolcri.
Le
osterie dovevano restare chiuse di notte, mentre alle suore era
persino proibito l’allestimento dei sepolcri, considerato un
divertimento un po’ troppo mondano.
di
Cinzia Dal Maso |
|
SPECCHIO
ROMANO - SPECIALE PASQUA 2011 |
|
Per
molti popoli l’uovo rappresentava la vita e la fertilità |
|
Antiche origini di
un simbolo pasquale
Nell’antica Roma, per ottenere dagli dei un buon raccolto, i
contadini usavano seppellire nei campi delle uova dipinte di rosso.
Simbolo della vita e della fertilità della terra, le uova
racchiudono un segreto millenario che accomuna popoli e religioni
diverse.
Già in
Egitto veniva loro attribuito un valore cosmico ed universale. I
sarcofagi, ad esempio, erano considerati un guscio-involucro che
proteggeva il corpo mummificato nel lungo viaggio dopo la morte. In
Mesopotamia si credeva che l’Amore avesse avuto origine da un uovo.
Astarte, la personificazione di questo nobile sentimento, era
secondo la leggenda nata da un esemplare di straordinaria grandezza,
rinvenuto dai pesci sul fondo del fiume Eufrate. Spinto a riva dalla
corrente, era stato covato da una colomba, mostrando – solo al
momento della schiusa - la sua meravigliosa "sorpresa".
La
Grande Madre Cibele, emersa nuda dal Caos, aveva diviso il mare dal
cielo e sfregando tra le mani il vento del nord, aveva generato un
serpente. L’animale si era poi congiunto a lei. Divenuta una
colomba, Cibele aveva deposto l’uovo cosmico. Da quell’uovo, dopo
che il serpente lo avvolse sette volte, ebbero origine tutte le
cose.
Pure il
mito greco di Leda e il cigno ruota attorno alla simbologia
dell’uovo, esempio di somma perfezione. La principessa venne a sua
insaputa fecondata da Zeus, apparso sotto le mentite spoglie di un
elegante uccello. L’unione originò due uova: in una erano i gemelli
Castore e Polluce, nell’altra Clitennestra, moglie del re
Agamennone, e Elena, la sposa di Menelao, tanto bella da scatenare
la guerra di Troia. In un’antica leggenda indiana è narrato che fu
un cigno a covare sulle acque l’uovo da cui ebbe origine il mondo.
Come
augurio di immortalità, uova dipinte sono state rinvenute anche a
Cartagine e nelle necropoli etrusche. A Tarquinia, ad esempio, un
defunto della Tomba delle Leonesse (fine del VI sec. a.C.), è
rappresentato mentre tiene tra le dita un piccolo uovo bianco,
immagine della vita oltre la morte.
Per la
cultura ebraica la sua superficie, perfetta e continua,
rappresentava l’eternità della vita: per questo durante il banchetto
non poteva essere spartito tra i commensali. La sua divisione
avrebbe presagito la distruzione dell’esistenza. Il Cristianesimo
accolse la simbologia dell’uovo sin dall’epoca di Sant’Agostino.
E il
suo significato mistico venne legato alla Resurrezione di Cristo.
L’uovo divenne così l’immagine della rinascita e della vita oltre le
tenebre del peccato.
Pare
che l’usanza di regalare le uova in occasione della Pasqua risalga
al 1100, quando si diffuse la tradizione di benedirle e di offrirle
in Chiesa la domenica di Pasqua.
A
trovare per primo un sorpresa nell’uovo fu invece Francesco I di
Francia, che agli inizi del ‘500 ricevette un guscio con all’interno
un’incisione su legno della Passione di Cristo.
di Annalisa Venditti |
|
SPECCHIO
ROMANO - SPECIALE PASQUA 2011 |
|
Era il trionfo delle ghiottonerie esposte dai
pizzicagnoli |
|
Roma "de ‘na vorta" Il
pranzo di Pasqua
L’aspetto
sacro trovava la sua espressione nelle vetrine delle botteghe,
nell’utilizzo "architettonico" di salami, prosciutti, salsicce e
caciotte
 Nei
giorni immediatamente precedenti la Pasqua, nella Roma
dell’Ottocento i negozi di generi alimentari, soprattutto i "pizzicagnoli", gareggiavano
fra loro nel presentare la vetrina più ricca e ghiotta, dando sfogo
ad una fantasia senza limiti. Una descrizione particolareggiata di
queste mostre ci viene fornita da G.G. Belli: "Nelle
due sere del giovedì e venerdì santo i pizzicagnoli addobbano le
loro botteghe con una quantità tale di carni salate, di caci, ed
altre somiglianti delicature, che ne sono totalmente ricoperti le
pareti e i soffitti. Le varie forme e i diversi colori di simili
oggetti, stimolanti l’appetito di un popolo che si dovrebbe supporre
essersene astenuto per 46 giorni, vi sono calcolati e studiati
all’ornamento più o meno elegante in proporzione del genio
architettonico del pizzicagnolo. Inoltre, lontananze di uovi, con in
fondo specchiere per raddoppiarle, stellette di talchi: zampilletti
artificiali di acque: pesci natanti intorno ad uccelli rinchiusi gli
uni e gli altri in campane di doppia fodera: misteri della Passione
dipinti intorno a lanternoni di carta, bilicati, e aggirati dalle
correnti opposte di gas e d’aria atmosferica mercé un’interna
candela in combustione: finalmente, figure sacre e profane modellate
in burro, o, se è freddo, anche in distrutto di maiale, ecc. ecc.,
formano, all’uopo di copiosa illuminazione a più colori, un corredo
di pompa edificante che attrae un gran numero di divoti in giro di
visita, ciò che per le donne specialmente diviene una specie di
carnevaletto in quaresima".
E, ne "er
giro de le pizzicarie", eccone
una che colpì particolarmente il Belli: "De
le pizzicarie che tutte fanno / la su’ gran mostra pe Pasqua dell’Ova,
/ quella de Biacio a la Ritonna è st’anno / la più mejo de Roma che
se trova. / Colonne de caciotte, che saranno / cento a dì poco,
arreggeno un arcova / ricamata a sarcicce, e lì ce stanno / tanti
animali d’una forma nova. / Fra l’antri, in arto, c’è un Mosè de
strutto, / cor bastone per aria com’un sbirro / ,in cima a una
montagna de presciutto; / e sott’a lui, pe stuzzicà la fame, / c’è
un Cristo e una Madonna de butirro / drent’a una bella grotta de
salame".
Una
tradizione che perdurò a lungo, superando i primi anni del
Novecento, di cui ci fornisce una "gustosa" testimonianza Giggi
Zanazzo nelle sue "Tradizioni
Popolari Romane". Eccola: "Ne
le du’ sere der gioveddì e vennardi ssanto, li pizzicaroli romani
aùseno a ffa’ in de le bbotteghe la mostra de li caci, de li
preciutti, dell’òva e dde li salami. Certi ce metteno lo specchio pe’
ffa’ li sfonni, e ccert’antri cce fanno le grotte d’òva o dde
salami, co’ ddrento er sepporcro co’ li pupazzi fatti de bbutiro,
che sso’ ‘na bbellezza a vvedesse. E la ggente, in quela sera,
uscenno da la visita de li sepporcri, va in giro a rimirà’ le mostre
de li pizzicaroli de pòrso (facoltosi), che ffanno a ggara a cchi le
pò ffa’ mmejo".
Ma "l’urtimi
ggiorni de quaresima –
ricorda Zanazzo - se
faceva l’ottavario der catechisimo o le ccusì ddette Missione. Er
doppopranzo insinenta all’Avemmaria, tutti li negozzianti de Roma,
compresi l’osti, li trattori, li tabbaccari, l’orzaroli, eccetra,
chiudeveno le bbotteghe. E ognuno se n’annava a ppredica, indove la
quale er predicatore spiegava la dottrina pe’ ppreparà’ li cristiani
a ppijà’ la santa Pasqua. ".
Finalmente arrivava il giorno di Pasqua. Intorno alla tavola
imbandita, avvolta dalla tovaglia più bella con sopra piatti e
stoviglie splendenti, la famiglia riunita fremeva in attesa del
pranzo succulento. Scriveva ancora Belli: "Ècchecce
a Pasqua. Già lo vedi, Nino / la tavola è infiorata sana sana / d’erba-santa-maria,
menta romana, / sarvia, perza, viole e rosmarino./ Già so’ pronti
dall’antra sittimana / dieci fiaschetti e un bon baril de vino. /
Già, pe’ grazzia de Dio, fuma er cammino / pe’ celebbrà sta festa a
la cristiana. / Cristo è risusscitato; alegramente ! / In sta
giornata nun s’abbadi a spesa, / e nun se pensi a guai un accidente.
/ Brodetto, oca, salame, zuppa ingresa, / carciòfoli, granelli e ‘r
rimanente, / tutto a la grolia de la Santa Chiesa".
Le uova
sode, meglio conosciute come "toste", venivano dipinte di rosso e
offerte ai visitatori.
di Antonio Venditti |
|
SPECCHIO
ROMANO - SPECIALE PASQUA 2011 |
|
I romani ne apprezzavano le qualità alimentari e medicinali |
|
Il carciofo, dall’Egitto alle tavole di Pasqua
 Sulle
tavole imbandite per la Pasqua non dovrà mancare uno degli ortaggi
più gustosi della nostra tradizione culinaria, il carciofo,
rigorosamente romanesco, grosso e tondeggiante, e preferibilmente
cimarolo, ossia proprio il capolino centrale di ogni pianta, il più
ricercato ma anche il più costoso. Osservandone attentamente la
forma, infatti, si capisce subito che non si tratta di un frutto, ma
di un’infiorescenza. La definizione botanica di Cynara Scolymus
richiama il mito della bella e sfortunata ninfa Cynara, dai lunghi
capelli color cenere, di cui si era invaghito Giove. Avendo osato
respingere il nume, la fanciulla fu trasformata in una pianta,
spinosa e pungente, come suggerisce l’aggettivo greco scolymos. Il
nome attuale, invece, deriva dal termine arabo harsciof, o
al-kharshuf, che significa spina di terra e pianta che punge.
Secondo alcuni l’ortaggio era già conosciuto e apprezzato dagli
egiziani, che lo avrebbero conosciuto dagli etiopi. Sulle
tavole imbandite per la Pasqua non dovrà mancare uno degli ortaggi
più gustosi della nostra tradizione culinaria, il carciofo,
rigorosamente romanesco, grosso e tondeggiante, e preferibilmente
cimarolo, ossia proprio il capolino centrale di ogni pianta, il più
ricercato ma anche il più costoso. Osservandone attentamente la
forma, infatti, si capisce subito che non si tratta di un frutto, ma
di un’infiorescenza. La definizione botanica di Cynara Scolymus
richiama il mito della bella e sfortunata ninfa Cynara, dai lunghi
capelli color cenere, di cui si era invaghito Giove. Avendo osato
respingere il nume, la fanciulla fu trasformata in una pianta,
spinosa e pungente, come suggerisce l’aggettivo greco scolymos. Il
nome attuale, invece, deriva dal termine arabo harsciof, o
al-kharshuf, che significa spina di terra e pianta che punge.
Secondo alcuni l’ortaggio era già conosciuto e apprezzato dagli
egiziani, che lo avrebbero conosciuto dagli etiopi.
Certamente i romani ne facevano largo uso, come
testimoniano Plinio il Vecchio e Columella, che nel suo "De Re
Rustica" ne conferma la coltivazione sia a scopo alimentare che
medicinale. Il carciofo, infatti, diuretico e leggermente lassativo,
stimola le funzioni epatiche, esercitando un’azione benefica nelle
forme itteriche. E’ inoltre antinfiammatorio e antipruriginoso.
Secondo Apicio, il raffinato gastronomo del I
secolo d.C., i carciofi si potevano mangiare conditi con la solita
salsa di pesce, olio e fettine di uova sode. Oppure, si dovevano
ricoprire con un trito di erbe aromatiche fresche: ruta, menta,
coriandro e finocchio, aggiungendo poi pepe, ligustico, miele, salsa
di pesce e olio. In un’ultima ricetta i carciofi, sempre prima
lessati, sono insaporiti con pepe, comino, salsa di pesce e olio.
Nel Medioevo il carciofo sembra fosse caduto
nell’oblio, anche se la mancata citazione nelle fonti letterarie non
ne fa escludere del tutto l’uso. In ogni caso, con il Rinascimento
anche il saporito ortaggio conobbe una sua seconda vita. Un’ampia e
dettagliata letteratura ne registra la coltivazione in varie regioni
italiane. Pietro Mattioli, famoso medico senese vissuto nel XVI
secolo, scriveva nel suo trattato sulle piante medicinali: "veggonsi
ai giorni nostri in Italia carcioffi di diverse sorti: spinosi, sia
serrati che aperti, non spinosi, rotondi, lunghi, aperti e chiusi, e
di quelli che rassemblano alle pine dei pini".
d i
Annalisa Venditti |
|
SPECCHIO
ROMANO - SPECIALE PASQUA 2011 |
| |
|
LE CIAMBELLE CRESCIUTE, PER
UNA VITA PIÙ DOLCE
 Dolci
e fragranti, da mettere assolutamente sulla tavola di Pasqua ma
adatte a qualsiasi periodo dell’anno: sono le ciambelle cresciute,
diffusissime in Ciociaria, ma entrate a far parte della tradizione
culinaria romana. La preparazione è molto semplice, occorre solo
armarsi di un po’ di pazienza per la lievitazione della pasta. Per
fare un bel vassoio di ciambelle occorrono 6 uova, un bicchiere di
olio e uno di latte, una grattata di limone, un quadruccio di
lievito di birra e circa un chilo e mezzo di farina. Si fa
intiepidire il latte e vi si scioglie il lievito, che poi si
aggiunge in una bacinella a tutti gli altri ingredienti. Si può
anche unire una manciata di uva sultanina ammollata e strizzata. Si
lavora ben bene l’impasto, fino a che si stacca dalle mani,
aggiungendo, se occorre, altra farina. Ora non resta che coprire la
bacinella con un canovaccio e metterla nel luogo più caldo della
casa, lontana dalle correnti d’aria. Se fa troppo freddo, si può
scaldare leggermente il forno, poi spegnerlo e metterla dentro. Il
tempo della lievitazione varia a seconda della temperatura e delle
condizioni meteorologiche, da un paio d’ore a un’intera notte. In
ogni caso, il volume dell’impasto deve raddoppiare. A questo punto,
si ricavano le ciambelle prendendo una pallina d’impasto, bucandola
al centro e allargandola, quindi si dispongono sulle teglie foderate
con la carta da forno. Si spennellano con il rosso d’uovo battuto e
si lasciano riposare per un altro paio d’ore, finché la superficie
non sarà bella tesa e omogenea. Si mettono nel forno ben caldo e si
fanno cuocere a 180 gradi per una decina di minuti, facendo
attenzione che non brucino sotto. Appena sono belle dorate si
tolgono dal forno. Dolci
e fragranti, da mettere assolutamente sulla tavola di Pasqua ma
adatte a qualsiasi periodo dell’anno: sono le ciambelle cresciute,
diffusissime in Ciociaria, ma entrate a far parte della tradizione
culinaria romana. La preparazione è molto semplice, occorre solo
armarsi di un po’ di pazienza per la lievitazione della pasta. Per
fare un bel vassoio di ciambelle occorrono 6 uova, un bicchiere di
olio e uno di latte, una grattata di limone, un quadruccio di
lievito di birra e circa un chilo e mezzo di farina. Si fa
intiepidire il latte e vi si scioglie il lievito, che poi si
aggiunge in una bacinella a tutti gli altri ingredienti. Si può
anche unire una manciata di uva sultanina ammollata e strizzata. Si
lavora ben bene l’impasto, fino a che si stacca dalle mani,
aggiungendo, se occorre, altra farina. Ora non resta che coprire la
bacinella con un canovaccio e metterla nel luogo più caldo della
casa, lontana dalle correnti d’aria. Se fa troppo freddo, si può
scaldare leggermente il forno, poi spegnerlo e metterla dentro. Il
tempo della lievitazione varia a seconda della temperatura e delle
condizioni meteorologiche, da un paio d’ore a un’intera notte. In
ogni caso, il volume dell’impasto deve raddoppiare. A questo punto,
si ricavano le ciambelle prendendo una pallina d’impasto, bucandola
al centro e allargandola, quindi si dispongono sulle teglie foderate
con la carta da forno. Si spennellano con il rosso d’uovo battuto e
si lasciano riposare per un altro paio d’ore, finché la superficie
non sarà bella tesa e omogenea. Si mettono nel forno ben caldo e si
fanno cuocere a 180 gradi per una decina di minuti, facendo
attenzione che non brucino sotto. Appena sono belle dorate si
tolgono dal forno.
di Cinzia
Dal Maso |
|
SPECCHIO
ROMANO - SPECIALE PASQUA 2011 |
|
Una storia millenaria per la dolce colomba
pasquale |
|
Un simbolo di pace
sulle tavole in festa
 Artigianale,
confezionata, mandorlata, con o senza canditi, farcita dalle creme
più gustose: è la colomba, il soffice dolce della mensa pasquale.
Sulle tavole imbandite a festa porta con sé il retaggio di una
storia millenaria che si perde nella notte dei tempi e rinasce nel
messaggio cristiano della morte e resurrezione di Gesù Cristo. Già
nell’antica Grecia le colombe si veneravano come uccelli sacri alla
dea dell’amore Afrodite e del suo sfortunato amante, Adone. I
Romani, che alla divinità avevano dato il nome di Venere, si
cibavano delle uova di colomba pensando che predisponessero alle
fantasie e ai piaceri dell’amore. Secondo la medicina antica, le
pacifiche colombe non producevano bile. Per gli egiziani e i cinesi
il loro grande senso dell’orientamento permetteva di impiegarle
nella consegna di messaggi: le colombe tornavano sempre al loro
nido. Artigianale,
confezionata, mandorlata, con o senza canditi, farcita dalle creme
più gustose: è la colomba, il soffice dolce della mensa pasquale.
Sulle tavole imbandite a festa porta con sé il retaggio di una
storia millenaria che si perde nella notte dei tempi e rinasce nel
messaggio cristiano della morte e resurrezione di Gesù Cristo. Già
nell’antica Grecia le colombe si veneravano come uccelli sacri alla
dea dell’amore Afrodite e del suo sfortunato amante, Adone. I
Romani, che alla divinità avevano dato il nome di Venere, si
cibavano delle uova di colomba pensando che predisponessero alle
fantasie e ai piaceri dell’amore. Secondo la medicina antica, le
pacifiche colombe non producevano bile. Per gli egiziani e i cinesi
il loro grande senso dell’orientamento permetteva di impiegarle
nella consegna di messaggi: le colombe tornavano sempre al loro
nido.
Nella Bibbia la colomba, messaggera di
pace, annuncia la fine del diluvio universale consegnando a Noè un
ramoscello d’olivo. Lo Spirito Santo è rappresentato spesso da
questa amabile creatura: così nel Battesimo di Gesù nel Giordano e
nell’Annunciazione a Maria Vergine.
Il "Phisiologus", una raccolta in
greco composta ad Alessandria d’Egitto nel II d. C., riporta
interpretazioni allegoriche e morali di diversi animali (ottima
l’edizione di Giulio Einaudi Editore curata da Luigina Morini). A
proposito della colomba è scritto: "ne esistono di molti e diversi
colori. C’è il colore screziato, nero, bianco, rosso, giallo-oro,
celeste, cinerino, dorato, miele. Ma sopra tutte primeggia la
colomba rossa, che tutte le governa e pacifica, e ogni giorno
riunisce nella sua colombaia anche le colombe selvatiche. E’ colui
che ci redense con il suo prezioso sangue e radunò noi da popoli
diversi nell'unica casa della Chiesa".
Spiegando l’etimologia della parola,
il "Phisiologus", testo che può essere considerato "padre" di tutti
i Bestiari medievali, precisa che "la colomba selvatica viene
chiamata uccello casto per i suoi costumi. Infatti si dice che una
volta rimasta vedova se ne stia solitaria e non ricerchi più
l’accoppiamento fisico".
All’interno di una profonda metafora,
carica di significati, spiega che "in India c’è un albero
ambidestro, il cui frutto è straordinariamente dolce e assai
gradevole. Le colombe amano molto le attrattive di questo albero,
perché si ristorano con i suoi frutti e si riposano sotto la sua
ombra e sono protette dai suoi rami. C’è infatti un drago crudele
nemico delle colombe, e quanto le colombe temono il drago e lo
fuggono, altrettanto il drago evita e teme molto l’albero, tanto che
non osa avvicinarsi neppure alla sua ombra. Se l’ombra dell’albero è
a destra, egli si sposta a sinistra, se invece l’ombra dell’albero è
a sinistra, si sposta fuggendo a destra: le colombe, sapendo che il
loro nemico drago teme l’albero e la sua ombra e non può
avvicinarsi, fuggono sull’albero e gli si affidano per salvarsi
dalle insidie del loro avversario, Infatti finché sono su
quell’albero e si trattengono lì, il drago non può prenderle in
nessun modo. Se invece ne trova qualcuna lontana anche di poco
dall’albero o fuori della sua ombra, subito la ghermisce e divora".
Nell’allegoria cristiana la colomba rappresenta dunque il Cristo
salvatore e la schiera di fedeli che, tentati dal male, devono
rifugiarsi tra le braccia della Chiesa.
Così nel giorno di Pasqua, in cui si
celebra il mistero della Resurrezione, un dolce ne rinnova la
salvifica promessa. Ma all’esegesi biblica si affiancano le credenze
popolari. Secondo una leggenda pavese, nel 572 una soffice colomba
pasquale venne offerta al re longobardo Alboino, mentre riceveva
l’omaggio della cittadinanza conquistata, da un astuto vecchio che
in cambio del dono strappò al sovrano l’incauta promessa di
"rispettare sempre le colombe". Quando al cospetto di Alboino si
presentarono dodici belle fanciulle che dissero in coro di chiamarsi
Colomba, il Longobardo - per mantener fede alla parola data -
dovette rinunciare a qualsiasi proposito su di loro. Un dolce
stratagemma aveva salvato l’onore delle giovani pavesi.
di Annalisa Venditti |
|
SPECCHIO
ROMANO - SPECIALE PASQUA 2011 |
|