
|
E’ stato trasferito
nel Parco del Gianicolo |
|
Il
monumento a Ciceruacchio
 "La
memoria di lui vivrà eterna quanto il tempo. Roma, l'Italia, lo
venereranno quale Martire; e siamo certi che quando sul Campidoglio
sventolerà il tricolore vessillo e saranno infugati dal Vaticano i
tristi corvi, Roma, decretando onore di epigrafi e di monumenti ai
suoi Martiri, inciderà i nomi loro sulla pietra, e in cima a que'
nomi sarà quello di Angelo Brunetti detto Ciceruacchio". Così Felice
Venosta, nel 1863, concludeva il suo libro dedicato all’eroe
trasteverino, fucilato insieme con i suoi figli a Ca’ Tiepolo, la
notte tra il 10 e l’11 agosto 1849, durante la lunga marcia di
Garibaldi in direzione di Venezia, dopo la caduta della Repubblica
Romana. "La
memoria di lui vivrà eterna quanto il tempo. Roma, l'Italia, lo
venereranno quale Martire; e siamo certi che quando sul Campidoglio
sventolerà il tricolore vessillo e saranno infugati dal Vaticano i
tristi corvi, Roma, decretando onore di epigrafi e di monumenti ai
suoi Martiri, inciderà i nomi loro sulla pietra, e in cima a que'
nomi sarà quello di Angelo Brunetti detto Ciceruacchio". Così Felice
Venosta, nel 1863, concludeva il suo libro dedicato all’eroe
trasteverino, fucilato insieme con i suoi figli a Ca’ Tiepolo, la
notte tra il 10 e l’11 agosto 1849, durante la lunga marcia di
Garibaldi in direzione di Venezia, dopo la caduta della Repubblica
Romana.
Bisognò
aspettare il centenario della nascita di Garibaldi, il 1892, perché
un comitato popolare, di cui era presidente Salvatore Barzilai e di
cui facevano parte Luigi Cesana, direttore de "Il Messaggero", e lo
scultore Ferrari, inoltrasse la richiesta di un monumento all’eroe.
Fu aperta una sottoscrizione e distribuito un foglio nel quale era
scritto che il monumento avrebbe dovuto "glorificare l’anima
popolare, espressa dall’eroismo di Ciceruacchio, il quale, dopo aver
diffuso le idee liberali in mezzo al popolo romano, cadde vittima
della doppiezza politica di Pio IX".
L’esecuzione dell’opera in bronzo fu affidata allo scultore
siciliano Ettore Ximenes, che ne aveva già presentato il progetto
con notevole successo all’esposizione di Torino del 1880. La solenne
inaugurazione del monumento, collocato sul lungotevere Arnaldo da
Brescia, presso il ponte Margherita, avvenne il pomeriggio del 3
novembre 1907. Appena cadde il telo che copriva il gruppo scultoreo,
la folla rimase con il fiato sospeso a contemplare la figura
imponente e fiera di Angelo Brunetti, che, guardando in faccia il
nemico, si scopriva il petto, indicando di mirare al cuore. Ai suoi
piedi il figlio Lorenzo, in ginocchio e bendato, con la bocca
spalancata in un grido. Dal monumento fu escluso l’altro figlio,
Luigi, con un atto giudicato da Aldo Lombardi "antistorico ed
inumano". Ma Luigi Brunetti era un personaggio scomodo: su di lui
gravava il sospetto di essere stato l’esecutore materiale
dell’assassinio di Pellegrino Rossi, ministro dell’Interno del
governo pontificio, accoltellato il 15 novembre del 1848 nel palazzo
della Cancelleria.
Nel
1959, in occasione dell’apertura del sottovia del lungotevere
Arnaldo da Brescia, il monumento fu spostato di non molto, sul
lungotevere in Augusta, dove però i rami di due platani ne
ostacolavano la visibilità e il passaggio continuo delle macchine ne
compromettevano la conservazione. Ora sembra aver trovato una sede
degna e definitiva. La scorsa settimana, in occasione delle
celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è stato
trasferito nel parco del Gianicolo, luogo simbolo del Risorgimento
romano, poco prima del cancello che dà su Porta San Pancrazio.
di
Cinzia Dal
Maso
|
|
Fu inaugurata per il centenario
della Repubblica Romana |
|
La statua di Mazzini
attesa per molti anni
Il Fascismo
ostacolò decisamente la realizzazione del monumento perché opera del
Gran Maestro della Massoneria italiana, Ettore Ferrari
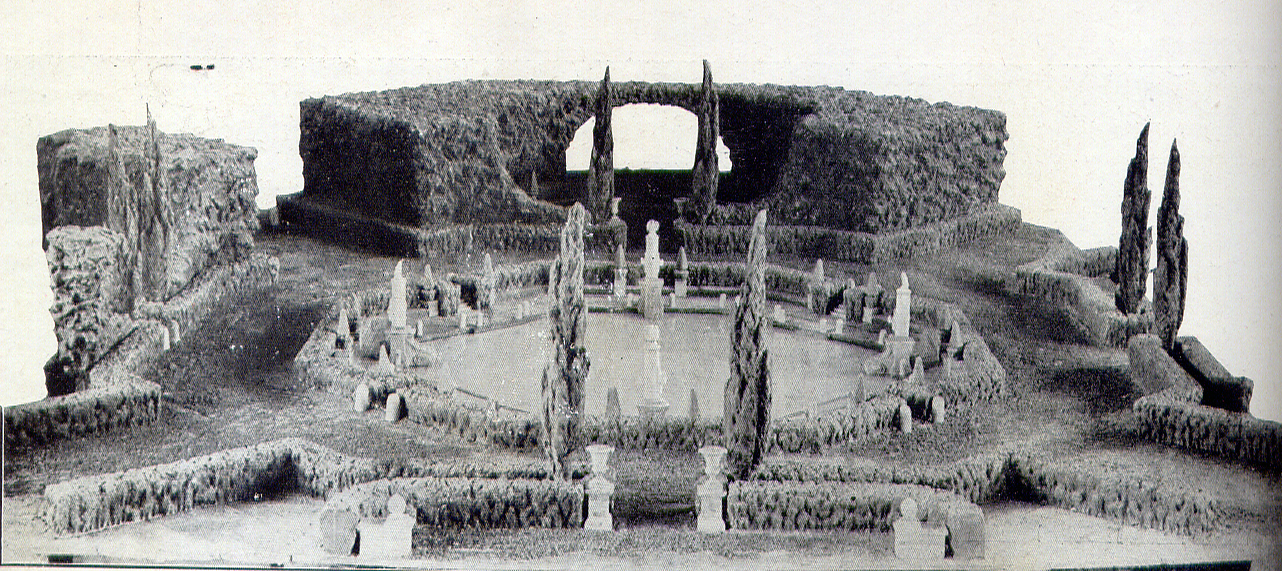 Nel
1880 il Governo italiano, presieduto da Francesco Crispi, decise di
erigere un monumento a Giuseppe Mazzini. Fu redatto un disegno di
legge, che venne dibattuto tra animate discussioni. Crispi voleva
che Mazzini fosse celebrato come sostenitore dell’Unità nazionale,
mentre i deputati dell’estrema sinistra chiedevano di mettere in
luce anche il credo repubblicano del fondatore della Giovane Italia.
Nel
luglio dello stesso anno venne nominata una specifica Commissione,
ma si dovette attendere il 1902 per incaricare dell’esecuzione del
monumento Ettore Ferrari (1845-1929), già autore della statua di
Giordano Bruno in piazza Campo de’ Fiori, che presentò subito un
progetto, approvato nel mese di maggio. Nel 1905 erano pronti anche
i bozzetti, ispirati alla forza del pensiero mazziniano, trasposta
in una rappresentazione continua, di tono eroico, con riferimenti ad
opere emblematiche del romanticismo. Il progetto, più complesso
rispetto ad altri monumenti dedicati alla celebrazione di uomini
illustri del Risorgimento, è stato in linea di massima rispettato.
Il monumento risulta composto da una statua in bronzo di Mazzini,
seduto in atteggiamento pensoso, posta al di sopra di un alto
basamento ornato da un fregio allegorico ad alto e altissimo
rilievo, con le figurazioni dell'idea Mazziniana: l'aspirazione alla
libertà che si concretizza nella Giovane Italia, il sacrificio per
la redenzione degli oppressi dalla tirannide, la lotta contro il
dispotismo, il turbine trionfale della rivoluzione e la
ricomposizione delle spoglie dei martiri. Nella parte posteriore,
sono effigiati all’interno di medaglioni alcuni promotori
dell’indipendenza italiana: Goffredo Mameli, Carlo Pisacane, Aurelio
Saffi, Maurizio Quadrio, Alberto Mario, Rosolino Pilo e Adriano
Lemmi. Non mancano chiari riferimenti alla Massoneria, di cui
Ferrari fu Gran Maestro dal 1904 al 1917. Tra le figure scolpite si
nota quella di un uomo dall’ampio grembiule di cuoio, cui una donna,
personificazione della Virtù, porge un martello e uno scalpello. Il
basamento in marmo bianco, rettangolare nella parte anteriore e
preceduto da un’ara, diventa semicircolare sul retro per recingere
un sacro boschetto. Non venne realizzato il tempietto dorico che
avrebbe dovuto contenere la statua di Mazzini, perché escluso dal
progetto nel 1911 dallo stesso Ferrari.
L’artista fu impegnato quasi trent’anni nella realizzazione
dell’opera, durante i quali non riuscì a saperne con certezza
nemmeno la collocazione definitiva. Probabilmente il maggiore
ostacolo alla realizzazione del monumento, che divenne
insormontabile durante il periodo fascista, fu proprio la nota
appartenenza del Ferrari alla Massoneria.
L’artista moriva nel 1929, lasciando le parti scultoree,
praticamente ultimate, nel giardino della propria abitazione; anche
la statua in bronzo era stata fusa e si trovava a Napoli, presso la
fonderia Laganà.
Solo
dopo la seconda Guerra Mondiale, nel 1948, venne presa la ferma
decisione di sistemare il monumento proprio nel luogo suggerito dal
Ferrari, alle pendici dell’Aventino, sul piazzale Romolo e Remo,
oggi dedicato a Ugo La Malfa, al centro di una vasta esedra,
interrotta da via di Valle Murcia e via delle Terme Deciane e
delimitata da un lungo sedile in travertino.
Per
mantenere la fedeltà al progetto originario, fu chiesta la
collaborazione del figlio dell’artista, Gian Giacomo Ferrari, che a
sua volta si fece aiutare dallo scultore Ettore Guastalla nella
ricomposizione delle parti scultoree.
Il
monumento venne finalmente inaugurato il 2 giugno 1949, in occasione
del centenario della Repubblica Romana.
Tra il
settembre del 1999 e il marzo del 2000, il monumento a Giuseppe
Mazzini è stato sottoposto a un radicale intervento di restauro per
sanare i danni causati dalla prolungata esposizione agli agenti
atmosferici e da atti vandalici. Per quanto riguarda questi ultimi,
alcune delle figure a tutto tondo risultavano prive di dita, mani e
in alcuni casi, persino della testa. Inoltre, alcune scritte a
vernice e pennarello imbrattavano la statua di bronzo, il marmo e il
travertino del basamento e dei sedili.
di Antonio Venditti |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
|
E’ OPERA
DI MARIO RUTELLI, FAMOSO PER LA FONTANA DELLE NAIADI |
|
IL
MONUMENTO EQUESTRE
DI ANITA GARIBALDI
 Nel
1932 l’Italia fascista commemorò con una lunga serie di eventi il
cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi. Al Palazzo delle
Esposizioni fu allestita una prestigiosa mostra garibaldina, mentre
furono pubblicati gli scritti dell’Eroe dei Due Mondi. Nel
1932 l’Italia fascista commemorò con una lunga serie di eventi il
cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi. Al Palazzo delle
Esposizioni fu allestita una prestigiosa mostra garibaldina, mentre
furono pubblicati gli scritti dell’Eroe dei Due Mondi.
Le manifestazioni più importanti si svolsero
però a giugno. Il primo del mese ci fu il trasferimento a Roma dei
resti di Ana Maria De Jesus Ribeiro, meglio conosciuta come Anita,
inseparabile compagna di Garibaldi. Il giorno seguente i resti
furono tumulati in un loculo ai piedi del monumento eretto in sua
memoria sul Gianicolo. Il 4 giugno, alla presenza di un foltissimo
pubblico, delle autorità, di Vittorio Emanuele III, della regina
Elena in veste di madrina e di Benito Mussolini, il monumento fu
inaugurato, come testimonia un filmato dell’Istituto Luce.
Anita era nata in Brasile, nei pressi di
Laguna, Stato di Santa Caterina. Non se ne conosce la data di
nascita precisa, anche se la sua città le ha attribuito quella del
30 agosto 1821. Era già sposata con Manuel Duarte de Aguiar quando
incontrò Giuseppe Garibaldi nell'agosto del 1839 a Laguna. Lui se ne
innamorò perdutamente e fu ben presto ricambiato: già nell'ottobre
Anita era imbarcata su una nave con l’eroe e da allora per dieci
anni condivise l’inquieta e pericolosa vita di Garibaldi.
"Non meno fervida di me – la descriveva l'eroe
- per la sacrosanta causa dei popoli e per una vita avventurosa".
Nel 1842, dal momento che Manuel Duarte era morto, i due si poterono
sposare a Montevideo.
Nel 1847 Anita si imbarcò per l’Italia con i
figli Menotti, Teresita e Ricciotti. Il marito la seguì nell'ottobre
1848. Quando Garibaldi si recò alla difesa di Roma, non volle
portare con sé la donna per non farle correre troppi pericoli,
nonostante le sue proteste. Anita lo raggiunse solo a giugno, pochi
giorni prima che la Repubblica cadesse. Quando il 2 luglio 1849
Garibaldi abbandonò Roma, Anita era sofferente e al quarto mese di
gravidanza. La drammatica ritirata, i pericoli e le privazioni
d'ogni genere compromisero le condizioni della giovane donna, che
fu portata, allo stremo delle forze, nella fattoria Guiccioli, nei
pressi di Ravenna, dove spirò il 4 agosto del 1849. Garibaldi,
braccato dagli Austriaci, dovette lasciarla lì e venne tumulata
presso la chiesa delle Mandriole. Solo al ritorno dell’esilio, nel
1859, l’Eroe tornerà a prendere i suoi resti mortali per seppellirla
vicino alla madre, a Nizza. Finalmente nel 1932 Anita avrebbe potuto
riposare nel suo monumento sul Gianicolo, opera di Mario Rutelli,
sormontata dal dinamico bronzo (oggi puntellato per un leggero
cedimento) in cui la donna è raffigurata a cavallo, con i lunghi
capelli sciolti, mentre stringe al seno uno dei suoi figli, il
piccolo Menotti, e punta in alto una pistola. Il cavallo rampante e
l’espressione guerriera assimilano Anita a una moderna Amazzone. Lo
scultore raffigurò uno degli episodi della vita di Anita, avvenuto
nel 1840 presso San Simon (Rio Grande). La donna aveva appena
partorito in una casa di amici e Garibaldi l’aveva dovuta lasciare
per cercare delle vesti per lei e per il neonato. Nel frattempo, le
truppe imperiali si erano spinte fino a San Simon spargendo ovunque
il terrore. Anita, vestita della sola camicia, aveva preso tra le
braccia il figlio e, armata di pistola, aveva affrontato una furiosa
cavalcata notturna tra boschi e burroni, mettendosi in salvo.
Garibaldi, dopo averla cercata inutilmente nella casa, la ritrovò
nella foresta mente allattava tranquillamente il piccolo. Sulla base
del monumento, alcuni bassorilievi in bronzo rievocano altri episodi
della breve ma movimentata vita di Anita. che
fu portata, allo stremo delle forze, nella fattoria Guiccioli, nei
pressi di Ravenna, dove spirò il 4 agosto del 1849. Garibaldi,
braccato dagli Austriaci, dovette lasciarla lì e venne tumulata
presso la chiesa delle Mandriole. Solo al ritorno dell’esilio, nel
1859, l’Eroe tornerà a prendere i suoi resti mortali per seppellirla
vicino alla madre, a Nizza. Finalmente nel 1932 Anita avrebbe potuto
riposare nel suo monumento sul Gianicolo, opera di Mario Rutelli,
sormontata dal dinamico bronzo (oggi puntellato per un leggero
cedimento) in cui la donna è raffigurata a cavallo, con i lunghi
capelli sciolti, mentre stringe al seno uno dei suoi figli, il
piccolo Menotti, e punta in alto una pistola. Il cavallo rampante e
l’espressione guerriera assimilano Anita a una moderna Amazzone. Lo
scultore raffigurò uno degli episodi della vita di Anita, avvenuto
nel 1840 presso San Simon (Rio Grande). La donna aveva appena
partorito in una casa di amici e Garibaldi l’aveva dovuta lasciare
per cercare delle vesti per lei e per il neonato. Nel frattempo, le
truppe imperiali si erano spinte fino a San Simon spargendo ovunque
il terrore. Anita, vestita della sola camicia, aveva preso tra le
braccia il figlio e, armata di pistola, aveva affrontato una furiosa
cavalcata notturna tra boschi e burroni, mettendosi in salvo.
Garibaldi, dopo averla cercata inutilmente nella casa, la ritrovò
nella foresta mente allattava tranquillamente il piccolo. Sulla base
del monumento, alcuni bassorilievi in bronzo rievocano altri episodi
della breve ma movimentata vita di Anita.
Lo scultore Mario Rutelli era nato a Palermo il
4 aprile del 1859 e morì a Roma il 4 novembre del 1841. Fece i suoi
studi artistici all’Accademia di Palermo e li completò nella
capitale presso Giulio Monteverde. La sua opera più celebre e
discussa è la Fontana delle Naiadi in piazza della Repubblica a
Roma. Famosa anche la quadriga di bronzo sul teatro Politeama di
Palermo. Altre opere romane di Mario Rutelli sono una delle
quadrighe sul Vittoriano e il monumento a Nicola Spedalieri in
piazza Sforza Cesarini, vicino alla Chiesa Nuova.
Dell’argomento si parlerà a Nuova Spazio Radio
(88.100 MHz), a "Questa è Roma", il programma ideato e
condotto da Maria Pia Partisani, in studio con Livia Ventimiglia il
martedì dalle 14 alle 15 e in replica il sabato dalle 10 alle 11.
di Cinzia
Dal Maso |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
|
FU
COSTRUITO GRAZIE AGLI ITALIANI EMIGRATI IN ARGENTINA |
|
IL
FARO TRICOLORE DEL GIANICOLO

Nelle ricorrenze nazionali, potenti fasci di luce tricolori
illuminano le notti romane: vengono dal Faro del Gianicolo,
elevato nel 1911, in occasione del primo cinquantenario
della creazione del Regno d’Italia, grazie ai fondi raccolti
dagli Italiani emigrati in Argentina. Il luogo in cui è
stato collocato, oltre a essere molto elevato, ha anche un
significato simbolico per essere stato teatro degli scontri
per la difesa della Repubblica romana del 1849.
Il Faro è opera dell’architetto
piacentino Manfredo Manfredi (1859 – 1927), che realizzò
anche la tomba di Vittorio Emanuele II all’interno del
Pantheon, il progetto del palazzo del Viminale, e contribuì
a portare a termine il Vittoriano.
Realizzato in pietra bianca di
Botticino, è alto 20 metri e si ispira alle forme dell’arte
classica.
Su una base circolare con diametro di
dieci metri si innalza una tozza colonna sovrastata da un
capitello su cui corre la dedica: "A ROMA CAPITALE GLI
ITALIANI D’ARGENTINA. MCMXI". Sopra al capitello è una sorta
di ara circolare ornata da quattro erme con protomi leonine,
collegate da festoni. Sopra a tutto, la lanterna,
raggiungibile attraverso la scala a chiocciola che conduce
al capitello e poi attraverso una scala a pioli di ferro.
Nella base del Faro sono stati ricavati tre locali: l’atrio
di ingresso alla scala e due ambienti di servizio e
deposito, situati nello spazio circolare che corre intorno
alla scala.
La balconata del Faro, che guarda verso
il carcere di Regina Coeli, a cui è molto vicina in linea
d’aria, era utilizzata fino a qualche tempo fa dai familiari
dei detenuti per comunicare con i loro parenti: una pratica
in effetti vietata, ma tollerata dalle forze dell’ordine,
purché i messaggi riguardassero esclusivamente notizie
importanti e urgenti.
di Annalisa
Venditti |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
|
EDIFICATA DA
AURELIANO, TRASFORMATA DA URBANO VIII E RIFATTA DA PIO IX |
|
Porta S. Pancrazio
attraverso i secoli
 La
cinta muraria voluta nel III secolo dall’imperatore Aureliano
racchiudeva anche buona parte del Trastevere in una sorta di grande
triangolo con il vertice meridionale sul Gianicolo, dove si apriva
la porta Aurelia, per far uscire la via omonima. Per la vicinanza
con il sepolcro, le catacombe e poi la chiesa di San Pancrazio, fin
dal V secolo prese il nome di porta San Pancrazio. Nelle sue
vicinanze, allo sbocco dell’Acquedotto di Traiano, si trovavano i
mulini pubblici, rimasti in funzione fino al tardo medioevo. Almeno
fino al XV secolo, si usava concedere in appalto o in vendita a
privati le porte cittadine, per la riscossione del pedaggio sul
transito. Un documento dell’Archivio vaticano del 1474 rende noto
che in quell’epoca la rata semestrale da pagare per l’appalto di
porta San Pancrazio era di 25 fiorini: una somma piuttosto modesta,
cui doveva corrispondere un altrettanto modesto traffico in entrata
e uscita da quella porta. La
cinta muraria voluta nel III secolo dall’imperatore Aureliano
racchiudeva anche buona parte del Trastevere in una sorta di grande
triangolo con il vertice meridionale sul Gianicolo, dove si apriva
la porta Aurelia, per far uscire la via omonima. Per la vicinanza
con il sepolcro, le catacombe e poi la chiesa di San Pancrazio, fin
dal V secolo prese il nome di porta San Pancrazio. Nelle sue
vicinanze, allo sbocco dell’Acquedotto di Traiano, si trovavano i
mulini pubblici, rimasti in funzione fino al tardo medioevo. Almeno
fino al XV secolo, si usava concedere in appalto o in vendita a
privati le porte cittadine, per la riscossione del pedaggio sul
transito. Un documento dell’Archivio vaticano del 1474 rende noto
che in quell’epoca la rata semestrale da pagare per l’appalto di
porta San Pancrazio era di 25 fiorini: una somma piuttosto modesta,
cui doveva corrispondere un altrettanto modesto traffico in entrata
e uscita da quella porta.
Non
sappiamo di preciso quale fosse la sua forma originaria. La pianta
di Roma del Maggi del 1625 ce la mostra a un solo fornice affiancato
da due torri, ma evidenzia anche il pessimo stato di conservazione
di quel tratto di mura. Difatti, la porta fu quasi del tutto
ricostruita qualche anno dopo, sotto il pontificato di Urbano VIII
(1623-44), da Mattia de’ Rossi, discepolo di Gian Lorenzo Bernini,
che conservò solo la controporta merlata, riconoscibile ancora nelle
incisioni del Rossini del 1829.
Nel
1849 il Gianicolo fu teatro della drammatica difesa della Repubblica
Romana dagli assalti delle truppe francesi del generale Oudinot. Il
13 giugno i cannoni francesi aprirono nella porta una grossa
breccia. Tra coloro che accorsero a difenderla c’era la giovane
Colomba Antonietti, che combatteva accanto al marito travestita da
uomo e morì per una palla di cannone che la colpì di rimbalzo.
La
porta venne presa nuovamente di mira il 21 giugno, quando i francesi
iniziarono a sparare da distanza ravvicinata contro i suoi bastioni,
aprendovi tre brecce. Il 24 giugno nell’assalto alle mura presso la
porta uno dei primi a soccombere, ferito a morte, fu il
diciassettenne Emilio Morosini. Quando la repubblica cadde, insieme
con le speranze dei patrioti, nemmeno della porta restava molto in
piedi.
Restaurato il governo pontificio, Pio IX incaricò della sua
ricostruzione l’architetto Virginio Vespignani (1808 – 82), che la
edificò nel 1854 nelle sobrie e solenni forme attuali. Sull’attico
un’iscrizione latina in cui si
legge: PORTAM PRAESIDIO URBIS IN IANICULO VERTICE / AB URBANO VIII
PONT. MAX. EXTRUCTAM COMMUNITAM / BELLI IMPETU AN. CHRIST. MDCCCLIV
DISIECTAM / PIUS IX PONT. MAXIMUS / TABERNA PRAESIDIARIS EXCEPIENDIS
/ DIAETA VECTIGALIBUS EXIGENDIS / RESTITUIT / ANNO DOMINI MDCCCLIV
PONTIFICATUS VIII / ANGELI GALLI EQ TORQUATO PRAEFECTO AERARII
CURATORI. La sua traduzione suona così: "Pio IX Pontefice Maximo
nell'anno 1854, settimo del suo pontificato, ricostruì, come dimora
per i soldati del presidio e come padiglione per esigere le gabelle,
la porta fortificata costruita a presidio della città sulla sommità
del Gianicolo dal Pontefice Maximo Urbano VIII, distrutta
dall'impeto della guerra nel 1854, a cura di A. G. Torquato prefetto
dell'erario". si
legge: PORTAM PRAESIDIO URBIS IN IANICULO VERTICE / AB URBANO VIII
PONT. MAX. EXTRUCTAM COMMUNITAM / BELLI IMPETU AN. CHRIST. MDCCCLIV
DISIECTAM / PIUS IX PONT. MAXIMUS / TABERNA PRAESIDIARIS EXCEPIENDIS
/ DIAETA VECTIGALIBUS EXIGENDIS / RESTITUIT / ANNO DOMINI MDCCCLIV
PONTIFICATUS VIII / ANGELI GALLI EQ TORQUATO PRAEFECTO AERARII
CURATORI. La sua traduzione suona così: "Pio IX Pontefice Maximo
nell'anno 1854, settimo del suo pontificato, ricostruì, come dimora
per i soldati del presidio e come padiglione per esigere le gabelle,
la porta fortificata costruita a presidio della città sulla sommità
del Gianicolo dal Pontefice Maximo Urbano VIII, distrutta
dall'impeto della guerra nel 1854, a cura di A. G. Torquato prefetto
dell'erario".
La
porta tornò alla ribalta delle cronache il 20 settembre del 1870,
quando vi penetrarono le truppe del generale Bixio, in contemporanea
ai bersaglieri che aprirono la breccia di Porta Pia.
Attualmente nella porta hanno sede l’Associazione Nazionale Veterani
e Reduci Garibaldini e il Museo Garibaldino, dedicato anche alla
Divisione italiana partigiana Garibaldi, attiva in Jugoslavia tra il
1943 e il 1945.
Nel
vero e proprio Museo Garibaldino le pareti, le bacheche e le vetrine
ospitano cimeli di vario tipo, alcuni dei quali relativi all’Eroe
dei due Mondi e ai suoi familiari. Non mancano ricordi della
Repubblica Romana e camicie rosse di ufficiali e di semplici
soldati.
Il
Museo attualmente è chiuso al pubblico per consentirne la
risistemazione interna.
di Antonio
Venditti e Cinzia
Dal Maso |
|
|
|
GLI
AVVENIMENTI PIÙ TRAGICI E GLORIOSI SI VERIFICARONO A GIUGNO |
|
La Repubblica Romana
compie centosessanta anni
 Il
9 febbraio del 1849 – 160 anni or sono - veniva proclamata la
Repubblica Romana, una parentesi rivoluzionaria che avrebbe avuto
vita breve e sarebbe caduta il 3 luglio sotto le bombe francesi del
generale Oudinot. Proprio in questo mese di giugno ricorre
l’anniversario dei giorni più caldi, tragici e gloriosi di
quell’avventura. Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 l’attacco
dell’artiglieria francese prese di sorpresa gli avamposti e riuscì a
conquistare il Convento di San Pancrazio e Villa Corsini, ossia il
casino dei Quattro Venti. Alle prime luci dell’alba tutto il
Gianicolo era un campo di battaglia, raggiunto fin dalle 5 del
mattino dallo stesso Garibaldi. I combattimenti infuriavano
soprattutto intorno a Villa Corsini, riconquistata e persa dai
volontari numerose volte, come ricorda Cesare Pascarella: "S’entrava
ner portone, pe’ le scale, / Pe’ le camere, fra le baricate / De
sedie e tavolini, pe’ le sale, / A mozzichi, a spintoni, a
sciabolate, / Co’ qualunqu’arma, come se poteva, / Fra fiamme, foco,
strilli, sangue, morte, / Se cacciaveno via; se rivinceva; / Se
rivinceva; ma nun ce fu verso / De spuntalla. Fu preso pe’ tre vorte
/ De fila e pe’ tre vorte fu riperso". In quegli inutili tentativi
s’immolò tanta parte dei difensori di Roma: morirono Francesco
Daverio, il ventiduenne Enrico Dandolo, Gaetano Bonnet, Angelo
Masina. Tra i feriti Emilio Dandolo e Goffredo Mameli, colpito per
errore dalla baionetta di un bersagliere, destinato a una
lunghissima agonia per cancrena, che lo porterà alla morte il 6
luglio. Il
9 febbraio del 1849 – 160 anni or sono - veniva proclamata la
Repubblica Romana, una parentesi rivoluzionaria che avrebbe avuto
vita breve e sarebbe caduta il 3 luglio sotto le bombe francesi del
generale Oudinot. Proprio in questo mese di giugno ricorre
l’anniversario dei giorni più caldi, tragici e gloriosi di
quell’avventura. Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 l’attacco
dell’artiglieria francese prese di sorpresa gli avamposti e riuscì a
conquistare il Convento di San Pancrazio e Villa Corsini, ossia il
casino dei Quattro Venti. Alle prime luci dell’alba tutto il
Gianicolo era un campo di battaglia, raggiunto fin dalle 5 del
mattino dallo stesso Garibaldi. I combattimenti infuriavano
soprattutto intorno a Villa Corsini, riconquistata e persa dai
volontari numerose volte, come ricorda Cesare Pascarella: "S’entrava
ner portone, pe’ le scale, / Pe’ le camere, fra le baricate / De
sedie e tavolini, pe’ le sale, / A mozzichi, a spintoni, a
sciabolate, / Co’ qualunqu’arma, come se poteva, / Fra fiamme, foco,
strilli, sangue, morte, / Se cacciaveno via; se rivinceva; / Se
rivinceva; ma nun ce fu verso / De spuntalla. Fu preso pe’ tre vorte
/ De fila e pe’ tre vorte fu riperso". In quegli inutili tentativi
s’immolò tanta parte dei difensori di Roma: morirono Francesco
Daverio, il ventiduenne Enrico Dandolo, Gaetano Bonnet, Angelo
Masina. Tra i feriti Emilio Dandolo e Goffredo Mameli, colpito per
errore dalla baionetta di un bersagliere, destinato a una
lunghissima agonia per cancrena, che lo porterà alla morte il 6
luglio.
Avrebbe
detto Garibaldi: "Il tre giugno decise della sorte di Roma...Il
Vascello solo si sostenne fino all’ultimo, per la bravura di Medici
e della sua gente; e quando si abbandonò alla fine, non rimaneva di
quell’esteso edifizio che un mucchio di macerie".
 Ascoltiamo
ancora i versi di Pascarella: "Nun c’era più che Medici
ar Vascello. / Er
resto tutto quanto era perduto. / Nun ce restava in piede antro che
quello. / Ma ce rimase lì fino a la fine: / Fin che er muro, li
sassi, li mattoni, / Fin che le pietre de li cornicioni / Nun
staveno giù drento a le cantine. / E lì, fra assarti, mine,
contromine, / Tutti li reggimenti e li cannoni, / Fin che nun volle
lui, non furno boni / De fallo scegne’ giù da le rovine. / Ché, dar
principio che ce s’era messo, / Più loro li francesi ce provaveno /
A cacciallo, e più lui sempre lo stesso. / Imperterrito sempre e
sempre in cima / A le macerie, se lo ritrovaveno / ‘Gni giorno
sempre lì peggio de prima". Ascoltiamo
ancora i versi di Pascarella: "Nun c’era più che Medici
ar Vascello. / Er
resto tutto quanto era perduto. / Nun ce restava in piede antro che
quello. / Ma ce rimase lì fino a la fine: / Fin che er muro, li
sassi, li mattoni, / Fin che le pietre de li cornicioni / Nun
staveno giù drento a le cantine. / E lì, fra assarti, mine,
contromine, / Tutti li reggimenti e li cannoni, / Fin che nun volle
lui, non furno boni / De fallo scegne’ giù da le rovine. / Ché, dar
principio che ce s’era messo, / Più loro li francesi ce provaveno /
A cacciallo, e più lui sempre lo stesso. / Imperterrito sempre e
sempre in cima / A le macerie, se lo ritrovaveno / ‘Gni giorno
sempre lì peggio de prima".
Al 13
giugno si ascrive uno degli episodi più commoventi dell’epopea
garibaldina. A Porta San Pancrazio, mentre tenta di riparare le
barricate con sacchi di sabbia, un giovanissimo soldato viene
colpito di rimbalzo da una palla di cannone che gli spezza le reni.
Un ufficiale si getta su di lui in preda alla disperazione e gli
copre il volto di baci. Il soldato è Colomba Antonietti, che si è
tagliata i capelli e veste una divisa maschile per combattere al
fianco del marito, il conte Luigi Porzi, l’ufficiale che da quel
giorno vivrà nel culto della sposa persa così tragicamente.
Garibaldi avrebbe malinconicamente confidato nelle sue memorie:
"quella donna mi ricorda la mia povera Anita: anch’essa era sì
tranquilla e sì coraggiosa in mezzo al fuoco".
I
combattimenti sarebbero ripresi più aspri che mai il 27 e il 28
giugno. Il 29 Luciano Manara scrisse, riferendosi ai Francesi:
"Vinceranno...Ma ogni maceria sarà difesa. Ogni rovina che copre
cadaveri dei nostri è salita da altri che vi muoiono anziché
cederla. Roma in questo momento è grande, grande come le sue
memorie, come i monumenti che la ornano e che il barbaro sta
bombardando". Alle due del mattino del 30 giugno i francesi
attaccarono. Teatro degli scontri fu Villa Spada, sempre sul
Gianicolo, dove caddero tra gli altri Emilio Morosini e Luciano
Manara, spirato tra le braccia di Emilio Dandolo. Le cannonate degli
assalitori rasero al suolo Porta San Pancrazio. Alle 10 di quello
stesso giorno Mazzini riunì il consiglio della Repubblica a Palazzo
Corsini alla Lungara. La decisione presa fu dolorosa ma inevitabile:
"in nome di Dio e del popolo, l’Assemblea Costituente Romana cessa
da una difesa resa impossibile e resta al suo posto".
di
Cinzia Dal Maso |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
|
E’
DEDICATA AL GIOVANE CIOCIARO DOMENICO SUBIACO |
|
La scalea
del Tamburino
La
rampa che da via Dandolo scende in viale Glorioso si chiama scalea
del Tamburino, ma pochi sanno che è dedicata a un giovane ciociaro,
Domenico Subiaco, nato a Ripi il 4 dicembre 1832 da due contadini,
Giovanni e Angela Maria Paparelli. Appena sedicenne, nel 1849 volle
essere tra i difensori della Repubblica Romana. Per la sua statura,
non fu ritenuto adatto al combattimento. Non gli venne affidato un
fucile, ma fu nominato tamburino del I Reggimento Fanteria e come
tale prese parte a più di una battaglia. Nella fatidica giornata del
3 giugno era sul Gianicolo, sotto il fuoco del generale Oudinot.
Come racconta Ceccarius,
Domenico suonò l’allarme e la carica. Poi, "al grido di ‘Viva
l'Italia!’’"Viva Roma!’, raccolse il fucile di un soldato caduto al
suo fianco, spianandolo contro il nemico, ma una palla francese lo
colpì nel mezzo della fronte".
L’episodio è riferito anche da un testimone oculare, Camillo
Ravioli: "dall’alto della porta di S. Pancrazio tirò a petto
scoperto gettata l'uniforme - e lo vid’io nel mattino di quel giorno
stesso 3 giugno - da dieci a dodici colpi contro i francesi che
assalivano il bastione ottavo, facendosi porgere l'arma carica dai
compagni che gli erano di sotto, finché una palla nemica lo colpì
nel parietale sinistro e lo gettò rovescio e moribondo a basso".
Bisognò
aspettare il 1891 perché la scalea presso il quale era caduto il
ragazzo gli venisse dedicata. Poi nient’altro, nemmeno una targa con
qualche nota biografica che aiuti a identificare il "tamburino".
Almeno
la sua terra d’origine non è stata immemore e nella piazza della
Libertà di Frosinone, in un monumento dello scultore Ernesto Biondi,
Domenico Subiaco è raffigurato insieme a molti altri patrioti. Nel
1911 anche Ripi ha dedicato una lapide al suo "figlio eroico" che
"giacque sedicenne" incitando "gli eroi di Roma" "contro lo
straniero invasore".
di Cinzia
Dal Maso |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
|
COSTRUITE DA URBANO VIII, CANNONEGGIATE DAI FRANCESI E RESTAURATE DA
PIO IX |
|
UNA PASSEGGIATA NELLA
STORIA:
LE MURA GIANICOLENSI
 Durante
la "Guerra di Castro" contro i Farnese, il papa Urbano VIII
Barberini volle rinforzare le difese di Roma, che non risultava
sufficientemente protetta nella parte a destra del Tevere. Le
cosiddette mura Gianicolensi furono iniziate il 15 luglio del 1641
con una serie di misurazioni e condotte a termine a tempo di record,
nel 1643. Il progetto fu affidato all’architetto militare Giulio
Buratti e all’architetto Marcantonio De Rossi, che godeva della
protezione della potentissima donna Olimpia Maidalchini. La nuova
cinta mutò sostanzialmente il sistema delle murature preesistenti.
La porta Santo Spirito e il vicino bastione del Sangallo divennero
inutili, come la porta Settimiana. L’antica porta Portuensis, del
recinto di Aureliano, che si trovava 453 metri oltre il nuovo muro,
fu abbattuta e sostituita dalla porta Portese, che fu ultimata solo
nel 1644, quando Urbano VIII era morto. Per questo reca lo stemma
del suo successore, Innocenzo X. In corrispondenza della porta San
Pancrazio, invece, il nuovo muro veniva praticamente a coincidere
con quello di epoca romana. La porta però, in pessimo stato di
conservazione, veniva quasi del tutto ricostruita. Il De Rossi
conservò solo la controporta merlata, riconoscibile ancora nelle
incisioni del Rossini del 1829. Si può seguire il tracciato delle
mura partendo dalla parte più bassa, quella di porta Portese. Dopo
un breve tratto diretto a nord-ovest, il muro si dirige verso
sud-ovest e raggiunge largo Bernardino da Feltre, dove doveva
incrociare la cinta di Aureliano. Nulla resta del bastione che si
elevava in corrispondenza di viale Trastevere, vittima degli
sventramenti di epoca umbertina. Il muro riprende lungo via Aurelio
Saffi - dove risulta inizialmente piuttosto basso per l’innalzamento
del piano stradale - e sale sulla collina di Monte Verde. Giunti a
largo Berchet piega quasi ad angolo retto, costeggiato da viale
delle Mura Gianicolensi. Da qui fino all’incrocio con via Fratelli
Bonnet il muro racchiude il giardino di villa Sciarra e nell’area
interna è solo parzialmente visibile, perché per la massima parte
coperto da un terrapieno. A metà di questo percorso, nella gola tra
due bastioni, si apre una posterula, utilizzata come ingresso
secondario a villa Sciarra, attraversando la quale si può avere
un’idea del notevole spessore della base del muro. Proprio a partire
da largo Berchet il muro presenta tutta una serie di rattoppi,
evidenziati da biffe bianche, che ricordano i restauri effettuati da
Pio IX per chiudere le brecce aperte nel giugno del 1849 dai
cannoneggiamenti dei francesi che assediavano la Repubblica Romana.
Si può infatti vedere lo stemma di Pio IX con la data 1849 in numeri
romani. Sulla parte di muro originario, invece, è ancora presente lo
stemma di Urbano VIII con le api dei Barberini. Su via Fratelli
Bonnet sono stati aperti – per ragioni di viabilità – due moderni
fornici, i cosiddetti "Archi di villa Sciarra". Il muro riprende
dunque a salire. Anche qui le lapidi testimoniano i danni prodotti
dall’assedio francese. Durante
la "Guerra di Castro" contro i Farnese, il papa Urbano VIII
Barberini volle rinforzare le difese di Roma, che non risultava
sufficientemente protetta nella parte a destra del Tevere. Le
cosiddette mura Gianicolensi furono iniziate il 15 luglio del 1641
con una serie di misurazioni e condotte a termine a tempo di record,
nel 1643. Il progetto fu affidato all’architetto militare Giulio
Buratti e all’architetto Marcantonio De Rossi, che godeva della
protezione della potentissima donna Olimpia Maidalchini. La nuova
cinta mutò sostanzialmente il sistema delle murature preesistenti.
La porta Santo Spirito e il vicino bastione del Sangallo divennero
inutili, come la porta Settimiana. L’antica porta Portuensis, del
recinto di Aureliano, che si trovava 453 metri oltre il nuovo muro,
fu abbattuta e sostituita dalla porta Portese, che fu ultimata solo
nel 1644, quando Urbano VIII era morto. Per questo reca lo stemma
del suo successore, Innocenzo X. In corrispondenza della porta San
Pancrazio, invece, il nuovo muro veniva praticamente a coincidere
con quello di epoca romana. La porta però, in pessimo stato di
conservazione, veniva quasi del tutto ricostruita. Il De Rossi
conservò solo la controporta merlata, riconoscibile ancora nelle
incisioni del Rossini del 1829. Si può seguire il tracciato delle
mura partendo dalla parte più bassa, quella di porta Portese. Dopo
un breve tratto diretto a nord-ovest, il muro si dirige verso
sud-ovest e raggiunge largo Bernardino da Feltre, dove doveva
incrociare la cinta di Aureliano. Nulla resta del bastione che si
elevava in corrispondenza di viale Trastevere, vittima degli
sventramenti di epoca umbertina. Il muro riprende lungo via Aurelio
Saffi - dove risulta inizialmente piuttosto basso per l’innalzamento
del piano stradale - e sale sulla collina di Monte Verde. Giunti a
largo Berchet piega quasi ad angolo retto, costeggiato da viale
delle Mura Gianicolensi. Da qui fino all’incrocio con via Fratelli
Bonnet il muro racchiude il giardino di villa Sciarra e nell’area
interna è solo parzialmente visibile, perché per la massima parte
coperto da un terrapieno. A metà di questo percorso, nella gola tra
due bastioni, si apre una posterula, utilizzata come ingresso
secondario a villa Sciarra, attraversando la quale si può avere
un’idea del notevole spessore della base del muro. Proprio a partire
da largo Berchet il muro presenta tutta una serie di rattoppi,
evidenziati da biffe bianche, che ricordano i restauri effettuati da
Pio IX per chiudere le brecce aperte nel giugno del 1849 dai
cannoneggiamenti dei francesi che assediavano la Repubblica Romana.
Si può infatti vedere lo stemma di Pio IX con la data 1849 in numeri
romani. Sulla parte di muro originario, invece, è ancora presente lo
stemma di Urbano VIII con le api dei Barberini. Su via Fratelli
Bonnet sono stati aperti – per ragioni di viabilità – due moderni
fornici, i cosiddetti "Archi di villa Sciarra". Il muro riprende
dunque a salire. Anche qui le lapidi testimoniano i danni prodotti
dall’assedio francese.  La
prima, di Pio IX, reca gli stemmi Odescalchi, Mastai Ferretti e del
Comune di Roma. Un’altra è stata apposta dopo l’unità d’Italia, il 4
giugno 1871, per onorare "la memoria di coloro che combattendo
strenuamente caddero in difesa della patria". Si giunge quindi nel
punto più elevato dell’intera fortificazione, a porta San Pancrazio,
anch’essa distrutta dagli eventi bellici del 1849 e ricostruita nel
1854 dall’architetto Virginio Vespignani (1808 – 82), in forme
sobrie e solenni. Il muro ora scende lungo il viale delle Mura
Aurelie. Dopo il primo bastione si nota un’edicola in travertino con
al centro una statua di Sant’Andrea, con un’iscrizione che ricorda
come proprio in quel punto fosse stata ritrovata la testa di
Sant’Andrea apostolo, abbandonata dal ladro che l’aveva trafugata. La
prima, di Pio IX, reca gli stemmi Odescalchi, Mastai Ferretti e del
Comune di Roma. Un’altra è stata apposta dopo l’unità d’Italia, il 4
giugno 1871, per onorare "la memoria di coloro che combattendo
strenuamente caddero in difesa della patria". Si giunge quindi nel
punto più elevato dell’intera fortificazione, a porta San Pancrazio,
anch’essa distrutta dagli eventi bellici del 1849 e ricostruita nel
1854 dall’architetto Virginio Vespignani (1808 – 82), in forme
sobrie e solenni. Il muro ora scende lungo il viale delle Mura
Aurelie. Dopo il primo bastione si nota un’edicola in travertino con
al centro una statua di Sant’Andrea, con un’iscrizione che ricorda
come proprio in quel punto fosse stata ritrovata la testa di
Sant’Andrea apostolo, abbandonata dal ladro che l’aveva trafugata.
Dopo
circa un chilometro, il muro di Urbano VIII si congiunge al bastione
fatto erigere nel 1568 da Pio V, presso l’attuale palazzo di
Propaganda Fide e poco prima del largo di porta Cavalleggeri. In
quest’ultimo tratto sono murati ben 12 stemmi di Urbano VIII e 3 di
Pio IX.
di Cinzia
Dal Maso |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
|
IL 3
GIUGNO DEL 1849 GARIBALDINI E FRANCESI SI CONTESERO IL POSSESSO DI
VILLA CORSINI |
|
LA STORICA BATTAGLIA DEI
QUATTRO VENTI
 Il
15 maggio del 1849, la storia della Repubblica Romana sembrava
essere giunta a una svolta. Era stata raggiunta quella che sembrava
una vittoria della diplomazia di Mazzini: una tregua d’armi con i
Francesi di 20 giorni, pattuita con il plenipotenziario Lesseps, cui
seguì un trattato secondo il quale l’armata francese doveva essere
considerata dai romani "un’armata
amica che viene a concorrere alla difesa del loro territorio". Il
15 maggio del 1849, la storia della Repubblica Romana sembrava
essere giunta a una svolta. Era stata raggiunta quella che sembrava
una vittoria della diplomazia di Mazzini: una tregua d’armi con i
Francesi di 20 giorni, pattuita con il plenipotenziario Lesseps, cui
seguì un trattato secondo il quale l’armata francese doveva essere
considerata dai romani "un’armata
amica che viene a concorrere alla difesa del loro territorio".
Il re
francese Luigi Napoleone, però, la pensava diversamente. Il 29
maggio inviò due dispacci, uno al gen. Oudinot per ordinargli di
procedere all’assalto di Roma e l’altro a Lesseps, intimandogli di
tornare in Francia. Oudinot, secondo una sorta di codice
cavalleresco dell’epoca, annunciò che avrebbe ripreso i
combattimenti lunedì 4 giugno. Il generale, però, non fu di parola.
Con un’azione che venne considerata un vero e proprio tradimento,
nella notte tra il 2 e il 3 giugno due colonne francesi sorpresero i
difensori nel sonno e si impadronirono delle ville Pamphili, Corsini
e Valentini, tutte posizioni strategiche d grande importanza.
Garibaldi, ancora sofferente per la caduta di Velletri, accorse sul
Gianicolo la mattina del 3, arrivandovi alle 5 e mezzo. Con lui
erano la legione italiana e i bersaglieri lombardi, che per tutta la
giornata tentarono di recuperare le posizioni perdute, nonostante la
loro incredibile inferiorità numerica. Particolarmente cruenti
furono gli assalti a villa Corsini, conosciuta anche come il casino
dei Quattro Venti, riconquistata e persa più volte. Durante un
attacco dei lancieri morirono il generale Masina, vari soldati, il
porta bandiera Pier Antonio Zamboni, il tenente aiutante Pietro
Scalcerle e numerosi ufficiali del Galletti. Poco dopo fu la volta
dei legionari guidati da Nino Bixio, che fu gravemente ferito. In
uno degli assalti riportò ferite mortali Francesco Daverio, capo
dello stato maggiore della legione. Tra le 8 e le 9 del mattino
intervennero i bersaglieri lombardi di Luciano Manara, subendo
enormi perdite. Quel giorno Goffredo Mameli riportò la ferita al
ginocchio che lo avrebbe fatto morire di cancrena. All’epopea di
villa Corsini Cesare Pascarella ha dedicato alcuni dei più bei versi
della sua "Storia nostra": "Se seppe che er nemico era padrone / Già
der casino de le Quattro Venti. / Pe’ riportaje via la posizione /
Se cominciorno li combattimenti. / E dar primo momento che sorgeva /
La luce, che s’uscì for da le Porte, / Fino all’ultimo che ce se
vedeva, / Se fece tutto!...Ma non ce fu verso / De spuntalla! Fu
preso pe’ tre vorte / De fila e pe’ tre vorte fu riperso. / Eppure,
come daveno er segnale / (Mentre da le finestre e le ferrate /
Veniva giù l’inferno!), dar viale / se rimontava su le scalinate; /
S’entava ner portone, pe’ le scale, / Pe’ le camere, fra le baricate
/ De sedie e tavolini, pe’ le sale, / A mozzichi, a spintoni, a
sciabolate, / Co’ qualunqu’arma, come se poteva, / Fra fiamme, foco,
strilli, sangue, morte, / Se cacciaveno via; se rivinceva; / Se
rivinceva; ma nun ce fu verso / De spuntalla. Fu preso pe’ tre vorte
/ de fila e pe’ tre vorte fu riperso. / L’urtima, er tetto in cima
già fumava; / Travi, soffitti, mura s’abbruciaveno, / Pe’ le camere
ormai se camminava / Su li morti che se carbonizzaveno; / E a ‘gni
razzo, a ‘gni bomba che schioppava / Ne le camere che se
sfracellaveno, / Mentre che se feriva e s’ammazzava, / Travi,
soffitti...giù!, se sprofonnaveno. / E pure, sai? Finché nun fu
distrutto, / Finché ce furno muri, scale, porte / Pe’ ripotecce
entrà, se provò tutto; / Se provò tutto; ma nun ce fu verso / De
spuntalla. Fu preso per tre vorte / De fila e pe’ tre vorte fu
riperso". al
ginocchio che lo avrebbe fatto morire di cancrena. All’epopea di
villa Corsini Cesare Pascarella ha dedicato alcuni dei più bei versi
della sua "Storia nostra": "Se seppe che er nemico era padrone / Già
der casino de le Quattro Venti. / Pe’ riportaje via la posizione /
Se cominciorno li combattimenti. / E dar primo momento che sorgeva /
La luce, che s’uscì for da le Porte, / Fino all’ultimo che ce se
vedeva, / Se fece tutto!...Ma non ce fu verso / De spuntalla! Fu
preso pe’ tre vorte / De fila e pe’ tre vorte fu riperso. / Eppure,
come daveno er segnale / (Mentre da le finestre e le ferrate /
Veniva giù l’inferno!), dar viale / se rimontava su le scalinate; /
S’entava ner portone, pe’ le scale, / Pe’ le camere, fra le baricate
/ De sedie e tavolini, pe’ le sale, / A mozzichi, a spintoni, a
sciabolate, / Co’ qualunqu’arma, come se poteva, / Fra fiamme, foco,
strilli, sangue, morte, / Se cacciaveno via; se rivinceva; / Se
rivinceva; ma nun ce fu verso / De spuntalla. Fu preso pe’ tre vorte
/ de fila e pe’ tre vorte fu riperso. / L’urtima, er tetto in cima
già fumava; / Travi, soffitti, mura s’abbruciaveno, / Pe’ le camere
ormai se camminava / Su li morti che se carbonizzaveno; / E a ‘gni
razzo, a ‘gni bomba che schioppava / Ne le camere che se
sfracellaveno, / Mentre che se feriva e s’ammazzava, / Travi,
soffitti...giù!, se sprofonnaveno. / E pure, sai? Finché nun fu
distrutto, / Finché ce furno muri, scale, porte / Pe’ ripotecce
entrà, se provò tutto; / Se provò tutto; ma nun ce fu verso / De
spuntalla. Fu preso per tre vorte / De fila e pe’ tre vorte fu
riperso".
Il
casino dei Quattro Venti, con la sua caratteristica pianta quadrata
con quattro ingressi al centro di ogni lato e salone centrale, era
rimasto irrimediabilmente compromesso. Poco restava dei frontoni
guarniti di ghirlande e dei vasi di fiori che il pittore olandese
Jan Philip Koelman aveva visto splendere al mattino sotto i raggi
del sole nascente. I suoi resti furono inglobati nell’Arco
quadrifronte dei Quattro Venti, costruito tra il 1856 e il 1859
dall’architetto Andrea Busiri Vici, che oggi si innalza presso
l’ingresso di villa Pamphili. L’arco riutilizza anche le strutture
murarie del piano d’imposta e parte del mattonato. E’ decorato con
statue dei venti e con lo stemma di papa Innocenzo X.
Recenti
restauri hanno evidenziato anche alcune iscrizioni sui muri vergate
nel 1849.
di Antonio
Venditti e Cinzia
Dal Maso |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
| |
|
Gli eroi della Repubblica Romana
e le loro memorie a Monteverde
 In
occasione del Centenario della proclamazione della Repubblica
Romana, sono stati posti sul Gianicolo una serie di pannelli
bronzei, per illustrare le vicende della difesa di Roma del 1849. Su
questo colle, infatti, fu scritta una delle pagine più gloriose e
tristi del Risorgimento italiano. L’esercito francese, comandato dal
generale Oudinot, accorso in aiuto di Pio IX, forte di 36.000 uomini
e 75 cannoni, iniziò ad attaccare alle tre del mattino del 3 giugno
il settore del Gianicolo dove era acquartierato Garibaldi, il cui
esercito, al comando di Roselli, contava 19.000 uomini accorsi da
tutta l’Italia, pieni di buona volontà ma nella maggior parte dei
casi scarsamente addestrati, con 100 vecchi cannoni, quasi tutti di
piccolo calibro e con scarse munizioni. Cadde subito Villa Pamphili.
Stessa sorte toccò a Villa Corsini, nella cui disperata difesa trovò
la morte Enrico Dandolo. Goffredo Mameli, ferito nei pressi di San
Pietro in Montorio, spirò dopo qualche giorno. La situazione si fece
tragica non appena i Francesi, nella notte tra il 21 e il 22 giugno,
riuscirono a rompere la prima linea. Reggeva ancora la posizione
avanzata del Vascello, presidiata dalla divisione Medici. Scriveva
Luciano Manara in una lettera del 29 giugno: “ogni maceria sarà
difesa. Ogni rovina che copra i cadaveri dei nostri è salita da
altri che vi muoiono piuttosto che cederla. Roma in questo momento è
grande, grande come le sue memorie, come i monumenti che la ornano e
che il barbaro sta bombardando”. Il giorno seguente, 30 giugno, i
francesi travolgevano anche questa seconda linea. Luciano Manara era
assediato con i suoi bersaglieri volontari a Villa Spada. “Una palla
colpì il povero Luciano alla bocca dello stomaco e gli uscì dalla
schiena”, ricordò Emilio Dandolo, fratello di Enrico. “Fece tre
passi e io accorsi e lo presi in braccio. Ho pochi momenti da vivere,
mi disse: ti raccomando i miei figli: e mi diede un bacio”. La
situazione non era più sostenibile. L'Assemblea repubblicana ritenne
impossibile continuare la difesa. Il 2 luglio Garibaldi invitò
quanti volessero proseguire la lotta a seguirlo: “chi vuole
continuare la guerra contro lo straniero venga con me. Non offro né
paga, né quartiere, né provvigioni. Offro fame sete marce battaglie
e morte". Quindi uscì da Roma con circa quattromila uomini,
dirigendosi alla volta di Venezia. Il 3 luglio i Francesi occupavano
la città. In
occasione del Centenario della proclamazione della Repubblica
Romana, sono stati posti sul Gianicolo una serie di pannelli
bronzei, per illustrare le vicende della difesa di Roma del 1849. Su
questo colle, infatti, fu scritta una delle pagine più gloriose e
tristi del Risorgimento italiano. L’esercito francese, comandato dal
generale Oudinot, accorso in aiuto di Pio IX, forte di 36.000 uomini
e 75 cannoni, iniziò ad attaccare alle tre del mattino del 3 giugno
il settore del Gianicolo dove era acquartierato Garibaldi, il cui
esercito, al comando di Roselli, contava 19.000 uomini accorsi da
tutta l’Italia, pieni di buona volontà ma nella maggior parte dei
casi scarsamente addestrati, con 100 vecchi cannoni, quasi tutti di
piccolo calibro e con scarse munizioni. Cadde subito Villa Pamphili.
Stessa sorte toccò a Villa Corsini, nella cui disperata difesa trovò
la morte Enrico Dandolo. Goffredo Mameli, ferito nei pressi di San
Pietro in Montorio, spirò dopo qualche giorno. La situazione si fece
tragica non appena i Francesi, nella notte tra il 21 e il 22 giugno,
riuscirono a rompere la prima linea. Reggeva ancora la posizione
avanzata del Vascello, presidiata dalla divisione Medici. Scriveva
Luciano Manara in una lettera del 29 giugno: “ogni maceria sarà
difesa. Ogni rovina che copra i cadaveri dei nostri è salita da
altri che vi muoiono piuttosto che cederla. Roma in questo momento è
grande, grande come le sue memorie, come i monumenti che la ornano e
che il barbaro sta bombardando”. Il giorno seguente, 30 giugno, i
francesi travolgevano anche questa seconda linea. Luciano Manara era
assediato con i suoi bersaglieri volontari a Villa Spada. “Una palla
colpì il povero Luciano alla bocca dello stomaco e gli uscì dalla
schiena”, ricordò Emilio Dandolo, fratello di Enrico. “Fece tre
passi e io accorsi e lo presi in braccio. Ho pochi momenti da vivere,
mi disse: ti raccomando i miei figli: e mi diede un bacio”. La
situazione non era più sostenibile. L'Assemblea repubblicana ritenne
impossibile continuare la difesa. Il 2 luglio Garibaldi invitò
quanti volessero proseguire la lotta a seguirlo: “chi vuole
continuare la guerra contro lo straniero venga con me. Non offro né
paga, né quartiere, né provvigioni. Offro fame sete marce battaglie
e morte". Quindi uscì da Roma con circa quattromila uomini,
dirigendosi alla volta di Venezia. Il 3 luglio i Francesi occupavano
la città.
Monteverde conserva numerose memorie di quei tragici avvenimenti: la
Villa Doria Pamphilj, l’entrata di Villa Corsini, con le tracce
delle palle di cannone francesi, Porta San Pancrazio, dove fu ferita
mortalmente Colomba Antonietti, mentre combatteva, vestita da uomo,
accanto al marito, l’antica osteria Scarpone, nelle cui gallerie
sotterranee venivano provvisoriamente seppelliti i morti della
battaglia per il Casino dei Quattro Venti, il convento di San
Pancrazio, il Vascello, la “batteria dei pini”, ultimo baluardo
garibaldino, dove oggi si innalza il Sacrario dei Caduti per la
causa di Roma italiana.
di Cinzia Dal Maso |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
| |
|
SANTA
MARINELLA FU FONDATA
GRAZIE A GARIBALDI

Fu Giuseppe Garibaldi, l’Eroe dei Due Mondi, a consigliare il
principe Baldassarre Odescalchi di trasformare il tratto di spiaggia
antistante il suo castello in una località di villeggiatura. Nacque
così Santa Marinella, destinata a un rapido e fortunato sviluppo.
Lo stemma, moderno, presenta un’ancora
e una bella rocca in riva al mare. Un richiamo alle antiche origini
è la scritta "Ad Punicum", riferita al porto di Caere che si trovava
nel suo territorio e testimonia, con il suo nome, stretti legami con
i Cartaginesi e la loro stessa presenza sul luogo, già documentata
dal non lontano Santuario di Pyrgi. Qui in epoca romana sorsero
numerose ville marittime, tra cui quella appartenuta al senatore Cn.
Domizio Annio Ulpiano.
di Cinzia
Dal Maso |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
| |
|
LE VACANZE DI GARIBALDI A CIVITAVECCHIA
Giuseppe Garibaldi, dopo l’unità d’Italia,
amava trascorrere le vacanze estive a Civitavecchia. Uno dei suoi
stabilimenti balneari preferiti era il "Bruzzesi", realizzato su un
isolotto da Giuseppe, zio del colonnello garibaldino Giacinto
Bruzzesi, originario di Cerveteri. L’Eroe dei Due Mondi vi sostava
volentieri, infervorandosi anche in qualche conversazione politica.
Nel 1879, tormentato dai reumatismi, vi cercò un sollievo nelle
sabbiature. Al "Bruzzesi" Clelia, la figlia che Garibaldi aveva
avuto da Francesca Armosino, imparò a nuotare, dando anche prova di
coraggio nel salvare un giovinetto come lei, in procinto di
annegare.
Alla fine dell’Ottocento, lo stabilimento
cambiò proprietario e assunse il nome di Pirgo, che evocava le
origini etrusche della zona. Vi fu persino realizzato un elegante
teatro. Continuò ad attirare una clientela ricca e selezionata, fino
alla seconda guerra mondiale, poi la vita dello stabilimento
proseguì in tono minore. Negli anni ’60 si ebbe l’abbandono e nel
1995, per motivi di sicurezza, furono abbattute lo poche strutture
ancora in piedi.
di Cinzia
Dal Maso |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
|
