|

|
GLI EROI DEL
RISORGIMENTO ROMANO |
|
ANDREA AGUYAR |
|
SAMUELE
ALATRI |
|
COLOMBA ANTONIETTI |
|
ANGELO BRUNETTI |
|
GIACINTO BRUZZESI |
|
LUIGI CALAMATTA |
|
Alessandro
Calandrelli |
|
LUDOVICO CALANDRELLI |
|
MELCHIORRE CARTONI |
|
FILIPPO CASINI |
|
AUGUSTO CASTELLANI |
|
alessandro CASTELLANI |
|
LE SORELLE CASTELLANI |
|
LUIGI CECCARINI |
|
FILIPPO CERROTI |
|
Giuseppe Checchetelli |
|
NINO COSTA |
|
Anna de Cadilhac |
|
FILIPPO DE CUPIS |
|
NATALE DEL GRANDE |
|
BARTOLOMEO FILIPPERI |
|
MARGARET FULLER |
|
GEROLAMO INDUNO |
|
JAN PHILIP KOELMAN |
|
ANNIBALE LUCATELLI |
|
CESARE LUCATELLI |
|
Lorenzo Maderazzi
|
|
GOFFREDO
MAMELI |
|
MATTIA MONTECCHI |
|
CLELIA NALLI MASSIMI |
|
PAOLO NARDUCCI |
|
GIOVANNI ANGELO OSSOLI |
|
RIGHETTO |
|
PIETRO ROSELLI |
|
FELICE SCIFONI |
|
ULISSE SENI |
|
FRANCESCO STURBINETTI |
|
Giuditta Tavani Arquati |
|
ANGELO TITTONI |
|
GAETANO TOGNETTI |
|
Cristina
Trivulzio di Belgiojoso |
|
AUGUSTO VALENZIANI |
|
Un libro di Claudio Modena su
Angelo Brunetti |
|
Ciceruacchio, capopolo romano
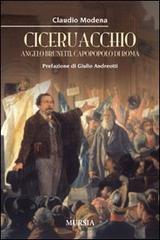
Angelo Brunetti era nato
a Roma il 27 settembre 1800, nel popolare rione di Campo Marzio.
Nella più tenera età la madre gli aveva dato il soprannome di
Ciceruacchio per il suo aspetto paffuto. Una volta cresciuto, si era
messo a fare il carrettiere e tra-sportava vino dai Castelli al
porto di Ripetta. Personaggio carismatico, semplice e schietto,
amato da popolo, con un’innata capacità dialettica rafforzata
dall’uso esclu-sivo del romanesco e una naturale eleganza nel
vestire, fu presto conquistato dagli i-deali risorgimentali, di cui
si fece portavoce fra i popolani. In un primo momento era stato
capace di avvicinare il popolo a Pio IX.
"Ciceruacchio.
Angelo Brunetti, capopopolo di Roma", uno straordinario volume di
Claudio Modena (Mursia, 306 pagine, 20,00 euro), è stato presentato
presso l’Istituto internazionale di studi "Giuseppe Garibaldi"
(piazza della Repubblica 12), diretto da Franco Tamassia.
"Non è
un libro ma un film, che ci fa ritrovare in mezzo ai rumori, ai
suoni, alle emo-zioni", ha spiegato Giuseppe Garibaldi, presidente
dell’Associazione e pronipote dell’Eroe dei Due Mondi, che ha voluto
anche dare uno speciale annuncio. "Stiamo organizzando per il 3, il
4 e il 5 luglio – ha detto – un pellegrinaggio a Caprera per il
nuovo museo dedicato a Garibaldi che sarà inaugurato dal Capo dello
Stato".
Del
libro di Modena ha parlato Silvana Galardi, scrittrice e storica del
Risorgimento. "Questo volume – ha sottolineato – mi ha consentito di
avvicinarmi a una figura di primo piano e di capire il perché di
alcuni atteggiamenti di Pio IX. La grandezza di Ciceruacchio, messa
in evidenza da Modena, è stata il suo sguardo lungimirante che
attraverso la Repubblica Romana vedeva già l’Italia".
Il
sogno però era destinato a durare poco. Il 2 luglio del 1849 la
neonata Repubblica romana cadeva, e quella stessa sera Ciceruacchio
con i figli Luigi e Lorenzo, di soli tredici anni, usciva da Roma,
occupata dalle truppe francesi, attraverso Porta San Giovanni.
Marciava al seguito di Garibaldi verso Venezia, per portare aiuto
alla mo-rente Repubblica Veneta. Nel suo animo ancora viva la
passione per gli ideali di li-bertà per cui aveva lottato, ma anche
tanta amarezza nel lasciare la sua amata città, la moglie Annetta e
gli amici.
Nel suo
libro, Modena ricostruisce la breve avventura di Ciceruacchio,
dall’appassionata fiducia riposta nel Papa Re all’adesione agli
ideali mazziniani e alla Rivoluzione del 1849, dalla caduta della
Repubblica Romana alla tragica fine: fu fu-cilato insieme con i suoi
figlioli la notte di San Lorenzo dello stesso anno a Porto Tolle,
presso Rovigo.
"E se,
come ha messo ben in evidenza Modena, la Repubblica Romana cadde, i
suoi valori sono quelli su cui si è fondata l’attuale Repubblica
Italiana", ha concluso Sil-vana Galardi.
di
Cinzia Dal Maso |
|
Fu uno dei dirigenti del Comitato romano |
|
Giuseppe Checchetelli, letterato e patriota
 Giuseppe
Checchetelli
era nato a Roma il 25 novembre 1823 da Antonio
e da Vincenza Campanelli, entrambi di Ciciliano, presso Tivoli. Fu
battezzato nella chiesa di S. Andrea delle Fratte. La sua casa,
all’altezza del civico 79 di via Due Macelli, è oggi scomparsa.
Si
laureò in giurisprudenza, senza mai esercitare la professione di
avvocato. Le sue grandi passioni furono l’attività letteraria e
soprattutto quella politica. Infatti, come disse Terenzio Mamiani,
"quantunque fornito di buoni studi letterari e bene avviato alla
carriera giuridica, nulla valse a distrarlo dall'amore suo intenso
ed inestinguibile per la gran causa nazionale. Ancor giovinetto
assaggiò lo squallore del carcere per sospetti ed accuse che non
potettero essere provate". Scrisse "Il burbero benefico", un
melodramma rappresentato al teatro Valle nel 1841, con le musiche di
A. Carcano. Del 1842 è il volume "Una giornata di osservazione nel
palazzo della villa di S. E. il principe d. Alessandro Torlonia".
Particolarmente interessanti le "Memorie della Storia d’Italia
considerata nei suoi monumenti" (1842 – 43).
Si
entusiasmò per le aperture liberali di Pio IX e organizzò
dimostrazioni del Circolo Popolare.
Nel '48
si arruolò fra i volontari, nella prima Legione romana, destinata a
diventare il 10° reggimento di linea. Partì sottotenente e prese
parte alla difesa di Vicenza. Quello stesso anno fu promosso tenente
e poi capitano aggiunto nello Stato Maggiore della prima Legione. Fu
poi nominato segretario della Legione e in seguito membro del
Consiglio di Guerra della Divisione.
Quando
era ancora sottotenente fu ferito e grazie alla sua condotta ottenne
una menzione d’onore.
Uno
volta tornato nella città natale, partecipò alla difesa della
Repubblica Romana, combattendo sia a Velletri che sul Gianicolo.
Nel
febbraio del 1850 aveva subito un breve arresto, perché ritenuto
coinvolto in un curioso incidente: mentre passeggiava in carrozza
con la sorella lungo la via del Corso, durante il Carnevale, il
figlio primogenito del principe di Canino aveva ricevuto un mazzo di
fiori che conteneva una granata. L’esplosione dell’ordigno aveva
ferito, fortunatamente in maniera non grave, i due fratelli. Una
volta scarcerato, il Checchetelli preferì andare a vivere nel paese
d’origine dei genitori. Lì lo andò a cercare il pittore e patriota
Nino Costa, che lo convinse a tornare a Roma, dove trovò anche
lavoro, come bibliotecario del duca Lorenzo Sforza Cesarini, per
trenta scudi al mese. Il Checchetelli fu tra coloro che tentavano di
rafforzare quell’Associazione nazionale di cui Mazzini aveva fondato
a Roma il primo nucleo.
Dopo un
tentativo di rivolta fallito sul nascere nel 1853, la pressione
della polizia pontificia lo costrinse a rifugiarsi nuovamente a
Ciciliano. Tornato a Roma, entrò nella dirigenza del Comitato
nazionale romano e si impegno nelle manifestazioni a favore della
seconda guerra d’indipendenza.
Nel
1861 si vide costretto a emigrare a Torino, dove si mise a
disposizione del ministro Ricasoli. Da più parti era ritenuto,
insieme con Augusto Silvestrelli, il rappresentante ufficiale dei
liberali romani. Per Paolo di Campello era un "uomo antico, tanta
era la rettitudine del suo carattere". Secondo Raffaele De Cesare
"possedeva un grande equilibrio di spirito".
Ricasoli considerava il Comitato romano una sorta di partito da
tenere vicino al Governo e a cui affidare un’opera di propaganda,
informazione e preparazione di varie iniziative a sostegno
dell’azione unitaria.
Checchetelli fu deputato dal 1861 al 1870, ma senza svolgere una
particolare attività parlamentare e limitando i suoi interessi alla
questione romana o all’emigrazione.
Il
fallimento della rivolta dell’autunno del 1867, culminata nella
sconfitta garibaldina di Mentana, portò un vespaio di polemiche sul
Comitato romano. Checchetelli, su cui piovvero le denunce, per lo
più ingiuste, di aver trascurato la preparazione dell’opinione
pubblica e il rafforzamento del partito, scomparve dalla vita
politica e pubblica italiana. Solo nel settembre del 1870 fu
chiamato, insieme a altri esperti, a ragguagliare il ministro
Visconti sull’eventualità di una insurrezione romana. Tornò a Roma
dopo la breccia di Porta Pia, senza ruoli politici particolari.
Fino da
giovane aveva sofferto di mal di fegato, che andava peggiorando con
il trascorrere degli anni. Nel 1874 il dottor Francesco Sani, un
liberale suo amico, lo operò di calcoli, senza ottenerne la
guarigione.
Morì in
povertà a Roma il 19 marzo 1879.
di
Cinzia Dal Maso
|
|
Repubblica Romana e comunità ebraica |
|
Samuele Alatri
 La
breve ma intensa esperienza della Repubblica Romana del 1849 vide
l’attiva partecipazione di un gran numero di esponenti della
comunità ebraica di Roma, che finalmente erano potuti uscire dal
ghetto e venivano considerati cittadini con parità di diritti.
Furono anche chiamati a partecipare alla gestione della cosa
pubblica e alla difesa della città, con l’arruolamento fino
dall’aprile del 1849 nella Guardia nazionale, dalla quale erano
stati sempre esclusi. Ebbero anche tre rappresentanti nel consiglio
municipale: Samuele Alatri, presidente della comunità, Samuel Coen
ed Emanuele Modigliani, nonno di Amedeo, il famoso artista.
Non
bisogna dimenticare che Mazzini provò sempre per il popolo ebraico
una viva simpatia, che si rafforzò nel corso degli anni.
Samuele
Alatri era nato a Roma il 30 marzo 1805 da una benestante famiglia
di commercianti. Aveva appena ventitrè anni quando entrò nel
consiglio direttivo della comunità israelitica romana e per molto
tempo si trovò a trattare con Gregorio XVI e con Pio IX alcune
questioni relative alla segregazione razziale. In particolare, nel
periodo delle riforme di quest’ultimo pontefice, il 18 aprile 1848
erano cadute le porte del ghetto. Riuscì a ottenere da Gregorio XVI
che il Monte di Pietà di Roma - di cui dal 1875 sarebbe diventato
direttore - concedesse prestiti su pegni anche agli ebrei, che prima
ne erano esclusi. Nel 1850 entrò a far parte del consiglio di
reggenza della Banca dello Stato Pontificio, la futura Banca Romana.
Riuscì a salvarla dalla crisi del 1855 e poi presentò un progetto di
riforma generale delle banche dello Stato.
La sua
formazione liberale-moderata lo spinse a partecipare, tra il 1848 e
il 1849, al Municipio romano e a stringere legami politici e
personali con Terenzio Mamiani, Marco Minghetti e Francesco
Sturbinetti, di cui divenne consulente. "Er papa der ghetto", come
era soprannominato Alatri, fece parte della delegazione che portò a
Vittorio Emanuele il risultato del plebiscito dell’ottobre del 1870
per l’annessione di Roma all’Italia. Fu consigliere comunale dalle
elezioni del 13 novembre 1870 fino alla morte. Dal 1870 al 1874
ricoprì anche la carica di assessore alle finanze, entrando in
contrasto con il governo per la ripartizione dei beni ecclesiastici
e per gli stanziamenti a favore delle opere edilizie della capitale.
Nelle elezioni amministrative del 1887 fece parte, insieme con
Urbano Rattazzi e altri, della lista dell'Unione romana, di tendenza
cattolico-moderata. A tale proposito, sembra che Pio IX avesse
detto: "Samuele Alatri è il più cristiano di quei cristiani del
Campidoglio".
Fu
anche deputato nella XII legislatura, dal 1874 al 1876. Eletto per
il collegio di Roma II, svolse attività limitata alle commissioni.
Si candidò nuovamente nel 1876, in opposizione alla sinistra, ma fu
battuto. Nel 1880 fu a capo di un Consiglio straordinario per la
riorganizzazione della comunità ebraica di Roma. Dal 1886 fino alla
morte, presiedette il Consiglio generale ordinario.
Si
spense a Roma il 20 maggio 1889.
di
Cinzia Dal Maso
|
|
Un libro sull’eroina
di Cinzia Dal Maso |
|
Colomba
Antonietti
 E’
stato presentato domenica scorsa a Trastevere, presso il Laboratorio
della Individuazione di vicolo del Cedro 5, il libro di Cinzia Dal
Maso "Colomba Antonietti. La vera storia di un’eroina" (EdiLazio,
186 pagine, 12 euro). Il saggio è dedicato alla appassionante
vicenda di una giovane donna umbra che si innamorò contro il volere
della famiglia del nobile cadetto pontificio Luigi Porzi, lo sposò e
poi combatté con lui vestita da uomo, fino al tragico epilogo, che
la vide il 13 giugno del 1849 stroncata da una palla di cannone
francese, mentre difendeva la Repubblica Romana assediata dalle
truppe del generale Oudinot. E’
stato presentato domenica scorsa a Trastevere, presso il Laboratorio
della Individuazione di vicolo del Cedro 5, il libro di Cinzia Dal
Maso "Colomba Antonietti. La vera storia di un’eroina" (EdiLazio,
186 pagine, 12 euro). Il saggio è dedicato alla appassionante
vicenda di una giovane donna umbra che si innamorò contro il volere
della famiglia del nobile cadetto pontificio Luigi Porzi, lo sposò e
poi combatté con lui vestita da uomo, fino al tragico epilogo, che
la vide il 13 giugno del 1849 stroncata da una palla di cannone
francese, mentre difendeva la Repubblica Romana assediata dalle
truppe del generale Oudinot.
Ha
moderato l’incontro la psicologa Angela Maria Bartalotta, mentre la
psichiatra Anna Maria Meoni ha condotto una brillante analisi del
testo di Cinzia Dal Maso, soffermandosi soprattutto su quella che ha
definito "una storia nella storia": le numerose metamorfosi subite
attraverso il tempo dalla figura di Colomba Antonietti, divenuta di
volta in volta la donna che la società preferiva vedere in lei. Si
riuscì persino a mortificare il suo sacrificio riducendola a una
ragazza incosciente e impulsiva che era morta semplicemente perché
aveva deciso di andare a incontrare il marito sul campo di
battaglia. La polemica era portata avanti soprattutto da chi, come
scrive l’autrice, "non poteva ammettere in una donna azioni e
sentimenti considerati tipicamente maschili. In poche parole, una
donna non deve travalicare i limiti che le ha imposto la natura e
che sono quelli di figlia obbediente, madre e sposa fedele".
La
giornalista Annalisa Venditti, docente della Pontificia Università
Urbaniana, ha letto alcuni brani del volume, a cominciare dalle note
introduttive, in cui la Dal Maso spiega come ci sia "ancora una
storia in gran parte da scrivere, quella delle tante donne, di tutte
le classi sociali, che diedero il loro contributo alla difesa di
Roma. La storiografia ufficiale ha tentato di seppellirle sotto il
velo dell’oblio, oppure di sminuirne l’importanza". Un altro
passaggio importante del libro è quello che analizza i pochi reperti
provenienti dalla tomba di Colomba Antonietti in San Carlo ai
Catinari. "Dopo aver preso in esame questi oggetti nel loro insieme
– continua Cinzia Dal Maso – credo di poter ipotizzare che siano
stati posti con uno scopo ben preciso. Costituirebbero una sorta di
epigrafe crittografata per rendere riconoscibile il corpo anche a
distanza di molto tempo. I reperti andrebbero letti così: Colomba
Porzi (il bottone con le iniziali C.P.), moglie di Luigi (la
medaglietta con San Luigi), morta il 13 giugno (la medaglietta con
Sant’Antonio, che si festeggia quel giorno), alla Madonna dei Sette
Dolori (il medaglione)".
La
seconda parte del volume è dedicata alle donne della Repubblica
Romana, da quelle che combatterono in prima fila come Colomba
Antonietti a quelle impegnate nell’organizzazione del soccorso ai
feriti.
di
Alessandro Venditti |
|
Il Risorgimento dei
romani |
|
L’audace
Righetto
 Da
qualche anno sul Gianicolo, tra i monumenti agli eroi del
Risorgimento, c’è una nuova, importante memoria: la statua di
Righetto, copia in bronzo di Pasquale Nava del marmo eseguito nel
1851 da Giovanni Strazza e conservato nel palazzo Litta di Milano.
E’ un omaggio ai tanti ragazzini che sacrificarono la loro vita
nella difesa della Repubblica Romana del 1849 ed è raffigurato a
torso nudo, con un paio di calzoncini laceri, il braccio sinistro
alzato dopo aver strappato la miccia a una bomba. Tra le sue gambe è
una vispa cagnolina, sua compagna di avventura e di sventura. Da
qualche anno sul Gianicolo, tra i monumenti agli eroi del
Risorgimento, c’è una nuova, importante memoria: la statua di
Righetto, copia in bronzo di Pasquale Nava del marmo eseguito nel
1851 da Giovanni Strazza e conservato nel palazzo Litta di Milano.
E’ un omaggio ai tanti ragazzini che sacrificarono la loro vita
nella difesa della Repubblica Romana del 1849 ed è raffigurato a
torso nudo, con un paio di calzoncini laceri, il braccio sinistro
alzato dopo aver strappato la miccia a una bomba. Tra le sue gambe è
una vispa cagnolina, sua compagna di avventura e di sventura.
Di
Righetto si sa molto poco. Aveva dodici anni, era biondo e
mingherlino ed era rimasto orfano. I bottegai di Trastevere gli
affidavano delle piccole commissioni, facendogli guadagnare qualcosa
per sopravvivere. Sembra che una volta avesse perfino trovato lavoro
da un macellaio. Ma quando questi gli diede uno schiaffone per non
si sa quale mancanza, Righetto gli tirò lo schifo e scappò via.
Arrivarono i giorni dell’assedio di Oudinot a Roma. I cannoni
battevano in breccia le mura gianicolensi e le bombe cadevano nel
cuore della città, portando morte e distruzione. Il comportamento
dei romani, però, era di una compostezza e di un coraggio
incredibili. Scriveva Garibaldi ad Anita in una lettera del 21
giugno: "qui le donne e i ragazzi corrono addietro alle palle e
bombe gareggiandone il possesso".
"L'intervallo medio, tra la caduta e l'esplosione, era di 10 a 12
minuti secondi", spiegava Gustav von
Hoffstetter. "Non saprei a quale dei due motivi attribuire, se
all'audacia o all'ignoranza del pericolo, il precipitarsi che faceva
la nostra gente sur una bomba, per soffocarla, allorché essa ardeva
alcuni secondi più del solito. Molte bombe ci furono in tal modo
portate, aventi la spoletta o ricacciata dentro, o strappata, o
tagliata via. Per ognuna si pagava uno scudo". Naturalmente
Righetto era tra i più svelti a gettarsi sulle bombe per soffocarle
con uno straccio bagnato. Un giorno, mentre stava con alcuni suoi
compagni vicino a piazza Mastai, un ordigno cadde proprio vicino a
lui. Accorse immediatamente per spegnerlo, ma quello esplose in un
inferno di fumo e schegge, dilaniando anche quella che era ormai
tutta la sua famiglia, la fedele cagnetta Sgrullarella. Il ragazzo
fu raccolto in condizioni disperate. Era impossibile portarlo al
Santo Spirito: troppe le bombe che piovevano sulla strada per
l’ospedale. Il medico Romano Feliciani gli prestò le prime cure,
quindi lo fece condurre prima nella sua abitazione di via Sistina e
poi in via Belsiana, presso una vecchietta caritatevole, una certa
Marta Ranieri. Il ragazzo, però, era orrendamente mutilato e spirò
dopo alcune settimane tra grandi sofferenze.
di
Cinzia Dal
Maso
|
|
Il Risorgimento dei
romani |
|
Augusto
Castellani
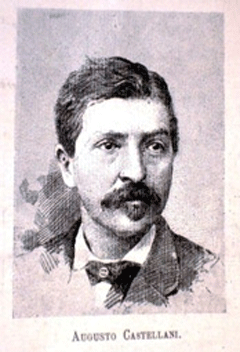 Augusto
Castellani era figlio di Fortunato e di Carolina Baccani e fratello
di Alessandro. Nato a Roma l’11 gennaio del 1829, si dedicò agli
studi classici, ma anche all’oreficeria, seguendo le orme paterne.
Tutta la sua vita fu caratterizzata da un fortissimo attaccamento
alla religione cattolica. Divenuto Papa Pio IX, nel 1846, lo
considerò una guida per la rinascita della nazione, secondo le
teorie giobertiane. L’anno seguente si arruolò, giovanissimo, nella
guardia civica. Le sue idee non gli permettevano di accettare i
principi della Repubblica Romana, eppure partecipò attivamente alla
sua difesa come artigliere, distinguendosi soprattutto nei
combattimenti del 3 giugno.
Entrati
i francesi a Roma, fu accusato di aver partecipato a un tumulto il
15 luglio del 1849 e incarcerato insieme con il fratello Alessandro.
Il padre dopo qualche giorno li fece liberare entrambi grazie alle
sue conoscenze e ai suoi mezzi economici. Augusto si dedicò con
tutte le sue energie al laboratorio di oreficeria, di cui nel 1851
divenne direttore amministrativo.
Sposò
la figlia di Filippo Farina, ministro del governo pontificio,
suscitando un certo scalpore nell’ambiente liberale romano.
Si
riaccostò alla politica dopo la dimissione del fratello dal
manicomio criminale, aderendo però alle idee monarchiche. Si
opponeva, seppur larvatamente, al potere temporale del Pontefice,
che riteneva responsabile dei problemi economici dello stato.
Dopo la
breccia di Porta Pia fece parte di una Giunta provvisoria del
governo italiano, all’interno della quale si oppose all’acceso
anticlericalismo di alcuni, pur nella convinzione della necessità di
una netta separazione tra Stato e Chiesa.
Fece
parte della delegazione incaricata di consegnare a Vittorio Emanuele
II i risultati del plebiscito del 2 ottobre 1870, quindi divenne
direttore del Museo Capitolino.
Dal
1883 al 1890 e dal 1895 al 1907 fece parte del consiglio comunale di
Roma, rimanendo in ombra a causa del rigore del suo comportamento
che lo faceva estraniare da quelli che riteneva giochi di potere.
Nel
1903 fu nominato cavaliere del lavoro, mentre però era costretto a
ridurre la sua attività di orafo a causa di una contrazione del
volume di affari. Morì nella sua amata città il 23 gennaio del 1914,
nel palazzo di piazza Fontana di Trevi. Venne seppellito al Pincetto
vecchio del Verano, in quella tomba di famiglia che si era fatto
costruire già dal 1865, una cappella rotonda adorna di antefisse
antiche e nella quale avrebbe voluto fossero inumati tutti i
collaboratori del suo laboratorio di oreficeria.
di
Cinzia Dal
Maso
|
|
Il Risorgimento dei
romani |
|
Alessandro Castellani
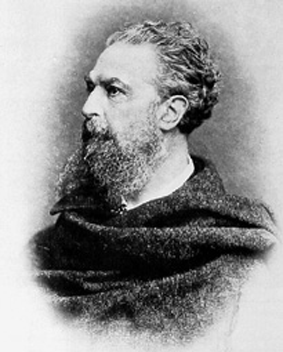 Alessandro
Castellani era nato a Roma il 2 febbraio del 1823 dal famoso orafo e
antiquario Fortunato Pio e da Carolina Baccani. All’età di tredici
anni aveva perso la mano sinistra in un incidente di caccia, ma
questo non gli impedì di dedicarsi, insieme con il fratello minore
Augusto, all'arte paterna, applicandosi alla preparazione dei
disegni. All’amore per il lavoro aggiunse quello per la politica e
fin dal 1847, seguendo gli ideali repubblicani e democratici, fece
parte del progressista Circolo popolare. Durante la breve esperienza
della Repubblica romana partecipò a una commissione per la scelta
degli impiegati governativi. Alessandro
Castellani era nato a Roma il 2 febbraio del 1823 dal famoso orafo e
antiquario Fortunato Pio e da Carolina Baccani. All’età di tredici
anni aveva perso la mano sinistra in un incidente di caccia, ma
questo non gli impedì di dedicarsi, insieme con il fratello minore
Augusto, all'arte paterna, applicandosi alla preparazione dei
disegni. All’amore per il lavoro aggiunse quello per la politica e
fin dal 1847, seguendo gli ideali repubblicani e democratici, fece
parte del progressista Circolo popolare. Durante la breve esperienza
della Repubblica romana partecipò a una commissione per la scelta
degli impiegati governativi.
Restaurato il governo pontificio, il 16 luglio del 1849 Alessandro
fu arrestato insieme con il fratello Augusto e rilasciato dopo pochi
giorni, grazie a una forte somma sborsata dal padre. Rimase comunque
in contatto con l'ambiente repubblicano dei mazziniani. Nell'agosto
del 1853, Alessandro fu tra i numerosi arrestati con l’accusa di
cospirazione, ma nel gennaio 1854 – nelle carceri del San Michele –
diede segni di un grave squilibrio mentale. Rimase in manicomio fino
al 1856, quando venne affidato alla responsabilità dei familiari.
Ricominciò a lavorare nell'azienda di famiglia. Ma le autorità
papali lo facevano controllare dalla polizia e quando ritennero che
fosse guarito gli imposero di scegliere se tornare in prigione o
andare in esilio. Così, nel giugno del 1860 Alessandro si trasferì a
Parigi, dove aprì, ai Champs Elysées, una succursale dell’oreficeria
paterna che riscosse un notevole successo. Nel 1862 iniziò un
proficuo commercio di oggetti d'arte che lo rese famoso. In quello
stesso anno si stabili a Napoli dove fondò una scuola di oreficeria,
occupandosi anche di arte ceramica.
Napoleone III riuscì a farlo graziare dall’esilio, ma Alessandro non
volle tornare nella sua città, preferendo cospirare da lontano.
Rientrò a Roma solo dopo la breccia di Porta Pia, nel 1870. Fu anche
proposto dai democratici come candidato alle elezioni generali per
la Camera, ma con la sua ferma rinuncia suscitò grande clamore.
Ancora
nel 1870 fece parte della Commissione per la tutela dei monumenti a
Roma, quindi, nel 1872, fu a capo della commissione promotrice del
comizio al Colosseo per sostenere l'introduzione del suffragio
universale.
Fu lui
ad elaborare il progetto, che tanto piaceva a Garibaldi, di deviare
il corso del Tevere per liberare la città dal pericolo di
inondazioni e per ritrovare i reperti archeologici che giacevano sul
letto del fiume. Nel marzo del 1879 fu eletto presidente
dell'Associazione repubblicana dei diritti dell'uomo.
Colpito
da gravi attacchi d’asma, Alessandro morì nella villa Vecchioni a
Portici il 9 giugno 1883. Secondo la sua volontà, la salma fu
portata a Roma, cremata e seppellita in terra libera, senza immagini
né lampade.
di
Cinzia Dal
Maso |
|
Il Risorgimento dei romani |
|
Gaetano Tognetti
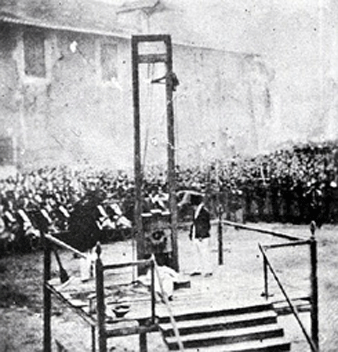 Il
22 ottobre 1867 una terribile esplosione risuonò per le vie e le
piazze di Roma: una mina aveva fatto saltare in aria una parte della
caserma Serristori, uccidendo 23 zuavi pontifici e 5 ignari
cittadini che si trovavano a passare in quella parte di Borgo. A
seguito di una delazione, furono accusati dell’attentato due giovani
muratori: Giuseppe Monti, di Fermo, trentatreenne, sposato e con un
figlio piccolo, e Gaetano Tognetti, un romano di appena ventitré
anni, che con il suo lavoro manteneva i genitori e quattro fratelli
più piccoli. Nel processo che seguì, il giudice inquirente calcò la
mano sul fatto che i due imputati erano poverissimi e vivevano delle
loro braccia meschinamente, quindi avevano un movente per
abbracciare il partito del disordine. Condannati a morte, i due
patrioti rimasero in carcere 13 mesi, quindi, il 24 novembre del
1868, all’alba, vennero portati su un cocchio chiuso in piazza dei
Cerchi, presso il Velabro, dove era stato montato il palco con la
ghigliottina. Mastro Titta, il famigerato boia di Roma, era ormai in
pensione da qualche anno. Lo sostituiva un suo aiutante, Antonio
Balducci, che indossava – come di consueto – una veste scarlatta. Ad
assistere allo spettacolo un folto gruppo di zuavi, ma non il
popolo, tenuto lontano. Monti, che volle salire sul palco scalzo, fu
giustiziato alle 7. Stessa sorte toccò a Tognetti, appena due minuti
dopo. Il boia raccolse le due teste e, tenendole per i capelli, le
mostrò agli zuavi, che fecero rullare i loro tamburi: questa fu
l’ultima esecuzione dello Stato Pontificio, a meno di due anni dalla
breccia i Porta Pia. A Monti e Tognetti Giosuè Carducci dedicò una
vibrante lirica piena di rancore per Pio IX, al quale diceva, tra
l’altro: "Ma tu co ’l pugno di peccati onusto / Calchi a terra quei
capi, empio signor, / E sotto al sangue del paterno busto / De le
tenere vite affoghi il fior. / Tu su gli occhi de i miseri parenti /
(E son tremuli vegli al par di te) / Scavi le fosse a i figli ancor
viventi. / Chierico sanguinoso e imbelle re". Il
22 ottobre 1867 una terribile esplosione risuonò per le vie e le
piazze di Roma: una mina aveva fatto saltare in aria una parte della
caserma Serristori, uccidendo 23 zuavi pontifici e 5 ignari
cittadini che si trovavano a passare in quella parte di Borgo. A
seguito di una delazione, furono accusati dell’attentato due giovani
muratori: Giuseppe Monti, di Fermo, trentatreenne, sposato e con un
figlio piccolo, e Gaetano Tognetti, un romano di appena ventitré
anni, che con il suo lavoro manteneva i genitori e quattro fratelli
più piccoli. Nel processo che seguì, il giudice inquirente calcò la
mano sul fatto che i due imputati erano poverissimi e vivevano delle
loro braccia meschinamente, quindi avevano un movente per
abbracciare il partito del disordine. Condannati a morte, i due
patrioti rimasero in carcere 13 mesi, quindi, il 24 novembre del
1868, all’alba, vennero portati su un cocchio chiuso in piazza dei
Cerchi, presso il Velabro, dove era stato montato il palco con la
ghigliottina. Mastro Titta, il famigerato boia di Roma, era ormai in
pensione da qualche anno. Lo sostituiva un suo aiutante, Antonio
Balducci, che indossava – come di consueto – una veste scarlatta. Ad
assistere allo spettacolo un folto gruppo di zuavi, ma non il
popolo, tenuto lontano. Monti, che volle salire sul palco scalzo, fu
giustiziato alle 7. Stessa sorte toccò a Tognetti, appena due minuti
dopo. Il boia raccolse le due teste e, tenendole per i capelli, le
mostrò agli zuavi, che fecero rullare i loro tamburi: questa fu
l’ultima esecuzione dello Stato Pontificio, a meno di due anni dalla
breccia i Porta Pia. A Monti e Tognetti Giosuè Carducci dedicò una
vibrante lirica piena di rancore per Pio IX, al quale diceva, tra
l’altro: "Ma tu co ’l pugno di peccati onusto / Calchi a terra quei
capi, empio signor, / E sotto al sangue del paterno busto / De le
tenere vite affoghi il fior. / Tu su gli occhi de i miseri parenti /
(E son tremuli vegli al par di te) / Scavi le fosse a i figli ancor
viventi. / Chierico sanguinoso e imbelle re".
Il
monumento funebre di Gaetano Tognetti, voluto dalla famiglia del
giovane dopo il 1870, si trova al cimitero del Verano, nel riquadro
12 del Pincetto vecchio. E’ un sobrio cippo su base ottagonale.
Sulla fronte è l’iscrizione, mentre sugli altri tre lati è incisa
una corona di foglie di quercia. Sopra al cippo è sistemato un dado
che termina con delle fiamme, circondato da una corona bronzea di
foglie d’edera e di ulivo.
La
caserma Serristori c’è ancora, nonostante gli sventramenti che in
epoca fascista interessarono la cosiddetta "spina di Borgo". Il
palazzo tardo rinascimentale - costruito a partire dal 1565 da
Averardo Serristori (ambasciatore di Cosimo Medici presso Pio IV) e
in seguito acquistato dalla Camera Apostolica – nel 1870 fu occupata
dalle truppe italiane. Con i Patti Lateranensi tornò alla Santa Sede
e dal 1930, dopo la sistemazione di Alberto Calza Bini, è sede della
scuola pontificia Pio IX.
di
Cinzia Dal
Maso |
|
Il Risorgimento dei romani |
|
Lorenzo Maderazzi
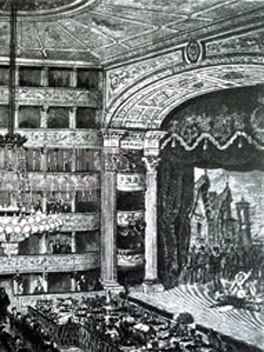 Felice Venosta,
nella sua biografia di Ciceruacchio, riferisce che nel 1849, durante la difesa
della Repubblica Romana, il tribuno fu, con Enrico Cernuschi, l’anima della
Commissione delle barricate. Spesso lavorò alla fortificazione delle porte, con
l’aiuto di "un tale Materassi, macchinista del teatro Apollo". Si tratta di
Lorenzo Maderazzi, nato alla fino del ‘700 e indicato nel Mercurio di Roma del
1843 come "Maresciallo del corpo dei vigili, macchinista teatrale", con
abitazione in via della Mola di San Giovanni de’ Fiorentini 19. Felice Venosta,
nella sua biografia di Ciceruacchio, riferisce che nel 1849, durante la difesa
della Repubblica Romana, il tribuno fu, con Enrico Cernuschi, l’anima della
Commissione delle barricate. Spesso lavorò alla fortificazione delle porte, con
l’aiuto di "un tale Materassi, macchinista del teatro Apollo". Si tratta di
Lorenzo Maderazzi, nato alla fino del ‘700 e indicato nel Mercurio di Roma del
1843 come "Maresciallo del corpo dei vigili, macchinista teatrale", con
abitazione in via della Mola di San Giovanni de’ Fiorentini 19.
Il suo lavoro era
talmente apprezzato che aveva eseguito il palcoscenico e tutto il meccanismo per
il teatro municipale di Alessandria.
L’8 settembre del
1846 aveva apprestato insieme con Agostino Tibaldi i legnami e le armature per
un arco trionfale temporaneo in onore di Pio IX che era stato posto allo sbocco
di via del Corso su piazza del Popolo. L’arco era stato disegnato da Felice
Cicconetti e l’impresa era diretta da Giuseppe Antonini, Ciceruacchio e Luigi
Paolelli.
Nel 1848 aveva
ottenuto da monsignor Savelli, insieme con altri capi del popolo, Ciceruacchio,
Piccioni, Bezzi, Filippo Meucci, Vinciguerra, il permesso di istituire il
"Circolo popolare". Felice Venosta, che lo definisce un "figlio del lavoro",
racconta una sua prodezza: era riuscito con grande facilità, per mezzo di una
sola corda, "avvolgendola attorno al sasso e gradatamente formandosene un
posapiede", a salire sulla cima dell’obelisco di piazza del Popolo, per
collocare sulla croce il berretto rosso.
Durante l’assedio
francese di Roma, Maderazzi, insieme con Ruggeri e Galiani, aveva requisito
un’ingente quantitativo di legname a un certo Annibaldi, per munire le
barricate, senza però un mandato scritto del triumvirato, allegando
semplicemente un ordine verbale di Garibaldi, che peraltro non era il comandante
supremo delle operazioni belliche. Nel 1852 l’Annibaldi si rivolse al Tribunale
della Rota per ottenere un risarcimento direttamente dal Maderazzi e dai suoi
compagni, sostenendo che la mercanzia era stata tolta dal magazzino "senza
neppure rilasciargli una carta la quale dicesse quanto, da chi, in qual giorno,
per quale comando, per qual prezzo e per quale uso venisse asportala".
La difesa dei "rei
convenuti" era affidala all’avvocato Calatili, che provò come il legname fosse
stato portato effettivamente in vari luoghi della città dove si costruivano le
barricate. Il legale sostenne inoltre che l’ordine scritto dei triumviri non era
necessario, poiché "ordinata la difesa di una città, s’intendeva data ai
comandanti la facoltà di richiedere quello che era utile, o necessario".
Inoltre, "ognuno dei comandanti, a meno che le sue facoltà non siano state
espressamente ristrette, deve fare tutto quello che tende a terminare presto la
guerra, ed a trionfare, né contrae responsabilità alcuna verso i privati chi
obbedisce a tali comandi".
L’istanza
dell’Annibaldi fu rigettata.
di
Cinzia Dal
Maso
|
|
Il Risorgimento dei Romani |
|
Alessandro Calandrelli, eroe del
trenta aprile
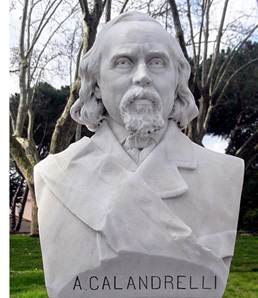 Alessandro
Calandrelli era nato a Roma l’8 ottobre 1805 da Giovanni, incisore di pietre
preziose, e Maria Borelli. Entrò giovanissimo nell’artiglieria pontificia e
diventò cadetto prima ancora di compiere 13 anni, primo atto di una brillante
carriera militare. Alessandro
Calandrelli era nato a Roma l’8 ottobre 1805 da Giovanni, incisore di pietre
preziose, e Maria Borelli. Entrò giovanissimo nell’artiglieria pontificia e
diventò cadetto prima ancora di compiere 13 anni, primo atto di una brillante
carriera militare.
Nel 1836 scrisse
una Memoria sull’artiglieria pontificia e l’anno seguente fu nominato professore
presso la Scuola dei cadetti d’artiglieria. Mentre era di stanza a Civitavecchia
rivelò anche le sue doti di studioso, con una Memoria sul castello di Santa
Severa e la decifrazione e la raccolta di antiche iscrizioni. Nel 1842 rilevò la
pianta della piazza fortificata di Civitavecchia e studiò le possibilità di
difesa della maremma toscana. Dopo il 1847 ottenne una medaglia d’oro di
benemerenza per il Regolamento del vestiario
della Guardia civica.
Nel novembre del
1848, dopo l’assassinio di Pellegrino Rossi e la fuga di Pio IX, Alessandro,
ormai capitano, aderì al governo provvisorio, diventando ben presto maggiore.
Nel gennaio dell’anno seguente venne eletto deputato dell’Assemblea costituente.
Proclamata la Repubblica Romana, ne fu prima sostituto del ministro della Guerra
e della Marina, quindi ministro interno. La sua preparazione e la sua esperienza
lo portarono a studiare una serie di provvedimenti per rendere più efficiente un
esercito scarsamente preparato dal punto di vista militare, composto da gruppi
volontari. Secondo il Calandrelli la legione Garibaldi aveva una crescita
incontrollata e vi si inserivano elementi indisciplinati in grado di provocare
disordini di vario tipo. La sua proposta all’Assemblea di aumentare gli
effettivi dell’esercito attraverso la coscrizione obbligatoria degli uomini dai
18 ai 36 anni fu respinta e la polemica che ne seguì provocò la sua messa in
disparte dalla vita politica repubblicana.
Durante l’assedio
francese della città, il suo contributo fu prezioso e nell’epica battaglia del
30 aprile, nella quale gli uomini del generale Oudinot furono sconfitti e
respinti, si guadagnò una medaglia d’oro al valor militare. Nei giorni di
euforia che seguirono, il cantastorie cieco Tarantoni girava per le strade di
Trastevere con la sua chitarra cantando una semplice canzoncina i cui versi
suonavano così: "Ciavemo Garibbardi / Ciavemo
Calandrella/ sti boja de francesi/ nun so potuti entrà/ l’emo respinti indietro
/ nun ponno aritornà".
I francesi, però,
sarebbero tornati, eccome, più forti e agguerriti di prima, tradendo la tregua
di Lesseps. Calandrelli, che fin dal 17 maggio era stato nominato, con il grado
di colonnello, direttore generale delle fortificazioni, si distinse nella
battaglia del 22 giugno, dirigendo l’artiglieria per impedire che gli assalitori
rafforzassero le posizioni conquistate il giorno precedente. Ma le sorti della
Repubblica erano ormai segnate. Il 1° luglio il triumvirato composto da Mazzini,
Saffi e Armellini si sciolse e se ne costituì uno nuovo, di cui facevano parte,
oltre ad Alessandro Calandrelli, Livio Mariani e Aurelio Saliceti.
Una volta
ristabilito il governo pontificio, Alessandro subì gravissime accuse di furto,
incettazione e concussione. Nel processo che ne seguì, nonostante si proclamasse
innocente, fu condannato a numerosi anni per furto e a morte per alto
tradimento. Nell’agosto del 1851 Pio IX mutò tutte le sue pene in 20 anni di
carcere ad Ancona. Da qui, a settembre, scriveva alla sorella: "Oggi son povero,
abbandonato e non possedo in mia tasca che 36 baiocchi...ecco il frutto dei miei
furti..."
Persino il re di
Prussia Federico Guglielmo IV si adoperò per il rilascio del Calandrelli, che
tuttavia dovette rimanere in carcere per due anni. Finalmente il 15 giugno del
1853 il Pontefice gli commutò la pena in esilio perpetuo, permettendogli di
riunirsi al padre e al fratello Ludovico che si trovavano a Berlino. Qui
Alessandro si guadagnò da vivere dando lezioni di italiano. Tra i suoi allievi
il naturalista e geografo Alexander von Humbold e Ferdinand Lassalle, che negli
anni a seguire sarebbe diventato leader del movimento operaio tedesco. Si sposò
con Emilia Reineke, che gli diede tre figli.
Solo dopo la
breccia di Porta Pia poté tornare a Roma. Era il 2 ottobre del 1870. Divenne
Consigliere del Circolo romano e prese parte attiva alla vita politica. Trovò un
modesto ma dignitoso impiego come ispettore edilizio del Comune. Nel 1871 iniziò
anche a collaborare saltuariamente con il quotidiano "Il Tribuno".
Si iscrisse alla
Società dei reduci delle patrie battaglie, fece parte della Commissione per le
onoranze Mazzini e di un’altra incaricata di individuare i nomi dei Romani
caduti durante il Risorgimento. Nel 1884 si ritirò ad Albano, dove morì il 7
febbraio 1888.
di
Cinzia Dal Maso
|
|
Il Risorgimento
dei romani |
|
Giovanni
Cherubini
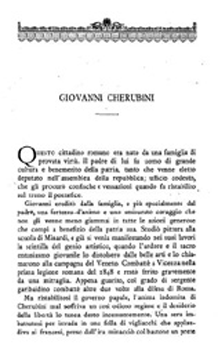 Annibale
Lucatelli nel suo prezioso volume "Carità di patria - Ai fratelli
dimenticati - Ricordo" traccia un toccante profilo di un eroico
romano, Giovanni Cherubini, cui il padre, uomo di grande cultura,
aveva trasmesso l’amore per la patria e la libertà. Giovanni
studiava pittura con buoni risultati presso Tommaso Minardi,
professore all’accademia di San Luca, quando decise di partire per
la campagna del Veneto. Combatté a Vicenza nel 1848, rimanendo
gravemente ferito dalla mitraglia. Riuscì a guarire, potendo così
partecipare, l’anno seguente, alla difesa della Repubblica Romana,
della cui assemblea il padre era stato eletto deputato. Annibale
Lucatelli nel suo prezioso volume "Carità di patria - Ai fratelli
dimenticati - Ricordo" traccia un toccante profilo di un eroico
romano, Giovanni Cherubini, cui il padre, uomo di grande cultura,
aveva trasmesso l’amore per la patria e la libertà. Giovanni
studiava pittura con buoni risultati presso Tommaso Minardi,
professore all’accademia di San Luca, quando decise di partire per
la campagna del Veneto. Combatté a Vicenza nel 1848, rimanendo
gravemente ferito dalla mitraglia. Riuscì a guarire, potendo così
partecipare, l’anno seguente, alla difesa della Repubblica Romana,
della cui assemblea il padre era stato eletto deputato.
Ristabilitosi il governo papale, una sera si imbatté per strada in
un folto gruppo di persone che applaudiva i francesi. Giovanni fu
colto dall’ira e minacciò con un bastone uno dei manifestanti, il
curato della Madonna dei Monti, poi, sapendo che il suo gesto non
sarebbe rimasto senza conseguenze, fuggì fuori dai confini dello
stato. Il tribunale lo condannò in contumacia a cinque anni di
carcere. Poiché la polizia pontificia, non riuscendo a mettere le
mani su di lui, aveva arrestato il padre con l’accusa di complicità
nel sacrilego gesto, Giovanni si vide costretto a tornare a Roma e a
scontare la sua pena per intero. Una volta liberato ebbe una parte
attiva nelle sommosse del 1859, guadagnandosi altri due arresti. Nel
1865 fu di nuovo costretto a emigrare e si trasferì a Terni, dove
rimase finché l’appello di Garibaldi non lo spinse a combattere di
nuovo. Nel 1867 partecipò alla campagna dell’Agro romano per la
liberazione di Roma. A Monterotondo si spinse fin sotto le porte
della città per incendiarle, incurante dei proiettili nemici. A
Mentana, racconta Lucatelli, "esaurì le munizioni dopo brevissimo
tempo, e sotto una pioggia di palle sottrasse cartucce dalla sacca
dei suoi compagni caduti e seguitò a sparare, ma quando non vi fu
più né tempo né mezzo di continuare, afferrò la carabina per la
canna e menò colpi violentissimi da tutte le parti come una belva
inferocita, mentre la faccia gli grondava sangue e le vesti erano
tutte lacere". Anche il fucile si ruppe, allora combatté con la
daga, poi, nel corpo a corpo, con pugni e morsi. All’altezza di
villa Santucci una scarica di mitraglia gli spezzò un ginocchio e lo
fece cadere. Gli zuavi gli furono addosso, lo crivellarono di ferite
e gli cavarono gli occhi con la baionetta, "sino a che quel forte
non spirò ruggendo come un leone". Lasciava la moglie e un figlio,
che fu educato nel collegio militare di Torino a spese di Vittorio
Emanuele II.
Di
Giovanni Cherubini si è parlato a Nuova Spazio Radio (88.100 MHz), a
"Questa è Roma", il programma ideato e condotto da Maria Pia
Partisani, in studio con Livia Ventimiglia il martedì dalle 14 alle
15 e in replica il sabato dalle 10 alle 11.
di
Cinzia Dal
Maso
|
|
Il Risorgimento dei
romani |
|
Annibale
Lucatelli
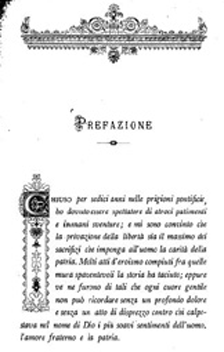 Annibale
Lucatelli era il fratello di Cesare, giustiziato il 21 settembre del
1861 a piazza Bocca della Verità. Anch’egli fervente patriota, era
nato a Roma il 5 novembre 1827. Nel 1848 partì volontario per la
prima guerra d’Indipendenza e fu ferito nella difesa di Treviso.
L’anno seguente si batté per la Repubblica Romana e dopo la caduta
di quest’ultima fuggì a Genova. Nel 1853 tornò clandestinamente a
Roma per preparare un moto rivoluzionario e fu arrestato. Durante il
processo davanti alla Sacra Consulta che ne seguì, tentò invano di
difendersi sostenendo che la sua presenza a Roma era dovuta a motivi
di cuore. Lui e Augusta Castellani, infatti, sarebbero stati
innamorati. Dopo la partenza di Annibale, la giovane si sarebbe
ammalata per il dolore e sua madre Carolina avrebbe finalmente dato
il suo consenso al matrimonio. Non venne creduto e la condanna fu
pesantissima: il carcere a vita, in seguito commutato in 20 anni di
prigione. Una violenta rivolta nel carcere di Paliano gli valse una
nuova condanna all’ergastolo. Fu liberato nel 1869 e mandato in
esilio. Poté tornare a Roma solo dopo il 20 settembre del 1870,
riprendere la sua arte di mosaicista e formarsi una famiglia. Nel
1871 il principe Umberto gli donò duemila lire, una sorta di
risarcimento delle tante sofferenze patite per il suo patriottismo. Annibale
Lucatelli era il fratello di Cesare, giustiziato il 21 settembre del
1861 a piazza Bocca della Verità. Anch’egli fervente patriota, era
nato a Roma il 5 novembre 1827. Nel 1848 partì volontario per la
prima guerra d’Indipendenza e fu ferito nella difesa di Treviso.
L’anno seguente si batté per la Repubblica Romana e dopo la caduta
di quest’ultima fuggì a Genova. Nel 1853 tornò clandestinamente a
Roma per preparare un moto rivoluzionario e fu arrestato. Durante il
processo davanti alla Sacra Consulta che ne seguì, tentò invano di
difendersi sostenendo che la sua presenza a Roma era dovuta a motivi
di cuore. Lui e Augusta Castellani, infatti, sarebbero stati
innamorati. Dopo la partenza di Annibale, la giovane si sarebbe
ammalata per il dolore e sua madre Carolina avrebbe finalmente dato
il suo consenso al matrimonio. Non venne creduto e la condanna fu
pesantissima: il carcere a vita, in seguito commutato in 20 anni di
prigione. Una violenta rivolta nel carcere di Paliano gli valse una
nuova condanna all’ergastolo. Fu liberato nel 1869 e mandato in
esilio. Poté tornare a Roma solo dopo il 20 settembre del 1870,
riprendere la sua arte di mosaicista e formarsi una famiglia. Nel
1871 il principe Umberto gli donò duemila lire, una sorta di
risarcimento delle tante sofferenze patite per il suo patriottismo.
Nel
1889 scrisse un volume in collaborazione con Leopoldo Micucci,
"Carità di Patria - Ai fratelli dimenticati – Ricordo". Così si
legge nella prefazione: "Chiuso per sedici anni nelle prigioni
pontificie, ho dovuto essere spettatore di atroci patimenti e immani
sventure; e mi sono convinto che la privazione della libertà sia il
massimo dei sacrifizi che imponga all’uomo la carità della patria.
Molti atti d’eroismo compiuti fra quelle mura spaventevoli la storia
ha taciuto; eppure ve ne furono di tali che ogni cuore gentile non
può ricordare senza un profondo dolore e senza un atto di disprezzo
contro chi calpestava nel nome di Dio i più soavi sentimenti
dell’uomo, l’amore fraterno e la patria. A coloro che appena oggi si
rammentano è rivolto questo libro, e alla loro memoria consacrato. A
me pareva ingiusto partirmi da questo mondo senza lasciare una
notizia di loro, ed è perciò che mi sono prefisso di scoprire le
loro tombe, e consegnare al cuore dei giovani tanto sacri ricordi".
Annibale morì nella sua città il 27 giugno del 1909. Suo figlio
Luigi (1877 – 1915) scrisse romanzi, novelle, articoli di
archeologia e resoconti di guerra. Divenne famoso negli ultimi anni
della sua breve vita pubblicando "pubbliche proteste" sul giornale
satirico "Il Travaso delle idee", con lo pseudonimo di Oronzo E.
Marginati.
di
Cinzia Dal
Maso |
|
Il Risorgimento dei
romani |
|
Un
anniversario quasi dimenticato
 In
questo anno di celebrazioni patriottiche più o meno sentite, ma
sempre molto ostentate, quanti saranno quelli che oggi si
ricorderanno di portare un fiore sulla tomba di Cesare Lucatelli,
nel centocinquantesimo anniversario della sua decapitazione? La
mattina del 21 settembre del 1861 in piazza Bocca della Verità
Giovanni Battista Bugatti, meglio conosciuto come Mastro Titta,
eseguì l’atto finale di un processo che aveva fatto discutere
l’Italia intera. Scriveva il fratello Annibale: "l’indignazione per
tanta barbarie fu generale, e non vi fu animo pietoso che con le
parole o con gli scritti non facesse omaggio alla memoria del
martire... Nel 1870 poi, alcuni giorni dopo la liberazione di Roma,
a cura dei patrioti romani, fu eretto in campo Verano un modesto
monumento alla memoria di Lucatelli. L’opera scultoria dei fratelli
Saraceni, riuscì un capo lavoro. Semplice, ma spontaneo n’è il
concetto, e profondamente vero. Se non vi fosse incisa parola
alcuna, quel marmo da sé basterebbe a narrare un sacrifizio, una
vendetta, un eroismo, una storia insomma che rabbrividisce ed
infiamma ad un tempo". Il monumento ricorda ancora ai rarissimi e
spesso distratti visitatori del Pincetto vecchio una storia ormai
lontana, eppure per anni è stato meta di un vero pellegrinaggio.
Continuava Annibale: "non passa giorno che non vi vegga qualche
pietoso ginocchioni a piè del monumento, e che non si trovi scritto
con la matita sul marmo qualche parola di ammirazione o di encomio
alla memoria del patriota. Fra l’altre vi fu scritta una volta
un’aurea sentenza tolta da una canzone popolare romana: Chi per la
patria muore, non muore mai. Un bel morir tutta la vita onora". In
questo anno di celebrazioni patriottiche più o meno sentite, ma
sempre molto ostentate, quanti saranno quelli che oggi si
ricorderanno di portare un fiore sulla tomba di Cesare Lucatelli,
nel centocinquantesimo anniversario della sua decapitazione? La
mattina del 21 settembre del 1861 in piazza Bocca della Verità
Giovanni Battista Bugatti, meglio conosciuto come Mastro Titta,
eseguì l’atto finale di un processo che aveva fatto discutere
l’Italia intera. Scriveva il fratello Annibale: "l’indignazione per
tanta barbarie fu generale, e non vi fu animo pietoso che con le
parole o con gli scritti non facesse omaggio alla memoria del
martire... Nel 1870 poi, alcuni giorni dopo la liberazione di Roma,
a cura dei patrioti romani, fu eretto in campo Verano un modesto
monumento alla memoria di Lucatelli. L’opera scultoria dei fratelli
Saraceni, riuscì un capo lavoro. Semplice, ma spontaneo n’è il
concetto, e profondamente vero. Se non vi fosse incisa parola
alcuna, quel marmo da sé basterebbe a narrare un sacrifizio, una
vendetta, un eroismo, una storia insomma che rabbrividisce ed
infiamma ad un tempo". Il monumento ricorda ancora ai rarissimi e
spesso distratti visitatori del Pincetto vecchio una storia ormai
lontana, eppure per anni è stato meta di un vero pellegrinaggio.
Continuava Annibale: "non passa giorno che non vi vegga qualche
pietoso ginocchioni a piè del monumento, e che non si trovi scritto
con la matita sul marmo qualche parola di ammirazione o di encomio
alla memoria del patriota. Fra l’altre vi fu scritta una volta
un’aurea sentenza tolta da una canzone popolare romana: Chi per la
patria muore, non muore mai. Un bel morir tutta la vita onora".
Purtroppo la tomba giace oggi nel più totale abbandono, sporca, con
la pietra di chiusura spezzata. Persino il modesto vaso di
terracotta per i fiori è rotto.
di
Cinzia Dal
Maso |
|
IL RISORGIMENTO DEI
ROMANI |
|
Il patriota romano Cesare Lucatelli
 Cesare
Lucatelli Cesare
Lucatelli
era nato a Roma il 20 aprile 1823. Il padre Antonio, brigadiere dei dragoni
pontifici e capo dei domatori di cavalli, ossia caposcozzone, appassionato di
storia romana, aveva chiamato i suoi primi figli Cesare, Augusto e Annibale e
aveva trasmesso loro l’amore per la libertà e l’indipendenza nazionale.
Nel
marzo del 1848 Cesare e Annibale si arruolarono volontari nel battaglione
universitario partecipando alla I guerra d’Indipendenza. Una volta tornati a
Roma, furono tra i difensori della Repubblica Romana e in seguito militarono
nell’Associazione nazionale mazziniana.
Cesare, nonostante
avesse studiato l’arte del mosaico e dell’incisione dei cammei, si mise a fare
l’oste. Il suo carattere impulsivo iniziò a procurargli seri problemi. Nel 1851
il Consiglio di guerra francese lo condannò a quattro mesi di prigione per una
rissa scoppiata con alcuni soldati che avevano mangiato nella sua osteria senza
pagare il conto.
Nell’agosto del
1853 fu coinvolto, insieme con Annibale, in un tentativo di insurrezione a Roma.
Scoperta la congiura, i due fratelli dovettero affrontare un complicato
processo, durante il quale si impegnarono a non compromettere gli amici. Cesare
fu condannato a 10 anni di reclusione e Annibale all’ergastolo, pene in seguito
fortemente ridotte. Alla fine del 1856 Cesare poteva tornare in libertà e
riprendere l’attività di oste, che però dovette presto abbandonare a seguito del
rincaro del vino.
Nel 1860 lavorava
come facchino per la ferrovia Roma-Civitavecchia, ma una lite con un collega gli
costò un altro mese di galera. Continuava il suo impegno politico, partecipando
a manifestazioni contro il governo pontificio, fino a quella tragica del 29
giugno 1861. Durante la festa per i santi patroni di Roma, all’improvviso, su un
edificio in costruzione a piazza San Carlo al Corso furono illuminati due grandi
quadri trasparenti raffiguranti Vittorio Emanuele II e Napoleone III, mentre
dalle basi delle colonne della chiesa vennero incendiati dei bengala bianchi,
rossi e verdi. Nella confusione che ne seguì, dodici gendarmi provenienti da via
della Croce cominciarono a caricare la folla, imitati da altri gendarmi di
guardia al Corso e coadiuvati da quaranta uomini del tenete Naselli, che
menavano colpi di sciabola alla cieca. Solo l’intervento della gendarmeria
francese evitò una strage. Un tale Francesco Velluti, capopattuglia dei gendarmi
pontifici, fu raggiunto sotto palazzo Ruspoli da una pugnalata alla
 coscia
sinistra e da una al basso ventre. Il Lucatelli, ferito alla testa e all’addome
dai gendarmi pontifici, fu arrestato come presunto aggressore. Intanto il
Velluti, ricoverato al San Giacomo, cessava di vivere. coscia
sinistra e da una al basso ventre. Il Lucatelli, ferito alla testa e all’addome
dai gendarmi pontifici, fu arrestato come presunto aggressore. Intanto il
Velluti, ricoverato al San Giacomo, cessava di vivere.
Al processo tutto
fu contro Cesare: 9 testimoni a carico, nessuno a discarico. Il difensore
d’ufficio tentò senza successo di sostenere una rissa tra più persone e
l’ubriachezza del suo assistito. Fu ritenuta l’arma del delitto un coltello
trovato in terra al Corso, la cui lama, però, non corrispondeva con la natura
delle ferite sul corpo del Velluti. Si accusò il Lucatelli di essersi vestito
con i colori della bandiera italiana,ma egli rispose di avere un unico paio di
pantaloni d’estate, bianchi. La camicia, comperata usata, era a strisce bianche
e rosso cupo. Quanto alla fascia verde che avrebbe portato alla vita, non era
altro che la cinta della divisa dei facchini, con tre fibbie sulla pancia e di
colore nero, che i ripetuti lavaggi avevano reso verdastra.
La sentenza fu
unanime: condanna a morte per omicidio "con animo deliberato, e per ispirito di
parte". Vani tutti i tentativi di ottenere la grazia. Inutili furono gli sforzi
per salvarlo. L’esule pontificio Giacomo Castrucci tentò perfino di
autoaccusarsi del delitto davanti al procuratore di Firenze.
Solo la sera prima
dell’esecuzione, alle 11, la sentenza fu comunicata al condannato, che l’accolse
con incredibile fermezza. Durante la notte i confratelli di San Giovanni
Decollato tentarono in ogni modo di far confessare e pentire Cesare, che da
parte sua chiese, senza ottenerlo, di poter rivedere il fratello Annibale,
recluso al San Michele.
La mattina del 21
settembre fu portato a piazza Bocca della Verità, dove era stato innalzato il
patibolo. Prima di salirvi, strinse al petto un crocifisso e pregò, quindi si
avviò con fermezza, dicendo ai gendarmi: "guardate come va a morire il Lucatelli",
acclamando l’Italia e augurandole l’antica gloria. Si rivolse al popolo
protestando la sua innocenza, finché i tamburi lo interruppero. Il carnefice lo
obbligò a mettere sul ceppo la testa, che dopo poco sarebbe stata mostrata ai
presenti.
di
Cinzia Dal Maso
|
|
Il Risorgimento dei
romani |
|
Le sorelle Castellani
 Dal
diario di Anna Galletti de Cadilhac sappiamo che durante la difesa
della Repubblica Romana, tra le donne che assistevano i feriti
presso l’ospizio della Trinità dei Pellegrini, c’erano anche tre
belle sorelle romane, Elisa, Francesca e Augusta Castellani.
Appartenevano alla nota famiglia di orafi, secondo la testimonianza
di Annibale Lucatelli, "una delle più benefiche della nostra città
pel sacrificio continuo di libertà e sostanze che sopportò
coraggiosamente". La loro casa, nel palazzo Costa a San Marcello,
veniva perquisita praticamente ogni settimana.
Il 10
novembre 1850, ottavario della solennità dei defunti, la signora
Teresa Narducci, madre del giovane studente Paolo che era caduto
nella battaglia del 30 aprile del 1849, aveva invitato le sorelle
Castellani a recarsi con lei nella chiesa di S. Ignazio per
assistere alla cerimonia e pregare per coloro che erano morti
difendendo la patria. "Giunte colà divotamente s’inginocchiarono –
racconta Lucatelli - e allorché i sacerdoti benedicevano il
catafalco che sorgeva nel mezzo della chiesa, si levaroro, e gettati
dei fiori sulla coltre, esclamarono sommessamente: "Pace alle anime
dei caduti per la patria!" Quasi tutti i presenti ripeterono: "Pace,
pace.""
Questo
fatto innocente non mancò di avere conseguenze. La notte seguente
parecchi gendarmi bussarono alle porte delle famiglie Narducci e
Castellani portando in carcere a Montecitorio le tre sorelle e la
signora Teresa. "Era stato un atto così pietoso che avrebbe placato
l’ira del più crudele degli uomini. Quella povera madre credeva di
trovare un sollievo al suo immenso dolore, gettando alcuni fiori
sulla tomba del figlio e invocando dal Signore la pace per lui; e le
era capitato invece uno spaventevole oltraggio". Il fratello delle
ragazze, Giovanni Castellani, si recò dal generale francese De
Courcetez e gli narrò l’accaduto. L’ufficiale ne rimase sconvolto e
si adoperò in ogni modo per il ritorno a casa delle donne, che
avvenne dopo due giorni. Le poverette, però, dovettero rimanere agli
arresti domiciliari per altri quattro mesi. Non poterono uscire
nemmeno quando la mamma delle Castellani chiese un permesso speciale
al parroco di San Marcello affinché le figlie si potessero recare in
chiesa per prendere l’Eucarestia. Il religioso si limitò a mandare
l’ostia consacrata a casa.
Tra il
Lucatelli e una delle giovani ci doveva essere del tenero: nei
processi segreti della Sacra Consulta di Roma si legge che Annibale
tentava di giustificare il suo ritorno a Roma nel 1853 con il
desiderio di sposarsi con Augusta Castellani. La giovane, addolorata
per la lontananza dell’uomo, si sarebbe ammalata e sua madre
Carolina avrebbe finalmente dato il suo consenso al matrimonio.
di
Cinzia Dal
Maso
|
|
IL RISORGIMENTO DEI ROMANI |
|
Filippo De Cupis
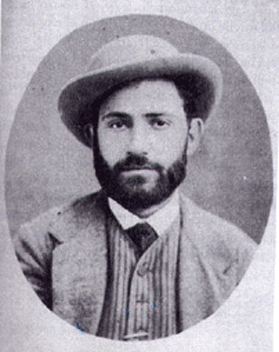 Durante
tutta l’infanzia e la prima giovinezza, l’interesse di Adriano De
Cupis era calamitato da un cassetto del comò chiuso, di cui nessuno,
in casa, gli voleva rivelare il contenuto. Solo dopo la morte del
padre, Adriano aveva potuto aprire quello scrigno, che non conteneva
monete o gioielli, ma qualcosa di infinitamente più prezioso: carte
ingiallite dal tempo, foto, lettere e documenti del bisnonno
garibaldino. Adriano ha sentito il dovere di studiare e riordinare
quelle memorie e oggi "Il cassetto chiuso" è diventato un libro,
denso di testimonianze e di immagini.
Filippo
De Cupis era nato a Roma, ma a 20 anni appena si era trasferito in
Sabina per gestire un feudo del principe Marcantonio Borghese,
andando ad abitare a Poggio Moiano con la moglie Giulia. Lo zio
Camillo, intimo amico di Melchiorre Cartoni, gli aveva instillato
fin dall’infanzia valori come patria e libertà. Il libro si sofferma
sull’incontro di Filippo con i figli di Garibaldi, Menotti e
Ricciotti, e sulla sua partenza nel 1866 - insieme con il fratello
Cesare De Cupis, il noto studioso della Campagna Romana - come
volontario nella terza guerra d’Indipendenza, dove si guadagnò i
gradi di capitano.
Nell’agosto del 1867 Filippo venne convocato a Orvieto da Giuseppe
Garibaldi, che gli affidò il delicato incarico di gestire le risorse
economiche per far fronte alle necessità di una parte delle truppe.
Seguirono le sanguinose battaglie di Monterotondo e Mentana. In
quest’ultima località le camicie rosse videro svanire le proprie
speranze di vittoria davanti ai nuovi fucili a retrocarica dei
francesi, gli chassepots.
Nel
1869 nasceva Luigi, il primo figlio di Giulia e Filippo. La festa
per il lieto evento fu organizzata dal fraterno amico di Filippo,
Leopoldo Brigazzi.
Quando
la vita sembrava sorridere alla famiglia, che si andava allargando
con la nascita di tre bambine e di un altro maschio, il destino
volle giocare un tiro crudele. Filippo, con l’ingenuità dei
galantuomini, si lasciò convincere da un banchiere, un tale Giuseppe
Nobili, ad affidargli una parte consistente del patrimonio ereditato
dal padre, per giocarlo in borsa. Fu un disastro. Non solo il Natali
gli prosciugò il conto, ma la banca gli ipotecò ogni proprietà.
Filippo cominciò a cercare l’imbroglione in lungo e in largo per la
Penisola. Alla fine lo trovò a Torino, ma solo per capire che da lui
non avrebbe potuto ottenere nulla. Completamente sul lastrico, trovò
un lavoro come fuochista su un vapore diretto a San Paolo del
Brasile, dove peraltro sembra non sia mai arrivato. Da allora la
famiglia non seppe più niente di lui.
di
Cinzia Dal
Maso
|
|
Il Risorgimento
dei romani |
|
Mattia Montecchi
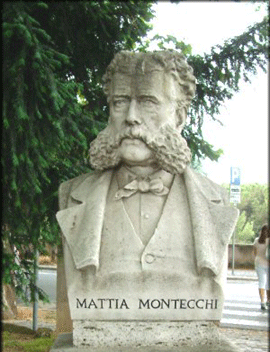
Su un
edificio di via Frattina, a destra del civico 12, proprio sopra le
finestre del primo piano, è murata una lapide in cui si legge: "In
questa casa dimorò / Mattia Montecchi romano / triumviro della
Repubblica nel (milleottocentoquarantanove) / Cittadino integerrimo
/ tutto diede alla patria / nulla chiese per sé".
Mattia
Montecchi era nato a Roma nel 1815 e fu carbonaro fino dal 1834,
partecipando a varie congiure contro il governo pontificio. Nel 1844
venne arrestato per cospirazione e condannato al carcere a vita. Fu
chiuso a Castel Sant’Angelo e poi nel forte di Civita Castellana,
dove ebbe come compagno di prigionia Felice Orsini. Nel 1846, dopo
l’elezione di Pio IX, poté godere dell’amnistia. Nel 1848 partecipò
alla campagna del Veneto. Ebbe una parte di primo piano nella
Repubblica romana, come deputato alla Costituente e ministro. Con la
restaurazione del governo pontificio, fu costretto all’esilio e a
Lugano fondò, insieme con Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi, una
società che si proponeva di pubblicare e diffondere in Italia
giornali, libri e opuscoli di idee rivoluzionarie e repubblicane.
Collaborò anche al giornale clandestino "L’Italia del Popolo".
Dopo
l’unificazione del Paese, tra il 1862 e il 1867, fu deputato del
Regno d’Italia.
Il 22
settembre del 1870 fu membro della Giunta di governo di Roma, fu
subito sciolta dal generale Cadorna.
Ecco
come Edmondo De Amicis descriveva, nel suo "Roma Capitale", il
discorso tenuto dal Montecchi nei giorni che seguirono la breccia di
Porta Pia: "Il vecchio patriota romano, accompagnato dagli amici,
avvolto e nascosto quasi dalle bandiere, sale sul pulpito a capo
scoperto, e preso appena fiato comincia con voce commossa: - Popolo
romano, rivendicato alla libertà e restituito per sempre alla comune
patria...
S’interrompe un istante, e poi con irresistibile slancio - ...Io ti
saluto!
L’ultima sua parola muore in un singhiozzo; egli si copre gli occhi
col fazzoletto e ricade sulla seggiola. La folla manda un grido
d’entusiasmo, tendendo le braccia e agitando le bandiere.
-
Silenzio! Silenzio!
Il
Montecchi ricomincia a parlare, a voce bassa, interrompendosi tratto
tratto. La folla ondeggiando e rimescolandosi, si stringe intorno al
pulpito. Le parole dell’oratore non giungono fino a me. Mi faccio
innanzi per intendere qualcosa.
Il potere temporale al Papa, - egli
esclama, - è caduto!"
Montecchi morì a Londra nel 1871. Il suo busto sul Gianicolo, del
1898, è opera di Emilio Dies.
di
Cinzia Dal
Maso
|
|
Il Risorgimento dei
romani |
|
Il generale Pietro Roselli, comandante supremo
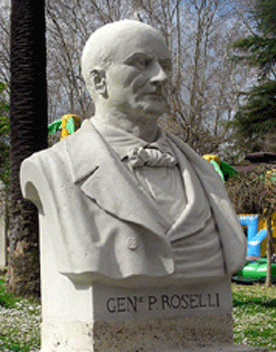 Pietro
Roselli era nato a Roma nel 1808. Frequentò l’accademia militare
diventando tenente del genio dell’esercito pontificio. Partecipò
alla prima guerra di indipendenza in Veneto alla testa di un
battaglione di volontari, prima come capitano e poi come maggiore.
Nell’esercito della Repubblica Romana fu promosso colonnello e come
tale intraprese una campagna contro il brigantaggio nelle Marche.
Nel maggio del 1849 venne richiamato a Roma e nominato – per volere
di Mazzini - generale di divisione, con il comando supremo delle
truppe. Così Roselli scavalcava di fatto Garibaldi, con la
giustificazione che, essendo romano e di sentimenti moderati, nonché
ex ufficiale pontificio, sarebbe stato meglio accettato sia dai
soldati della Repubblica che all’estero. Pietro
Roselli era nato a Roma nel 1808. Frequentò l’accademia militare
diventando tenente del genio dell’esercito pontificio. Partecipò
alla prima guerra di indipendenza in Veneto alla testa di un
battaglione di volontari, prima come capitano e poi come maggiore.
Nell’esercito della Repubblica Romana fu promosso colonnello e come
tale intraprese una campagna contro il brigantaggio nelle Marche.
Nel maggio del 1849 venne richiamato a Roma e nominato – per volere
di Mazzini - generale di divisione, con il comando supremo delle
truppe. Così Roselli scavalcava di fatto Garibaldi, con la
giustificazione che, essendo romano e di sentimenti moderati, nonché
ex ufficiale pontificio, sarebbe stato meglio accettato sia dai
soldati della Repubblica che all’estero.
Caduta
la Repubblica, andò in esilio a Genova, ma nel 1859 era di nuovo a
capo di una divisione di volontari. Finalmente nel 1860 divenne
tenente generale dell’esercito italiano, con il quale partecipò alla
conquista di Ancona, di cui fu anche comandante di piazza. Roselli
morì nel 1885 nella città marchigiana, dove fu sepolto, per sua
espressa volontà.
L’anno
seguente il Comune di Roma, per onorare la memoria dell'illustre
concittadino, concesse gratuitamente un’area di sepoltura nel
cimitero del Verano e partecipò alle spese per la tomba, progettata
da Ignazio Roselli Lorenzini, nipote del generale, e realizzata in
pietra gabina dallo scultore Adalberto Cencetti (1847 - 1907).
Il
busto del Gianicolo è invece opera di Pietro Benedetti (1893).
di
Cinzia Dal Maso
|
|
Fu un geniale artista e un fervido eroe del Risorgimento |
|
Il trasteverino Nino Costa, pittore e patriota
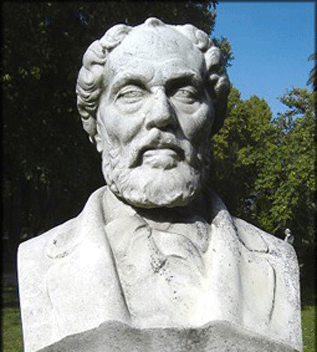 Giovanni
Costa, detto Nino, era nato a Roma il 15 ottobre 1826, quattordicesimo di
quindici figli, da una famiglia trasteverina di industriali della lana, il cui
palazzo è ancora visibile nella piazza dove c’è la chiesa di San Francesco a
Ripa, con tanto di lapide commemorativa. Giovanni
Costa, detto Nino, era nato a Roma il 15 ottobre 1826, quattordicesimo di
quindici figli, da una famiglia trasteverina di industriali della lana, il cui
palazzo è ancora visibile nella piazza dove c’è la chiesa di San Francesco a
Ripa, con tanto di lapide commemorativa.
Ricevette
un’educazione classica, ma rimase affascinato dall’arte medioevale e
rinascimentale. Intanto diventava un convinto assertore dell’unità d’Italia. Nel
1847 si iscrisse alla "Giovane Italia" e nel 1848 partecipò come volontario alla
prima guerra d’indipendenza.
Fin da questo
periodo iniziò a frequentare gli studi di artisti neoclassici e romantici,
allontanandosene però presto, per il suo amore per la pittura dal vero.
Quando fu
proclamata la Repubblica Romana, aveva appena 23 anni e si trovava in disaccordo
con il padre e con i fratelli, per le sue idee liberali, ma soprattutto per la
sua volontà di non occuparsi dell’azienda di famiglia, per dedicarsi alla
pittura. Ospitò nella sua casa a Garibaldi e fu nominato consigliere municipale.
Al ritorno del
Papa, tra il 1850 e il 1851 fu a Napoli, dove forse poté conoscere e apprezzare
la scuola di Posillipo. Nel 1853 avvenne la sua "conversione monarchica".
Imputava alle concezioni politiche di Mazzini il fallimento della difesa della
Repubblica Romana. Si riunì con alcuni amici nel suo studio di via Margutta 33.
Furono concordi che tutti i romani liberali si dovevano unire per aiutare il re
Vittorio a liberare l’Italia. "Passando ad esaminare quali mezzi fossero più
acconci ad ottenere tale scopo, presto ci trovammo d’accordo, pure, nel
riconoscere che l’uomo più capace e più accetto per ottenere la conversione dei
romani al nostro nuovo indirizzo politico e per ordinare un nuovo partito, per
promuoverlo e per sostenerlo fosse l’amico" Giuseppe Checchetelli, che dopo
essere stato arrestato nel febbraio del 1850, viveva nel paese di origine dei
genitori, Ciciliano. Costa lo convinse a tornare a Roma, e da allora
Checchetelli rimase per molti anni alla guida del cosiddetto "partito
ragionevole" romano.
Il 1856 segnò
inizio del successo artistico di Nino Costa nell’ambiente inglese, con il quadro
"Dormono di giorno per pescare di notte", che, replicato in dimensioni maggiori,
fu esposto nel 1890 alla New Gallery di Londra. Sempre nel 1856 venne esposto
alla Promotrice romana un dei suoi dipinti più celebrati, "Donne che imbarcano
legna al porto di Anzio", del 1852.
Nel 1859 tornò a
combattere per l'indipendenza italiana e partecipò alla seconda guerra di
indipendenza, arruolandosi nel regio esercito piemontese. Alla fine di
quell’anno andava a Firenze, dove si trovavano molti altri patrioti, per unirsi
a loro. Ma la città era anche un floridissimo centro artistico, dove entrò in
contatto, soprattutto al Caffè Michelangelo, con i giovani macchiaioli, che
convinse ad abbandonare i soggetti storici per la pittura dal vero.
Viaggiò moltissimo,
anche all’estero, con una grande apertura verso tecniche ed idee nuove. Può
essere considerato il paesaggista più autorevole fra i ribelli dell’ambiente
romano ed era convinto che occorresse dipingere con gli stessi mezzi del vero.
Nonostante l’enorme successo ottenuto in paesi come la Francia o l’Inghilterra e
a dispetto del suo ruolo di polo catalizzatore dei vari tentativi di
rinnovamento artistico della cultura romana, Costa non fu mai compreso e
accettato del tutto nella sua città. Si definiva "la persona più impopolare nel
mondo artistico romano".
Nel 1870 partecipò
alla liberazione di Roma e fu tra i primi ad entrare dalla breccia di porta Pia,
insieme con Augusto Valenziani, di cui il pittore così raccontava la morte: "fra
le fucilate dei nemici, pure noi avanzavamo a sbalzi, di corsa. I difensori ci
sparavano addosso. Mentre sotto il fuoco avanzavamo, mi sono voltato verso
Valenziani (che portava gli occhiali) chiedendogli: Le tue lenti si sono rotte?
Nello stesso istante una palla nella testa me lo faceva cadere morente, fra le
braccia. Io l’ho tratto da parte, l’ho appoggiato a un muro e abbracciandolo gli
ho detto: Ringrazia Iddio che ti fa morire così! E mi sono gettato all’assalto".
Da allora partecipò
attivamente alla vita politica della città, divenendo anche consigliere
comunale. Riprese l’attività artistica, senza perdere il suo carattere ribelle e
fondando molti gruppi artistici, come il Golden Club, il Circolo degli Italiani
e la Scuola Etrusca.
Prima di morire, il
31 gennaio del 1903 a Marina di Pisa, dettò i suoi ricordi alla figlia,
pubblicati postumi nel 1927 con il titolo "Quel che vidi e quel che intesi".
di
Cinzia Dal Maso
|
|
Il Risorgimento dei
romani |
|
Angelo Tittoni
 Il
busto del patriota Angelo Tittoni è collocato nel punto in cui la
passeggiata del Gianicolo si biforca, proprio di fronte al monumento
di Garibaldi. Lo scultore Ettore Ferrari, che lo ha eseguito nel
1902, ha raffigurato l’eroe con la divisa del battaglione
universitario romano, caratterizzata dal cappello alla calabrese
ornato di piume. Angelo era nato nel 1820 e apparteneva a quella
borghesia romana che aveva raggiunto una
solida posizione economica esercitando la professione di "mercante
di campagna" senza però godere di alcun privilegio e si era per
questo accostata alle idee liberali. Il
busto del patriota Angelo Tittoni è collocato nel punto in cui la
passeggiata del Gianicolo si biforca, proprio di fronte al monumento
di Garibaldi. Lo scultore Ettore Ferrari, che lo ha eseguito nel
1902, ha raffigurato l’eroe con la divisa del battaglione
universitario romano, caratterizzata dal cappello alla calabrese
ornato di piume. Angelo era nato nel 1820 e apparteneva a quella
borghesia romana che aveva raggiunto una
solida posizione economica esercitando la professione di "mercante
di campagna" senza però godere di alcun privilegio e si era per
questo accostata alle idee liberali.
Nel
1848 partecipò alla prima guerra di indipendenza, come colonnello
del battaglione universitario romano, di cui fu il primo comandante:
si distinse nella battaglia di Cornuda e nella strenua difesa di
Vicenza. In seguito fu sostituito dal maggiore Luigi Ceccarini.
L’anno
seguente aderì alla Repubblica Romana, costituendo il corpo militare
dei cacciatori del Tevere. Fu anche eletto nel consiglio municipale
e venne chiamato a presiedere la commissione per
l’approvvigionamento alimentare. Durante l’assedio francese di Roma
fu impegnato nella difesa del Vascello.
Alla
caduta della Repubblica, il ritorno di Pio IX non creò troppi
problemi alla famiglia Tittoni. Angelo, pur conducendo una vita
ritirata, continuò a svolgere la sua attività politica
Dal
1851 ospitò nella sua villa di Manziana il pittore russo Karl
Pavlovi ć
Brjullov, l’autore del celebre quadro "l’ultimo giorno di Pompei",
che morì proprio lì, il 23 giugno del 1852, lasciandogli in eredità
numerosi dipinti e disegni eseguiti durante i suoi soggiorni romani.
A
Manziana Brjullov aveva anche eseguito il ritratto a olio su tela di
Angelo oggi conservato in una collezione privata. Il giovane è
raffigurato in piedi, di tre quarti, con il capo voltato verso lo
spettatore, una corta barba scura e l’alta fronte stempiata. Sullo
sfondo, un muro a blocchi di tufo illuminato da una luce proveniente
da destra. L’abbigliamento è piuttosto informale, composto da
calzoni di fustagno e ampia camicia bianca, con sopra una casacca
nera aperta. La vita è stretta da una fusciacca rossa. L’intensità
dell’espressione conferisce al dipinto una straordinaria forza. Allo
stesso pittore si deve il ritratto del fratello di Angelo, Vincenzo.
Nel
febbraio del 1861 Angelo Tittoni, insieme con altri tredici
cittadini, fu costretto ad andare in esilio. Solo dopo l’unità
d’Italia poté tornare a Roma, dove morì nel 1882.
di
Cinzia Dal
Maso
|
|
Il
Risorgimento dei romani |
|
Filippo
Cerroti, ingegnere militare e patriota
 Filippo
Cerroti Filippo
Cerroti era nato a Roma il 10
febbraio del 1819. Nel 1832 era cadetto del genio pontificio e nel
1848 aveva partecipato, con le truppe romane, alla campagna del
Veneto. L’anno seguente fu alla difesa di Roma e durante il
triunvirato resse il Ministero della Guerra.
Caduta
della Repubblica Romana, fu costretto ad andare in esilio in
Piemonte, dove entrò pian piano nella sfera d'influenza cavouriana.
Militò nell’esercito sardo e combatté nel 1859. Si distinse
soprattutto come ingegnere militare e ferroviario, progettando
numerose strade ferrate.
Nel
settembre del 1870 Nino Bixio gli affidò il comando della piazza di
Civitavecchia. Nel novembre dello stesso anno fu membro del primo
consiglio comunale di Roma.
Fu
anche deputato del Regno d’Italia: venne eletto per la X legislatura
al collegio di Avezzano il 27 novembre 1870 e per la XI e la XII
legislatura al collegio di Roma II e Civitavecchia.
Si
occupò persino del Tevere, con uno studio pubblicato a Firenze nel
1872, "Le inondazioni di Roma ed i provvedimenti che possono
ripararvi".
Il 10
luglio del 1877 si costituiva la "Società Nazionale di Ginnastica,
Scherma e Tiro a Segno", con sede nel palazzo dei conti Giannelli,
in via dei Cesarini 18, oggi affacciato su corso Vittorio Emanuele.
La
sezione della scherma era affidata proprio al Cerroti, all’epoca
tenente generale, fiorettista provetto, che amava tirare con il
braccio sinistro.
Filippo
Cerroti si spense a Roma il 20 giugno 1892.
Il suo
busto sul Gianicolo, opera di G. Senesi, fu realizzato nel 1903.
di
Cinzia Dal
Maso
|
|
Il Risorgimento dei
romani |
|
Bartolomeo Filipperi
 Tra
i popolani romani che parteciparono agli eventi risorgimentali
spicca un personaggio veramente particolare, Bartolomeo Filipperi,
nato nel 1833 e assai influente nel rione di Trastevere. Tra
i popolani romani che parteciparono agli eventi risorgimentali
spicca un personaggio veramente particolare, Bartolomeo Filipperi,
nato nel 1833 e assai influente nel rione di Trastevere.
Appena
sedicenne combatté a difesa della Repubblica Romana.
Secondo
la descrizione di Aurelio Saffi fu uno di coloro che "sorti dalle
file degli operai e nobili di natura, furono più cari ai precursori
del risorgimento italiano".
Per
Giuseppe Mazzini era un romano degno di Roma.
Dopo la
caduta della Repubblica, andò in esilio a Genova fino al 1870,
tenendo una parte operativa nella storia del mazzinianesimo. In
seguito fu membro del Comitato romano.
A
vicolo Moroni era proprietario, insieme con Giovanni Mancini, del
Nuovo Politeama Romano. I due gestivano anche una rinomata e
caratteristica osteria annessa al teatro, detta "degli Orti
Aureliani", che in seguito si sarebbe chiamata "Trattoria del
Lungotevere", frequentata da letterati, artisti e giornalisti, che
vi fondarono l’associazione detta "La Lega dell’Ortografia".
Il 6
febbraio del 1875 Raffaele Sonzogno, direttore del quotidiano romano
"La Capitale", era stato assassinato nella sua redazione, da un uomo
catturato subito dopo l'omicidio, che aveva tutta l'aria di essere
un sicario. Al processo Filipperi fu al centro di una vivace
polemica. Chiamato a testimoniare fu invitato a giurare sul Vangelo,
ma si rifiutò, dichiarandosi un libero pensatore e dicendo di voler
giurare solo sulla propria coscienza e sul proprio onore.
Nel
1882 fondò, insieme con Bartolomeo Della Bitta e Angelo Giuntini,
l’Associazione "Giuditta Tavani Arquati", con sede in via della
Lungaretta 97, che si distinse per il suo acceso anticlericalismo e
nel 1889 arrivò a contare un centinaio di soci.
Si
legge nella "Civiltà Cattolica" del 1887: "Bartolomeo Filipperi,
noto garibaldino e repubblicano in Roma, che teneva in Trastevere
una osteria, frequentata dai radicali, era morto da pochi giorni in
Albano, dov’erasi recato per recuperare la sua salute. La sua salma
si volle portare per Roma in trionfo..." L’evento si trasformò
nell’occasione per un corteo e un comizio in cui si espressero con
animazione e violenza sentimenti antipapali. In quello stesso anno
gli venne dedicato un busto in marmo al Gianicolo, eseguito da
Lorenzo Cozza, figlio di del conte Adolfo, anch’egli scultore. Nato
a Orvieto nel 1877, Lorenzo si era trasferito alla fine del secolo a
Roma, dove frequentò la Regia Accademia di Belle Arti e vinse il
concorso per un monumento a Giacomo Leopardi a Recanati.
di
Cinzia Dal
Maso
|
|
Il Risorgimento dei
romani |
|
Ludovico
Calandrelli
 Ludovico
Calandrelli, fratello di Alessandro, era nato a Roma il 21 agosto
del 1807. Il padre Giovanni era un incisore di pietre preziose e
Ludovico, nella sua fanciullezza, studiò la pittura. La vita
militare, però, lo attraeva di più ed entrò nel 1816 nell’esercito
pontificio, come cadetto, prima nel genio e poi nell'artiglieria.
Nell'aprile del 1848, con il grado di capitano di terza classe, fu
al comando di una batteria da campo nel corpo di spedizione
pontificio del generale Durando, arrivando fino nel Veneto e
segnalandosi in vari fatti d’armi, soprattutto difendendo Vicenza
dall’attacco austriaco, per dodici ore di seguito, tra il 23 e il 24
maggio. Il 10 giugno, durante la battaglia decisiva per la città
veneta, rimase alla testa della sua postazione nonostante i ripetuti
attacchi nemici e partecipò alla mischia di porta Padova: azioni che
gli valsero la nomina prima a capitano di prima classe e poi a
maggiore.
Tornò
quindi a Roma, dove aderì prima al governo provvisorio, dal quale fu
nominato, nel gennaio del 1849, tenente colonnello, poi alla
Repubblica. Il 30 aprile fu di presidio a porta Cavalleggeri e si
distinse nella respinta dei francesi. Con il grado di colonnello, a
maggio comandò l’artiglieria da campo nella battaglia di Velletri
contro l’esercito napoletano. La sua azione fu preziosa durante
l’assedio della Repubblica, dal 3 al 19 giugno, quando rimase ferito
sui bastioni di porta San Pancrazio. Sul Giornale di Roma, nel
supplemento "Elenco dei feriti", il suo nome risulta al n. 14 del 19
giugno, con l’indicazione di "contusione al torace e basso ventre".
Dopo l’ingresso dei francesi, rimase a Roma fino a dicembre, quando
andò in esilio volontario, prima a Marsiglia, dove rimase fino al
maggio del 1850, poi a Berlino. Qui cercò di utilizzare la sua
esperienza militare. Nel 1852 scrisse una relazione
sull’organizzazione dell’esercito pontificio e compilò uno studio
sul sistema militare prussiano. Nel luglio del 1854 si portò a
Parigi ove ottenne, per interessamento del principe di Canino e del
generale Vaillant, un passaporto e un imbarco gratuito per
Costantinopoli, insieme ad alcune lettere di raccomandazione. In
Turchia – ai ferri corti con la Russia – fu ricevuto con tutti gli
onori ed entrò al soldo della Porta con il nome di Mouglis bey, ma
solo all'inizio del 1855 riuscì a spingersi verso l'interno,
giungendo a febbraio inoltrato nel punto chiave dello scacchiere
ottomano, la città di Erzerum. Qui lo capo di Stato Maggiore
dell'armata turca gli affidò il compito di preparare le postazioni
di artiglieria della città in vista di una possibile avanzata delle
truppe russe. Nell’esercito turco raggiunse il grado di generale. Il
suo fisico era però rimasto indebolito dalle fatiche e dal clima
poco salubre: Ludovico contrasse il colera, quindi un attacco di
tifo ne procurò la morte, il due settembre del 1855. Fu tumulato
nella chiesa armena cattolica di Erzerum, primo cristiano seppellito
con musica militare turca. Nel 1887 il municipio di Roma gli eresse
un busto in marmo sul Gianicolo, opera di Enrico Simonetti.
di
Cinzia Dal
Maso
|
|
Soccorreva i feriti durante la Repubblica Romana |
|
Clelia Nalli Massimi:
un’attrice in corsia
 Clelia
Nalli era nata a Roma nel 1810 da Enrica e Sebastiano, entrambi romani, di
estrazione borghese e assai stimati. La madre, poetessa di una certa fama,
intorno al 1820, nella sua casa in via del Pozzetto, ospitava riunioni di
artisti e letterati, tra cui il Ferretti, il Perticari, il Rossini, il Canova e
il principe Poniatowski, durante le quali venivano letti lavori teatrali di
Vittorio Alfieri e Vincenzo Monti. Tali letture si trasformarono in vere e
proprie rappresentazioni, nelle quali, per motivi di spazio, lo scenario era
sostituito da una semplice tabella sulla quale era indicato il luogo in cui si
svolgeva l’azione. Sembra che durante una di queste recite anche il Canova
interpretasse un ruolo nell’Ifigenia dell’Alfieri. Clelia
Nalli era nata a Roma nel 1810 da Enrica e Sebastiano, entrambi romani, di
estrazione borghese e assai stimati. La madre, poetessa di una certa fama,
intorno al 1820, nella sua casa in via del Pozzetto, ospitava riunioni di
artisti e letterati, tra cui il Ferretti, il Perticari, il Rossini, il Canova e
il principe Poniatowski, durante le quali venivano letti lavori teatrali di
Vittorio Alfieri e Vincenzo Monti. Tali letture si trasformarono in vere e
proprie rappresentazioni, nelle quali, per motivi di spazio, lo scenario era
sostituito da una semplice tabella sulla quale era indicato il luogo in cui si
svolgeva l’azione. Sembra che durante una di queste recite anche il Canova
interpretasse un ruolo nell’Ifigenia dell’Alfieri.
Le sue figlie
Giuditta, Lavinia e Clelia, cresciute in un ambiente così colto ed
effervescente, non potevano che rimanere contagiate dall’amore materno per la
letteratura italiana.
Clelia si era
sposata molto giovane con il chirurgo Lorenzo Massimi, anch’egli appassionato di
arte drammatica. Allo spirito eletto, ai modi scelti e soavi" – scriveva
Virginio Prinzivalli nelle memorie dell’Accademia filodrammatica romana -
riuniva un aspetto leggiadro". Era di statura media, snella ed elegante. Aveva
capelli neri e sguardo vivo, amava la lettura ed era dotata di solidi principi
morali e religiosi. Nell’aprile del 1842 entrò a far parte, insieme con la
sorella Giuditta, dell’Accademia filodrammatica romana. Pietro Sterbini le
affidò la parte di Livia nella sua tragedia il "Tiberio".
All’inizio del 1848
promosse alcune rappresentazioni a beneficio degli asili d’infanzia. Venne anche
messa in scena una singolare commedia in due atti, "L’Istituto di Montereau", il
cui titolo originale era "L' anno
1814 ossia Il pensionato di Montereau", di A. P. Dennery e E. Cormon, eseguita
da quattordici ragazze agli ordini di Virginia Traversi e Clelia Massimi, che,
per l’occorrenza, si erano fatte istruire nelle manovre militari da un ex
capitano della guardia napoleonica, il maggiore Zacchieri.
Singolare
l’intreccio, ambientato in Francia, a Montereau, nel 1814, quando la cittadina
era invasa dagli austriaci. I loro alleati avanzano verso Parigi e l'imperatore
muove contro di loro. Il sarto Giampaolo Canivet conduce la nipote Cecilia
presso la sua vicina madama Laurent, che oltre a quattro nipoti, Augustina,
Clotilde, Giannina ed Ernestina, tiene a pensione anche altre giovinette, per
tenerla al sicuro mentre lui è costretto a far parte della guardia nazionale.
Cecilia, una ragazza molto vivace, è innamorata del giovane Alfredo, ufficiale
della guardia nazionale. Induce Mulot, il giardiniere di madama Laurent, a
impadronirsi delle uniformi e delle armi in possesso dello zio Canivet, quindi
fa vestire tutte le pensionate da soldati e la serva Susanna da tamburino. Fa
prigioniera madama Laurent, chiude lo zio nella colombaia e si nomina comandante
del drappello femminile. Alfredo, ferito dai Cosacchi in un'imboscata, è
soccorso da Cecilia, che poi, sapendo che sta per passare vicino al pensionato
un distaccamento degli alleati, incita le ragazze a far fuoco su di loro.
Questi, credendo di essere assaliti da un gran numero di soldati francesi, si
danno alla fuga. Dall’alto di una collina Napoleone assiste all’avvenimento e
rimane ammirato dal coraggio del volontario che comanda il drappello, ignorando
che si tratta dell’intrepida Cecilia. Ordina al suo aiutante di raggiungere il
giovane, riconoscibile per la sua sciarpa celeste, e di promuoverlo. Cecilia,
saputa la cosa, cinge della sua sciarpa Alfredo, che, divenuto capitano, la può
sposare tra il tripudio generale.
Purtroppo sulla
commedia si abbatté la scure della censura teatrale, per mano del famigerato
abate Somai. Agli attori fu proibito di pronunciare le parole cosacchi, russi,
imperatore, Parigi, sostituite dalle generiche espressioni di nemici, capitale,
paese.
Nel giro di poco
tempo Clelia Massimi passò dalla guerra per commedia a quella tragica e reale
della Repubblica Romana sotto le bombe francesi. La donna, di cui era noto lo
spirito caritatevole – come scriveva il Prinzivalli sapeva fare "proprio
l’altrui dolore" - prestò la propria opera, insieme con la giovanissima figlia
Giulia, per la cura dei feriti presso l’ambulanza allestita all’ospizio della
Trinità dei Pellegrini.
Da una guida per
viaggiatori inglesi del 1856 sappiamo che in quegli anni Clelia Massimi dava
lezioni di declamazione per signore in lingua italiana nel palazzetto Borghese.
La sera del 23
novembre 1857, appena rincasata dalla prova generale di uno spettacolo teatrale,
Clelia fu colta da apoplessia fulminante e morì alle sette del mattino seguente.
di
Cinzia Dal Maso
|
|
Il Risorgimento dei
romani |
|
Natale Del Grande, l’eroe del rione
Monti
 Natale
del Grande era nato nel 1800 a Roma, nel rione Monti, dove era conosciuto e
amato da tutti. Si era creato onestamente una ricchezza, esercitando la
professione di mercante di campagna. Aderì alle idee libertarie e nel 1847 fu
tra gli organizzatori della Guardia Civica. Allo scoppio della prima guerra
d’Indipendenza, si arruolò tra i volontari e, con il grado di colonnello nella
Legione Romana, ebbe il comando di un reggimento. Fu nelle prime file tra gli
eroici difensori di Vicenza e il 10 giugno del 1848, durante la più cruenta
battaglia di tutta la campagna, in cui i nemici furono per quattro volte
respinti dal monte, dalle mura e dalle trincee, Natale cadde con il petto
squarciato da una racchetta austriaca, una sorta di granata legata a un manico
di legno. Si dice che morisse gridando ai suoi uomini: "io muoio, figlioli, ma
non importa: viva l’Italia!" Natale
del Grande era nato nel 1800 a Roma, nel rione Monti, dove era conosciuto e
amato da tutti. Si era creato onestamente una ricchezza, esercitando la
professione di mercante di campagna. Aderì alle idee libertarie e nel 1847 fu
tra gli organizzatori della Guardia Civica. Allo scoppio della prima guerra
d’Indipendenza, si arruolò tra i volontari e, con il grado di colonnello nella
Legione Romana, ebbe il comando di un reggimento. Fu nelle prime file tra gli
eroici difensori di Vicenza e il 10 giugno del 1848, durante la più cruenta
battaglia di tutta la campagna, in cui i nemici furono per quattro volte
respinti dal monte, dalle mura e dalle trincee, Natale cadde con il petto
squarciato da una racchetta austriaca, una sorta di granata legata a un manico
di legno. Si dice che morisse gridando ai suoi uomini: "io muoio, figlioli, ma
non importa: viva l’Italia!"
Dopo la
capitolazione di Vicenza, i Legionari trasportarono la salma di Natale del
Grande a Roma, dove si svolsero, il 18 agosto, le solenni esequie. Fu inumata
nel suo rione, nella chiesa di San Francesco di Paola, dove però nessuna lapide
lo ricorda.
Scriveva Mariano
D’Ayala nelle sue "Vite degl'italiani benemeriti della libertà e della patria"
(1868): "Ei lasciava un figliuolo, il quale speriamo, avrà continuato la bella
fama paterna". Il suo busto sul Gianicolo fu eseguito nel 1887 da Mario Gori.
Dell’argomento si
parlerà a Nuova Spazio Radio (88.100 MHz), a "Questa è Roma", il
programma ideato e condotto da Maria Pia Partisani, in studio con Livia
Ventimiglia il martedì dalle 14 alle 15 e in replica il sabato dalle 10 alle 11.
di
Cinzia Dal Maso |
|
Il Risorgimento dei Romani |
|
Luigi Ceccarini, una
vita per la patria
 Tra
i patrioti romani, non si può dimenticare Luigi Ceccarini. Era nato nel
1819 ed entrò a far parte dell’esercito pontificio. Infiammato come molti altri
dall’iniziale patriottismo di Pio IX, volle partecipare nel 1848 alla prima
guerra d’indipendenza contro l’Austria. Partì con il grado di capitano e si
conquistò quello di maggiore sul campo. Nella difesa di Vicenza comandava il
battaglione universitario ed era molto amato dai suoi ragazzi, con i quali
riuscì a sostenere l’urto di una brigata austriaca alla Rotonda del Palladio.
Alla caduta di Vicenza, Ceccarini portò il suo battaglione a Venezia, rimanendo
a difesa dei forti di Marghera, Brondolo, Chioggia e Pellestrina. Tra
i patrioti romani, non si può dimenticare Luigi Ceccarini. Era nato nel
1819 ed entrò a far parte dell’esercito pontificio. Infiammato come molti altri
dall’iniziale patriottismo di Pio IX, volle partecipare nel 1848 alla prima
guerra d’indipendenza contro l’Austria. Partì con il grado di capitano e si
conquistò quello di maggiore sul campo. Nella difesa di Vicenza comandava il
battaglione universitario ed era molto amato dai suoi ragazzi, con i quali
riuscì a sostenere l’urto di una brigata austriaca alla Rotonda del Palladio.
Alla caduta di Vicenza, Ceccarini portò il suo battaglione a Venezia, rimanendo
a difesa dei forti di Marghera, Brondolo, Chioggia e Pellestrina.
Nel 1849, diventato
tenente colonnello, partecipò alla difesa della Repubblica Romana dall’assedio
francese condotto dalle truppe del generale Oudinot. Insieme con il capitano del
genio Ravioli, il maggiore di artiglieria Lipari e il luogotenente Viola,
comandò, sul monte Testaccio, una batteria di tre cannoni: uno da 36, uno da 18
e uno da 9.
Con la
restaurazione del governo pontificio, Luigi Ceccarini non ottenne il perdono
papale e, escluso dall’amnistia, fu costretto a riparare in Piemonte. Entrò
nell’esercito sardo e prese parte alla seconda e alla terza guerra di
indipendenza. Dopo l’unità d’Italia contribuì alla repressione del brigantaggio
nel meridione.
Il busto di
Ceccarini sul Gianicolo fu realizzato nel 1896 dallo scultore Odoardo Tabacchi
(1836-1905) di Valganna (Varese), uno dei grandi autori dell’epopea
risorgimentale. Nel 2004 al busto fu staccata la testa e trafugata. L’anno
seguente fu ritrovata dalle forze dell'ordine.
di
Cinzia Dal Maso |
|
I romani e il Risorgimento |
|
Melchiorre Cartoni,
un marmoraro garibaldino
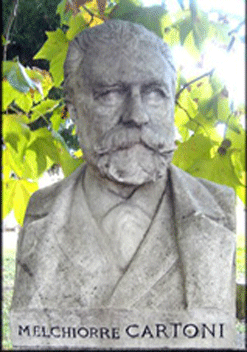
Melchiorre Cartoni
era nato nel 1927 da una famiglia di marmorari romani. Nel 1848 partecipò alla
prima guerra d’indipendenza, arruolandosi tra i volontari. Il 10 giugno di
quello stesso anno combatté in difesa di Vicenza, rimanendo ferito. Fu poi tra i
difensori di Roma nel 1849. Alla caduta della Repubblica, rimase a Roma, ma fu
rinchiuso sia alle Carceri Nuove che al San Michele per attività cospiratorie.
Il 15 agosto del 1862, accusato di complotto contro lo Stato, si nascose in casa
di parenti fino alla notte del 4 settembre, quando, durante un violento
temporale, raggiunse Fiano Romano, dove trovò un’imbarcazione sulla quale
attraversò fortunosamente il Tevere in piena. Passato il confine, andò a Rieti,
quindi a Perugia e infine a Cortona, ospite del marchese Gualtiero. Peregrinò
per l'Italia rimanendo in contatto con molti patrioti. Dal 1865 al 1870 abitò
quasi ininterrottamente a Poggio Moiano, dove la sua casa fu sempre aperta a
emigrati e perseguitati politici.
Il governo italiano
gli affidò importanti incarichi. Fu presidente del comitato per l'emigrazione e
organizzò le squadre dei volontari romani per la campagna del 1866. Fu membro
del Comitato Nazionale Romano e nel 1867 partecipò all’organizzazione della
spedizione di Mentana. Il 20 settembre del 1870 rientrò a Roma attraverso la
breccia di Porta Pia, quindi, modesto e sereno, tornò al suo studio di marmoraro.
Il suo busto al Gianicolo fu eseguito nel 1920 dallo scultore Giuseppe Tonnini.
di
Cinzia Dal Maso
|
|
Uno dei
cittadini romani protagonisti del Risorgimento |
|
Augusto Valenziani,
caduto a Porta Pia
 Scriveva
Silvio Negro nel 1941: "l’elenco dei Caduti per Roma sarà inciso, distribuito
per epoche, su1 bianco marmo delle lastre che chiudono i loculi dell’ossario: si
aprirà con il nome del romano Paolo Narducci, che fu il primo caduto del ‘49, e
si chiuderà con quello di un altro romano, la medaglia d’argento Augusto
Valenziani, ufficiale dell’esercito italiano dopo essere stato volontario nel
‘49, primo caduto di Porta Pia. La circostanza vale anche a mettere in evidenza
la larga partecipazione dell’elemento romano tra i Caduti, a sfatare una
leggenda ingiusta sulla quale speculò anche la passione politica, quella che
attribuiva l’iniziativa e il merito degli avvenimenti ai venuti di fuori.".
Valenziani era nato nel 1832 e, forse come cameriere segreto, aveva fatto parte
della corte papale. Giovanissimo fu impegnato nella difesa della Repubblica
Romana, quindi partecipò alla III Guerra d'Indipendenza. Era luogotenente del
40° fanteria e il 20 settembre 1870, a Porta Pia, fu uno dei primi ufficiali del
reggimento a superare la barricata esterna, ansioso anche di riabbracciare, dopo
tanti anni, la vecchia madre. Morì per la fucilata di uno zuavo pontifico. Scriveva
Silvio Negro nel 1941: "l’elenco dei Caduti per Roma sarà inciso, distribuito
per epoche, su1 bianco marmo delle lastre che chiudono i loculi dell’ossario: si
aprirà con il nome del romano Paolo Narducci, che fu il primo caduto del ‘49, e
si chiuderà con quello di un altro romano, la medaglia d’argento Augusto
Valenziani, ufficiale dell’esercito italiano dopo essere stato volontario nel
‘49, primo caduto di Porta Pia. La circostanza vale anche a mettere in evidenza
la larga partecipazione dell’elemento romano tra i Caduti, a sfatare una
leggenda ingiusta sulla quale speculò anche la passione politica, quella che
attribuiva l’iniziativa e il merito degli avvenimenti ai venuti di fuori.".
Valenziani era nato nel 1832 e, forse come cameriere segreto, aveva fatto parte
della corte papale. Giovanissimo fu impegnato nella difesa della Repubblica
Romana, quindi partecipò alla III Guerra d'Indipendenza. Era luogotenente del
40° fanteria e il 20 settembre 1870, a Porta Pia, fu uno dei primi ufficiali del
reggimento a superare la barricata esterna, ansioso anche di riabbracciare, dopo
tanti anni, la vecchia madre. Morì per la fucilata di uno zuavo pontifico.
Pietro Cossa gli
dedicò una toccante lirica. Il suo busto sul Gianicolo è opera dello scultore
Publio Morbiducci (1920), artista romano noto per il monumento del Bersagliere a
Porta Pia.
Nel 1941, la stele
funeraria della sua tomba al Verano fu inserita da Giovanni Jacobucci nel
Monumento a tre caduti per la liberazione di Roma 1870.
di
Cinzia Dal Maso
|
|
Perì nel naufragio del
piroscafo che lo portava in America |
|
Giovanni
Angelo Ossoli
 Il
marchese Giovanni Angelo Ossoli era nato a Roma – ultimo di otto
figli - il 17 gennaio del 1821, da Filippo e Maria Anna Cleter. Il
suo casato era originario della Lombardia, ma si era stabilito nel
Lazio fin dal 1701. Alto e di bella presenza, timido e non molto
colto, si infiammò ben presto degli ideali mazziniani. Il 1° aprile
del 1847 – era giovedì santo – incontrò per caso a San Pietro una
donna americana più matura di lui, ma piena di fascino e di idee
progressiste, già affermata come giornalista nel suo paese: era
Margaret Fuller, che aveva perso di vista gli amici con i quali
stava assistendo ai Vespri. Il marchese, con galanteria tutta
latina, si offrì di riaccompagnare a casa la donna, che dal canto
suo era rimasta subito impressionata dall’aspetto malinconico e
dalla cravatta a fiocco del giovane. Nacque presto l’amore,
contrastato dalla famiglia di lui, che non vedeva di buon occhio
questa femminista ante litteram, oltre tutto di religione
protestante. Solo la sorella Angela D’Andreis (1809 – 56) gli rimase
sempre vicino, comprendendo le sue scelte politiche e sentimentali.
Gli storici hanno cercato invano tracce del matrimonio di Margaret e
Giovanni Angelo nei documenti ufficiali. Forse il loro fu un
matrimonio di coscienza, rimasto segreto. Risultano "coniugi" nel
certificato di battesimo del loro unico figlio, Angelo Eugenio
Filippo, nato a Rieti il 5 novembre del 1848. Margaret rimase per
due mesi con il piccolo, poi lo affidò a una balia e tornò a Roma,
dove forse andò ad abitare insieme con il marito presso la sorella
di lui, Angela, in via di Sant’Eufemia 188. Qui la situazione stava
rapidamente precipitando. Il 15 novembre c’era stato l’assassinio di
Pellegrino Rossi, ministro dell’interno del governo pontificio. Il
24 dello stesso mese Pio IX era fuggito da Roma su una carrozza
chiusa, vestito da sacerdote, per rifugiarsi a Gaeta. I patrioti
affluivano a Roma da tutta l’Italia. Ai primi di dicembre erano già
arrivati Garibaldi, Angelo Masina e Goffredo Mameli. Il
marchese Giovanni Angelo Ossoli era nato a Roma – ultimo di otto
figli - il 17 gennaio del 1821, da Filippo e Maria Anna Cleter. Il
suo casato era originario della Lombardia, ma si era stabilito nel
Lazio fin dal 1701. Alto e di bella presenza, timido e non molto
colto, si infiammò ben presto degli ideali mazziniani. Il 1° aprile
del 1847 – era giovedì santo – incontrò per caso a San Pietro una
donna americana più matura di lui, ma piena di fascino e di idee
progressiste, già affermata come giornalista nel suo paese: era
Margaret Fuller, che aveva perso di vista gli amici con i quali
stava assistendo ai Vespri. Il marchese, con galanteria tutta
latina, si offrì di riaccompagnare a casa la donna, che dal canto
suo era rimasta subito impressionata dall’aspetto malinconico e
dalla cravatta a fiocco del giovane. Nacque presto l’amore,
contrastato dalla famiglia di lui, che non vedeva di buon occhio
questa femminista ante litteram, oltre tutto di religione
protestante. Solo la sorella Angela D’Andreis (1809 – 56) gli rimase
sempre vicino, comprendendo le sue scelte politiche e sentimentali.
Gli storici hanno cercato invano tracce del matrimonio di Margaret e
Giovanni Angelo nei documenti ufficiali. Forse il loro fu un
matrimonio di coscienza, rimasto segreto. Risultano "coniugi" nel
certificato di battesimo del loro unico figlio, Angelo Eugenio
Filippo, nato a Rieti il 5 novembre del 1848. Margaret rimase per
due mesi con il piccolo, poi lo affidò a una balia e tornò a Roma,
dove forse andò ad abitare insieme con il marito presso la sorella
di lui, Angela, in via di Sant’Eufemia 188. Qui la situazione stava
rapidamente precipitando. Il 15 novembre c’era stato l’assassinio di
Pellegrino Rossi, ministro dell’interno del governo pontificio. Il
24 dello stesso mese Pio IX era fuggito da Roma su una carrozza
chiusa, vestito da sacerdote, per rifugiarsi a Gaeta. I patrioti
affluivano a Roma da tutta l’Italia. Ai primi di dicembre erano già
arrivati Garibaldi, Angelo Masina e Goffredo Mameli.
Ricevuta la notizia della fuga del Papa, il ministero Galletti si
dimise, ma la Camera dei deputati, confermati i poteri al Governo,
mandò una deputazione a Gaeta, che fu respinta ai confini
napoletani.
Il 21 e
22 gennaio del 1849 si tennero, senza incidenti, su tutto il
territorio dello Stato, le elezioni per la Costituente romana.
Nonostante il Papa avesse minacciato di scomunica tutti coloro che
vi avessero partecipato, l’afflusso alle urne fu straordinario. Il 9
febbraio, in Campidoglio, fu solennemente proclamata la Repubblica
Romana. Giovanni Angelo Ossoli, sergente della guardia civica,
mobilizzata all’inizio del 1849, fu arruolato nella seconda
compagnia del primo battaglione e si distinse nella difesa della
Repubblica assediata dalle truppe del generale Oudinot,
guadagnandosi il grado di capitano.
Intanto
Margaret, pur preoccupata per la vita del marito, prestava la sua
opera per la cura dei feriti, come regolatrice dell’ambulanza posta
all’ospedale dei Fatebenefratelli, all’Isola Tiberina. Dopo un
cannoneggiamento francese che aveva sconvolto la città, scrisse in
una lettera, rivolgendosi alla luna che saliva tra le nuvole: "è
possibile che il tuo globo guardi su una Roma che fuma e brucia e
veda il suo sangue migliore scorrere tra le pietre senza che ci sia
uno al mondo che la difenda, uno che venga in aiuto, neppure uno che
gridi un tardivo vergogna!"
Caduta
la Repubblica, il 3 luglio 1849 i francesi entrarono a Roma.
Margaret e Giovanni Angelo tornarono a Rieti per riprendersi il
figlio, quindi ripararono a Firenze. Le loro finanze si
assottigliavano ogni giorno di più. Giovanni Angelo, la cui famiglia
da tempo non era in condizioni floride, non aveva mai lavorato e le
corrispondenze di Margaret non bastavano a sbarcare il lunario.
Decisero di partire per l’America, anche se la giornalista era
innamorata del nostro Paese. Aveva scritto in un suo articolo:
"dovunque io vada una gran parte del mio cuore rimarrà sempre in
Italia. Spero che i suoi figli mi riconosceranno sempre come una
sorella, sebbene non sia nata qui".
Per
scarsità di mezzi finanziari, si imbarcarono – nel maggio del 1850 -
su un piroscafo mercantile a vela, la Elizabeth. All’alba del 19
luglio, a poca distanza dal porto di New York, la nave si incagliò
nelle secche di Fire Island e intorno alle due del pomeriggio colò a
picco trascinando con sé i due coniugi. Solo il corpo del
figlioletto toccò terra, ma ormai senza vita. Fu seppellito nel
cimitero di Mount Auburn, nel Massachusetts, nella tomba che è anche
memoriale dei suoi sfortunati genitori (nella foto).
di
Cinzia Dal
Maso
|
|
Il Risorgimento dei Romani |
|
Ulisse Seni, un eroe
di diciannove anni
 Nella
sua "Storia delle guerre d’Italia dal 18 marzo 1848 al 28 agosto 1849" Luigi
Scalchi riferiva i principali episodi avvenuti il 12 giugno 1849 durante la
difesa della Repubblica Romana: "il secondo battaglione del reggimento Unione
combattè a petto a petto coi Francesi per distruggere le loro opere d’assedio.
Il Maggiore Panizzi che comandava il battaglione cadde sul campo di battaglia.
Incontrarono pure la stessa sorte i due Ufficiali Cremonini e Giordani. In
questo fatto d'armi il Generale Bartolomeo Galletti diede prove di alta
fermezza, ed ebbe ferito il suo Ajutante di campo, il Capitano Warne. Fu ferito
parimente Ulisse Seni romano ufficiale nel 2° reggimento di linea. Esso fu
colpito da una palla di stutzen nel capo mentre comandava il fuoco a
sinistra contro il nemico avvicinato a porta S. Pancrazio; morì pochi giorni
dopo". Questo nostro coraggioso concittadino aveva appena 19 anni. Altre notizie
si apprendono dal Monitore Romano del 18 giugno. Ulisse Seni aveva il grado di
sottotenente e fu ferito mentre infondeva coraggio ai suoi soldati, comandando
il fuoco a sinistra nel tentativo di impedire l’avanzata dei Francesi a Porta
San Pancrazio. "Non si udì voce di lamento dal suo labbro nei tre giorni di
tormentosa agonia che dovette soffrire nello Spedale di Santa Maria della Scala
ove del bombardamento si udiva senza interruzione il rimbombo; ma in mezzo alle
convulsioni e nei vaniloqui del delirio, ripeteva parole d’incitamento alla
battaglia e d’ira contro le quattro nazioni che con inique lotte la Patria
dilaniavano". Il giovane spirò il 15 giugno, alle 9 di mattina. Nella
sua "Storia delle guerre d’Italia dal 18 marzo 1848 al 28 agosto 1849" Luigi
Scalchi riferiva i principali episodi avvenuti il 12 giugno 1849 durante la
difesa della Repubblica Romana: "il secondo battaglione del reggimento Unione
combattè a petto a petto coi Francesi per distruggere le loro opere d’assedio.
Il Maggiore Panizzi che comandava il battaglione cadde sul campo di battaglia.
Incontrarono pure la stessa sorte i due Ufficiali Cremonini e Giordani. In
questo fatto d'armi il Generale Bartolomeo Galletti diede prove di alta
fermezza, ed ebbe ferito il suo Ajutante di campo, il Capitano Warne. Fu ferito
parimente Ulisse Seni romano ufficiale nel 2° reggimento di linea. Esso fu
colpito da una palla di stutzen nel capo mentre comandava il fuoco a
sinistra contro il nemico avvicinato a porta S. Pancrazio; morì pochi giorni
dopo". Questo nostro coraggioso concittadino aveva appena 19 anni. Altre notizie
si apprendono dal Monitore Romano del 18 giugno. Ulisse Seni aveva il grado di
sottotenente e fu ferito mentre infondeva coraggio ai suoi soldati, comandando
il fuoco a sinistra nel tentativo di impedire l’avanzata dei Francesi a Porta
San Pancrazio. "Non si udì voce di lamento dal suo labbro nei tre giorni di
tormentosa agonia che dovette soffrire nello Spedale di Santa Maria della Scala
ove del bombardamento si udiva senza interruzione il rimbombo; ma in mezzo alle
convulsioni e nei vaniloqui del delirio, ripeteva parole d’incitamento alla
battaglia e d’ira contro le quattro nazioni che con inique lotte la Patria
dilaniavano". Il giovane spirò il 15 giugno, alle 9 di mattina.
di
Cinzia Dal Maso
|
|
Sposò Bartolomeo
Galletti e curò i feriti della Repubblica |
|
Anna de Cadilhac, la
"bella di Roma"
 Anna
Galletti de Cadilhac era nata a Roma il 24 marzo 1825 dal francese
Alessandro e dalla romana Maria Luisa Salandri-Magatti. Rimasta
orfana in tenerissima età, fu affidata alle cure della nonna e della
zia materna. Poco più che adolescente, si innamorò perdutamente del
conte Bartolomeo Galletti, che la ricambiava con passione. Il conte
doveva essere veramente un bell’uomo: Garibaldi lo avrebbe definito,
qualche anno più tardi, "un eroe bello al pari di un eroe
dell’antica Grecia, coraggioso, intelligente, devoto alla patria".
Anche se sorsero non pochi impedimenti, alla fine giunse il giorno,
anzi la notte del matrimonio: il 15 ottobre del 1842, dopo la
mezzanotte, a casa del parroco di San Giacomo in Augusta. Gli sposi
andarono ad abitare in piazza Pollarola. Il matrimonio avrebbe
cambiato la vita di Anna, contagiata dal patriottismo del marito.
Nel 1848 fu promotrice di una manifestazione di donne romane.
Organizzava feste per sovvenzionare gli ospedali, gli asili
d’infanzia, i soldati. Il popolo la chiamava la "bella di Roma". Anna
Galletti de Cadilhac era nata a Roma il 24 marzo 1825 dal francese
Alessandro e dalla romana Maria Luisa Salandri-Magatti. Rimasta
orfana in tenerissima età, fu affidata alle cure della nonna e della
zia materna. Poco più che adolescente, si innamorò perdutamente del
conte Bartolomeo Galletti, che la ricambiava con passione. Il conte
doveva essere veramente un bell’uomo: Garibaldi lo avrebbe definito,
qualche anno più tardi, "un eroe bello al pari di un eroe
dell’antica Grecia, coraggioso, intelligente, devoto alla patria".
Anche se sorsero non pochi impedimenti, alla fine giunse il giorno,
anzi la notte del matrimonio: il 15 ottobre del 1842, dopo la
mezzanotte, a casa del parroco di San Giacomo in Augusta. Gli sposi
andarono ad abitare in piazza Pollarola. Il matrimonio avrebbe
cambiato la vita di Anna, contagiata dal patriottismo del marito.
Nel 1848 fu promotrice di una manifestazione di donne romane.
Organizzava feste per sovvenzionare gli ospedali, gli asili
d’infanzia, i soldati. Il popolo la chiamava la "bella di Roma".
Nel
1849, durante la difesa della Repubblica Romana, si prodigò
nell’assistenza ai feriti, come sottodirettrice dell’Ospedale dei
Pellegrini, dove, come apprendiamo dalle sue memorie, servivano
anche Anna Mandolesi, Amalia Canini, Elisa Castellani Truvé e le sue
sorelle Francesca ed Augusta Castellani, l’intera famiglia di
Filippo Paradisi con moglie e tre figlie, tra cui Maria Paradisi
Ossani e Clelia Massimi, dilettante drammatica, con sua figlia. Si
viene anche a sapere che "Garibaldi,
quando la sera, al tardi, veniva a visitare i feriti, a cui facea
parole di conforto, non mancava mai di porgermi compagnia dopo la
mezzanotte in cui rincasavo, e mi chiamava l’angelo di quello
Spedale e mostravami profondo rispetto e deferenza. Spessissimo mi
portava i cordiali saluti della sua buona Annita".
"Pio IX
– scrisse Anna nelle sue memorie -
scomunicò tutte le signore che prestarono la loro opera ai feriti,
trattandoci come le ultime donne dell’abbietta società, mentre il
nostro unico scopo era di sollevare quei miseri, che tutto avevano
sacrificato all’altare della Patria... noi non eravamo state delle
meretrici, ma spinte solo dalla carità cristiana per salvare i
feriti ed assistere, consolando i morienti, lontani dalle loro
infelici famiglie, e che rigorosamente s’osservava che anche le
infermiere della notte, che non erano sotto la nostra vigilanza,
fossero tutte principalmente di specchiata moralità. La nostra opera
caritatevole non era solo per i nostri feriti, ma si estendeva con
eguale amore, compassione e carità anche ai nemici Francesi e
Napoletani ivi degenti".
Caduta
la Repubblica, Bartolomeo Galletti fu esiliato e Anna, rimasta a
Roma, si distinse per impegno politico e bellezza. Nel 1863
intrecciò una relazione con Vittorio Emanuele II, che le costò la
separazione dal marito.
Morì a Napoli, in
solitudine, nel 1896.
di
Cinzia Dal
Maso
|
|
I trecento effettivi
erano studenti, professori e impiegati della Sapienza |
|
Il Battaglione Universitario
che difese Roma Repubblicana
 A
seguito della caduta della Repubblica Romana, il 6 luglio 1849 si
sciolse anche il Battaglione Universitario Romano. I suoi
giovanissimi componenti si erano ricoperti di gloria nella difesa
della città, pagando un prezzo altissimo: 27 caduti, tra cui i
fratelli Alessandro e Francesco Archibugi. Così suonava un anonimo
canto risorgimentale del 1848: "quanta schiera di gagliardi, quanto
riso ne’ sembianti. / Quanta gioia negli sguardi vedi a tutti
scintillar. / Lieto evviva, lieti canti odi intorno a risuonar. /
D’impugnar moschetto e spada primo a offrire il nostro petto. / Di
salvar questa contrada giuriam tutti nel Signor. / Chi non giura è
maledetto, chi non giura è un traditor. / La vittoria è nostra
ancella, nostro sogno è libertà". Il Battaglione, che avrebbe dovuto
avere 8 compagnie, era formato da reduci della campagna del Veneto,
studenti, professori e impiegati della Sapienza. Vi erano ammessi
anche liceali, a patto che avessero compiuto il diciottesimo anno di
età, e gli allievi dell’Accademia di San Luca: in tutto 300
effettivi, "numero magico anche questo e nulla di più grandioso dei
trecento di Leonida e dei trecento Fabi", come scrisse Garibaldi ne
"I Mille". A
seguito della caduta della Repubblica Romana, il 6 luglio 1849 si
sciolse anche il Battaglione Universitario Romano. I suoi
giovanissimi componenti si erano ricoperti di gloria nella difesa
della città, pagando un prezzo altissimo: 27 caduti, tra cui i
fratelli Alessandro e Francesco Archibugi. Così suonava un anonimo
canto risorgimentale del 1848: "quanta schiera di gagliardi, quanto
riso ne’ sembianti. / Quanta gioia negli sguardi vedi a tutti
scintillar. / Lieto evviva, lieti canti odi intorno a risuonar. /
D’impugnar moschetto e spada primo a offrire il nostro petto. / Di
salvar questa contrada giuriam tutti nel Signor. / Chi non giura è
maledetto, chi non giura è un traditor. / La vittoria è nostra
ancella, nostro sogno è libertà". Il Battaglione, che avrebbe dovuto
avere 8 compagnie, era formato da reduci della campagna del Veneto,
studenti, professori e impiegati della Sapienza. Vi erano ammessi
anche liceali, a patto che avessero compiuto il diciottesimo anno di
età, e gli allievi dell’Accademia di San Luca: in tutto 300
effettivi, "numero magico anche questo e nulla di più grandioso dei
trecento di Leonida e dei trecento Fabi", come scrisse Garibaldi ne
"I Mille".
Simbolo
del Battaglione, la sua bandiera, che nella sua prima fase, durante
la campagna del ’48, aveva le fasce tessute in oro e argento, i
colori pontifici. Ma dopo che il 29 aprile di quello stesso anno Pio
IX aveva pronunciato la famosa allocuzione "Non semel", con
la quale sconfessava l’azione del suo esercito e la guerra
all’Austria, vennero sostituite con tre fasce tricolori sulle quali
furono applicate in nero delle scritte che ricordavano combattimenti
dal Battaglione.
Sulla
fascia verde si legge: Cornuda 8 maggio 1848 – Vicenza 20–24 maggio
e 20 giugno 1848; su quella rossa: Treviso 12 maggio 1848 – Roma 30
aprile 1849; sulla bianca: Battaglione Universitario – Palestrina 9
maggio 1849.
L’Università di Roma La Sapienza al tempo aveva sede in Corso
Rinascimento, nell’edificio attualmente occupato dall’Archivio di
Stato di Roma. Lì aveva quartiere anche il Battaglione, in alcuni
ambienti sulla sinistra di chi esce dal portone verso piazza
S.
Eustachio, dove oggi si trova la Biblioteca Alessandrina, affacciati
sul cortile attraverso finestre protette da inferriate. Fu proprio
da una di quelle finestre che uno studente riuscì a salvare la
bandiera, il 3 luglio del 1849, quando i Francesi, entrati da Porta
del Popolo, stavano per occupare l’Università. Pietro Pieri, questo
è il nome dello studente, porse il vessillo a Filippo Zamboni, già
nel cortile, che la staccò dall’asta e la nascose sotto la sua
giubba. Quindi tutti e due uscirono dalla porta posteriore
dell’Università. Qualche giorno dopo entrambi, con l’aiuto di un
professore di chimica, nascosero sotto una trave del soffitto
l’asta, che però non venne più trovata. La bandiera, invece, fu
gelosamente custodita dallo Zamboni, che se l’era fatta cucire dalla
madre all’interno della sua giacca. Lì rimase per molti anni, fino
al 1861, quando la fece scucire per esporla nella sua abitazione. Ma
Garibaldi, che conosceva l’importanza di quel cimelio, spinse lo
Zamboni a donarlo al Comune di Roma. La cerimonia di consegna si
tenne in Campidoglio, il 15 settembre del 1876, alla presenza del
sindaco Pietro Venturi. Dodici reduci del Battaglione sottoscrissero
il verbale di consegna. Il Comune di Roma volle donare allo Zamboni
una copia del prezioso vessillo, oggi al Museo Civico di Trieste.
La
bandiera originale, invece, andò nel Vittoriano, presso l’Istituto
per la Storia del Risorgimento Italiano. Le fasce sono custodite dal
Comune di Roma. La bandiera fu mostrata alla prima Esposizione
Nazionale di Torino, nella sezione dedicata al Risorgimento, quindi
fu esposta all’Università di Bologna nel 1897, in occasione del
primo centenario del nostro tricolore. Il 15 settembre 1941 la
gloriosa bandiera avvolse l’urna con i resti mortali di Goffredo
Mameli, provvisoriamente traslati dalla tomba del Verano al
Vittoriano, prima di essere definitivamente collocati nel Mausoleo
del Gianicolo.
di
Cinzia Dal
Maso
|
|
Partecipò alla difesa della Repubblica Romana |
|
Il Battaglione della
Speranza,
un manipolo di eroi bambini
 Nel
novembre del 1847 un ex ufficiale piemontese, Pantier, raccolse alcuni
adolescenti romani e cominciò ad addestrarli militarmente: nasceva così il
Battaglione della Speranza, in seguito capitanato da Masserano e aggregato alla
Guardia Civica Mobilizzata di Roma comandata dal colonnello Palazzi. Nel
novembre del 1847 un ex ufficiale piemontese, Pantier, raccolse alcuni
adolescenti romani e cominciò ad addestrarli militarmente: nasceva così il
Battaglione della Speranza, in seguito capitanato da Masserano e aggregato alla
Guardia Civica Mobilizzata di Roma comandata dal colonnello Palazzi.
Il primo di
ottobre del 1848, un primo gruppo di quei ragazzini in divisa si radunò nella
locanda Martignoni, in via della Lungara, alla presenza di Angelo Brunetti,
Ciceruacchio. Dopo aver eseguito alcune esercitazioni, i giovinetti si sedettero
a tavola con Ciceruacchio, che improvvisò per loro dei versi: "Viva
la nuova Civica / più non temiam perigli / d’antichi eroi siam polvere / del
Nono Pio siam figli".
Nel 1849 il
Battaglione – forte di 33 elementi - partecipò attivamente alla difesa di Roma,
distinguendosi soprattutto alla breccia dell’ottavo bastione, presso Porta San
Pancrazio, dove si fece ricordare il Della Porta.
Così scriveva, nel
1850, una penna reazionaria, quella di Gaetano Valeriani: "verso il cadere della
Repubblica alla mobilizzata si associò una Compagnia d'imberbi ragazzetti, che
portava il nome di Battaglione della Speranza, titolo che esprimeva la
speranza che doveano in esso nutrire i popoli, come in un semenzajo d'invitti
campioni futuri. Ed esteri e nazionali tenevano in ridicolo questo Corpo
microscopico, i componenti il quale, nella maggior parte, avean bisogno tuttora
delle cure materne della nutrice. A questi elementi si affidava la salvezza,
anzi l’eternità, della Repubblica Romana!"
La piccola
formazione diede il suo tributo di sangue alla causa repubblicana, con almeno
quattro morti, tutti dodicenni. Tre di loro erano romani: David Bucchi,
Francesco Michelini e il tamburino Attilio Zampini, caduto il 30 giugno. Il
romagnolo Vincenzo Matteucci era morto il 3 giugno.
Tra i feriti, il
quattordicenne Antonio Lizzani, appartenente a una nota famiglia romana di
patrioti.
Gli "Speranzini"
erano impudenti e sfrontati. Uno di loro riuscì persino, sollevato da alcune
persone, a tagliare la penna rossa del cappello di una guardia svizzera, mentre
uno dei suoi compagni si impadroniva dell’alabarda di un altro svizzero.
Furono tanti gli
episodi eroici che ebbero per protagonisti questi piccoli soldati che gli stessi
francesi, una volta caduta la città, vollero rendere omaggio al loro valore.
Ma l’intera difesa
della Repubblica si avvaleva, in ogni suo reparto, di giovanissimi, se non
addirittura di bambini. Erano tamburini, portaordini, attendenti, ma spesso
combattevano, in un misto di coraggio e di incoscienza. I francesi erano
incuriositi dalle voci argentine e squillanti che arrivavano fino alle loro
postazioni, oltrepassando i bastioni. Un giorno si informarono presso un
ufficiale italiano che era andato a parlamentare. "Sono i nostri giovanetti –
rispose questi – che da 12 a 13 anni si arruolano nella truppa per combattere in
difesa della libertà della Patria".
Essenziale era la
funzione dei tamburini. Quegli stessi che durante le parate, nelle loro
sgargianti divise, segnavano il passo dei soldati, si ritrovavano nei
combattimenti scamiciati e laceri, come si vede in una stampa di Luigi Calamatta,
per incitare alla lotta e alla resistenza, battendo convulsamente sui loro
tamburi la "carica".
Emblematica la
storia di un giovane ciociaro, Domenico Subiaco, nato a Ripi il 4 dicembre 1832
da due contadini, Giovanni e Angela Maria Paparelli. Appena sedicenne, nel 1849
volle essere tra i difensori della Repubblica Romana. Per la sua statura, non fu
ritenuto adatto al combattimento. Non gli venne affidato un fucile, ma fu
nominato tamburino del I Reggimento Fanteria e come tale prese parte a più di
una battaglia. Il 3 giugno era sul Gianicolo, sotto il fuoco del generale
Oudinot.
Come racconta
Ceccarius, Domenico suonò l’allarme e la carica. Poi, gridando "viva l'Italia!"
e "viva Roma!", "raccolse il fucile di un soldato caduto al suo fianco,
spianandolo contro il nemico, ma una palla francese lo colpì nel mezzo della
fronte".
L’episodio è
riferito anche da Camillo Ravioli: "dall’alto della porta di S. Pancrazio tirò a
petto scoperto gettata l'uniforme - e lo vid’io nel mattino di quel giorno
stesso 3 giugno - da dieci a dodici colpi contro i francesi che assalivano il
bastione ottavo, facendosi porgere l'arma carica dai compagni che gli erano di
sotto, finché una palla nemica lo colpì nel parietale sinistro e lo gettò
rovescio e moribondo a basso".
di
Cinzia Dal Maso
|
|
Il Risorgimento dei
Romani |
|
Settimi, uno
dei tanti eroici popolani
Dal 30 aprile al 30
giugno 1849, la partecipazione dei romani, trasteverini e non, alla difesa della
Città Eterna, fu piena e convinta. "Roma, nell’insieme del suo popolo – scriveva
Aurelio Saffi a sua madre – non si è levata mai a tanta moralità, a tanta
dignità, a tanta grandezza di sentimenti generosi, quanto al presente",
aggiungendo che "la virtù e il coraggio di questo popolo supera ogni lode, è un
popolo degno della libertà per cui combatte". Purtroppo, della maggior parte di
questi umili eroi si è persa la memoria. Particolarmente interessante è, quindi,
una dichiarazione di Giovanni Venanzi, difensore della Repubblica e dopo il 1867
Consigliere comunale di Roma, relativa alla giornata del 30 aprile 1849: "fra i
volontari sortiti all’aperto dalla Porta S. Pancrazio e scorrazzanti in quei
pressi, ebbi più volte a notare un popolano dall’accento schiettamente romano,
senza cappello e dai capelli grigi, il quale si distingueva per l’arrischiato
coraggio e l’esaltamento da cui era invaso. Col fucile impugnato e gridando
ferocemente egli appariva e rispariva saltando fossi e burroni e correndo
anelante in traccia del nemico".
Quella stessa sera,
Venanzi ritrovò l’uomo tra i morti deposti presso la Sacrestia di San Pietro in
Montorio. Ne osservò i lunghi capelli grigi, il corto naso, il colorito pallido,
l’alta statura, la taglia svelta e nerboruta. Poteva avere cinquanta anni. Era
vestito di una camiciola di velluto color oliva, calzoni lunghi e scuri, calze
bianche e scarpe accollate. La camicia, semiaperta, era di tela grossolana, ma
bianchissima. Sul petto, sotto l’apertura, era ricamato in rosso il suo cognome:
Settimi.
di
Cinzia Dal Maso
|
|
I Romani e il
Risorgimento |
|
Filippo Casini, il
leone della Montagnola
 Filippo
Casini, nato il 13 gennaio 1822 a Roma, si era laureato in
ingegneria. Conosceva sette lingue e si era meritato l’alto grado di
ufficiale onorario di artiglieria. Nella terribile notte tra il 29 e
il 30 giugno del 1849 – con Roma assediata dai francesi - si era
offerto volontario, "senza soldo e senza ascenzo", per il comando
dell’ultima batteria della difesa, quella della Montagnola, presso
San Pietro in Montorio. Venne accontentato. Intorno a lui cadevano
tutti i suoi soldati, insieme con l’altro tenente, anch’esso romano,
Oreste Tiburzi. Rimasto solo, Casini, a cavalcioni di un cannone,
continuò a tirare terribili fendenti con la sciabola, finché non
cadde a terra coperto di sangue. I francesi lo ritennero morto. Solo
il mattino seguente, nel corso di una perlustrazione, si accorsero
che era ancora vivo e lo trasportarono in un’ambulanza. Il medico
francese che lo soccorse, in un rapporto sulla Gazette Medicale de
Paris, ne descrisse l’eroico comportamento: "è stato portato
all’Ambulanza medica di Villa Pamphili un Ufficiale dell’Artiglieria
romana, che aveva il cranio spaccato da dodici colpi di sciabola,
una coscia forata da dodici colpi di baionetta, e una doppia
frattura al braccio destro. Egli aveva difeso la sua batteria come
un leone difende la sua prole e ha ceduto soltanto quando alla sua
volontà più non obbediva il braccio fracassato". Il coraggio di
Casini aveva toccato il cuore dei francesi. Lo stesso generale
Oudinot volle andare a trovarlo per elogiarne la condotta e per
specificare che lo riteneva non un prigioniero ma un ospite. Fu
accompagnato a casa dalla madre, in via Paola, su una barella
scortata dal picchetto d’onore francese. Purtroppo il suo fisico era
rimasto minato e l’eroe sarebbe morto un anno dopo, il 15 agosto
1850, per marasma. Filippo
Casini, nato il 13 gennaio 1822 a Roma, si era laureato in
ingegneria. Conosceva sette lingue e si era meritato l’alto grado di
ufficiale onorario di artiglieria. Nella terribile notte tra il 29 e
il 30 giugno del 1849 – con Roma assediata dai francesi - si era
offerto volontario, "senza soldo e senza ascenzo", per il comando
dell’ultima batteria della difesa, quella della Montagnola, presso
San Pietro in Montorio. Venne accontentato. Intorno a lui cadevano
tutti i suoi soldati, insieme con l’altro tenente, anch’esso romano,
Oreste Tiburzi. Rimasto solo, Casini, a cavalcioni di un cannone,
continuò a tirare terribili fendenti con la sciabola, finché non
cadde a terra coperto di sangue. I francesi lo ritennero morto. Solo
il mattino seguente, nel corso di una perlustrazione, si accorsero
che era ancora vivo e lo trasportarono in un’ambulanza. Il medico
francese che lo soccorse, in un rapporto sulla Gazette Medicale de
Paris, ne descrisse l’eroico comportamento: "è stato portato
all’Ambulanza medica di Villa Pamphili un Ufficiale dell’Artiglieria
romana, che aveva il cranio spaccato da dodici colpi di sciabola,
una coscia forata da dodici colpi di baionetta, e una doppia
frattura al braccio destro. Egli aveva difeso la sua batteria come
un leone difende la sua prole e ha ceduto soltanto quando alla sua
volontà più non obbediva il braccio fracassato". Il coraggio di
Casini aveva toccato il cuore dei francesi. Lo stesso generale
Oudinot volle andare a trovarlo per elogiarne la condotta e per
specificare che lo riteneva non un prigioniero ma un ospite. Fu
accompagnato a casa dalla madre, in via Paola, su una barella
scortata dal picchetto d’onore francese. Purtroppo il suo fisico era
rimasto minato e l’eroe sarebbe morto un anno dopo, il 15 agosto
1850, per marasma.
Venne
seppellito in San Carlo al Corso, dove è ricordato da un monumento.
La sua tomba, però, non è stata ritrovata.
di
Cinzia Dal
Maso
|
|
Il Risorgimento dei
romani |
|
Paolo
Narducci, il primo illustre caduto per Roma repubblicana
 La
solenne sconfitta subita il 30 aprile 1849 dai francesi all’assedio di Roma fu
determinata anche dal coraggio di un giovane romano. Paolo Narducci era nato l’8
giugno del 1829 ed era stato battezzato in San Pietro. Aveva studiato con
profitto prima disegno all’Accademia di San Luca, poi filosofia e matematica. La
solenne sconfitta subita il 30 aprile 1849 dai francesi all’assedio di Roma fu
determinata anche dal coraggio di un giovane romano. Paolo Narducci era nato l’8
giugno del 1829 ed era stato battezzato in San Pietro. Aveva studiato con
profitto prima disegno all’Accademia di San Luca, poi filosofia e matematica.
Nel marzo del 1848
avrebbe voluto partecipare alla prima guerra di indipendenza, ma i suoi genitori
non glielo permisero. Intanto diventava cadetto d’artiglieria e poi tenente in
seconda. Appena saputo dello sbarco delle truppe di Oudinot a Civitavecchia
chiese e ottenne di essere mandato in prima linea, destinato prima a Porta
Angelica, quindi ai bastioni di Santa Marta sui Giardini Vaticani, vicino alla
Porta Pertusa. Qui si rese subito conto che la via Aurelia, da cui sicuramente
sarebbe giunto il nemico, era difesa solo da due obici posti in cannoniere male
costruite e disse ai suoi colleghi: "qui con quattro colpi di cannone mi
mandano per aria i parapetti e gli artiglieri, e da queste vigne dovrò finire
con una palla in petto". Quindi avvertì il comando dell’esistenza di una
strada che girava alle falde di Monte Mario e poteva essere usata dal nemico per
sorprendere Porta Angelica, di cui chiese di rinforzare le difese. Come il
giovane aveva previsto, una parte dei francesi prese la strada a valle di Monte
Mario per tentare di ricongiungersi al resto della truppa che intendeva entrare
nei giardini vaticani dopo aver sfondato la Porta Pertusa. Qui però gli
assalitori trovarono il coraggio e la tenacia del Narducci, che seppe battersi
come un vecchio soldato, mentre i suoi gli cadevano ai piedi morti o feriti. Fu
anche costretto a caricare e puntare il cannone da solo, finché una palla di
stutzen lo ferì mortalmente al petto. Ma i francesi non entrarono. Paolo
Narducci morì all’ospedale di Santo Spirito alle due e mezza del mattino del 2
maggio.
di
Cinzia Dal Maso
|
|
LUIGI CALAMATTA
RIFIUTÒ DI FARE UN RITRATTO A LAMARTINE |
|
UNA
RISPOSTA DAVVERO PUNGENTE

Tra gli illustri personaggi che ebbero
i natali a Civitavecchia, un posto a parte merita Luigi Calamatta.
Nato il 21 giugno 1801, rimase orfano in tenera età e fu inviato da
uno zio a Roma, all'Ospizio di S. Michele, perché vi apprendesse un
mestiere. I suoi insegnanti si accorsero ben presto che il fanciullo
era abilissimo nel disegno e lo introdussero all’arte
dell’incisione. Uscito a 19 anni dall’Istituto, lavorò con valenti
maestri, tra cui lo scultore Bertel Thorvaldsen. Fu a Parigi che il
Calamatta raggiunse la gloria: le sue incisioni erano richiestissime
ed erano ritenute insuperabili. Durante un banchetto nella Capitale
francese, il poeta Lamartine, tristemente famoso per aver chiamato
l’Italia "terra di morti", gli chiese di fargli un ritratto. Il
Calamatta gli rispose di essere italiano e lo invitò a cercare fra i
vivi chi gli volesse fare l'effigie.
di Cinzia
Dal Maso |
|
GIACINTO BRUZZESI,
GARIBALDINO, PARTECIPÒ ALLA SPEDIZIONE DEI MILLE |
|
UN ILLUSTRE CITTADINO DI CERVETERI

Il 12 dicembre 1822 nasceva a
Cerveteri – da Lelio Antonio Bruzzesi e Barbara Ponziani – un bimbo
che fu chiamato Giacinto Leopoldo Gaetano. Ad impartigli il
sacramento del Battesimo fu quell’Arciprete Regolini che sarebbe
diventato famoso per aver scoperto nella necropoli del Sorbo,
nell’aprile del 1836, la più ricca tomba etrusca, con il suo
splendido corredo di oreficerie. Giacinto Bruzzesi fu ufficiale
della Repubblica Romana del 1849, meritando una medaglia d’oro al
valore. Partecipò alla seconda guerra di indipendenza e alla
spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi. A testimonianza
della sua vita avventurosa, resta un volume autobiografico: "Dal
Volturno ad Aspromonte, memorie del colonnello Giacinto Bruzzesi.
Diario di campo, documenti diplomatici e dello Stato Maggiore,
relazioni..."
Riuscì a scampare ai pericoli di tante
battaglie e morì ormai anziano, nel 1899, dopo aver visto l’Italia
unita, con Roma per Capitale.
di Cinzia
Dal Maso |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
|
NEL 1849 A
ROMA DIRESSE IL COMITATO DI SOCCORSO DEI FERITI E LE AMBULANZE |
|
Cristina Trivulzio di Belgiojoso,
la principessa odiata dai francesi
 Nella
primavera del 1849, la disperata difesa della Repubblica Romana dai
francesi del generale Oudinot vide accorrere uomini da tutta
l’Italia, organizzati alla meglio. Alcuni corpi diventeranno famosi,
come la Legione Italiana di Garibaldi, la Legione Romana, i
Bersaglieri Lombardi di Manara, la legione dei Volteggiatori
Italiani di Giacomo Medici. Ma anche numerose donne seppero dare un
indispensabile apporto nei modi più disparati. Tra loro spicca
Cristina Trivulzio di Belgiojoso, principessa della migliore
aristocrazia lombarda, nata a Milano nel 1808, una "patriota
impegnata, intellettuale ed esule", come la descrivono Ginevra
Conti Odorisio e Fiorenza Taricone" nel volume "Per filo e per
segno" (Giappichelli Editore).
Crebbe
in una casa in cui respirò fin dall’infanzia un clima di
cospirazione, frequentata da personaggi come Silvio Pellico,
Federico Confalonieri e Gian Domenico Romagnosi. Un ritratto di
Francesco Hayez del 1832 ne mostra i capelli scurissimi come gli
occhi profondi e indagatori, un sobrio vestito nero che però lascia
scoperte spalle e braccia.
"Dopo
la sconfitta piemontese", spiegano Conti Odorisio e Taricone, "decise
di recarsi nella Repubblica romana, nella quale vide la possibilità
di costruire un primo Stato italiano indipendente. Si unì così a
Mazzini, nominato da poco triumviro, pur non condividendo tutti i
suoi principi".
A Roma
la situazione era drammatica. Le bombe francesi facevano strage di
civili e di soldati, dopo ogni scontro non si sapeva più dove
mettere i feriti, né con cosa soccorrerli e curarli. Mazzini affidò
a Cristina l’organizzazione della sanità pubblica e dei convogli di
ambulanze militari, oltre alla direzione del comitato di soccorso di
cui facevano parte Enrichetta di Lorenzo, compagna di Pisacane, la
marchesa Giulia Paulucci e l’americana Margaret Fuller.
Cristina lanciò un appello alle donne romane affinché la aiutassero
ad assistere i feriti. L’avviso è datato 27 aprile 1849 e recita: "nel
momento che un Cittadino offre la vita in servizio della Patria
minacciata, le Donne debbono anche esse prestarsi nella misura delle
loro forze e dei loro mezzi... sin d’oggi si è pensato di comporre
una Associazione di Donne allo scopo di assistere i Feriti, e di
fornirli di filacce e di biancherie necessarie. Le Donne Romane
accorreranno, non v’ha dubbio, con sollecitudine a questo appello
fatto in nome della patria carità.. Le
offerte in biancheria, filacce ecc. ecc. possono pure essere dirette
alle Cittadine componenti il Comitato..."
Furono
moltissime a rispondere alla chiamata, di tutte le classi sociali e
di ogni regione, persino straniere, dame irreprensibili ma anche
alcune prostitute di professione. Ne scelse trecento con una
durissima selezione, che tenne conto certamente più dell’interesse
dei feriti che della morale. Il loro impegno non conosceva riposo.
Faceva caldo e per essere più libere nei movimenti non si
preoccupavano di prodigarsi con le maniche rimboccate, un vero
scandalo per la società ipocrita dell’epoca, ma soprattutto per Pio
IX, che nell’Enciclica "Noscitis et Nobiscum", lamentava che
"più d’una volta gli stessi miseri infermi già presso a morire,
sprovveduti di ogni conforto della Religione, furono astretti ad
esalare lo spirito fra le lusinghe di sfacciata meretrice".
La
Belgiojoso rispose al Pontefice con una lettera pacata ma decisa nei
toni di non voler sostenere "che tra la moltitudine di donne che,
durante il maggio e giugno del 1849, si dedicarono alla cura dei
feriti non ve ne fosse neppure una di costumi reprensibili". "Vostra
Santità – continuava
- si degnerà
sicuramente di considerare che non disponevo della Polizia
Sacerdotale per indagare nei segreti delle loro famiglie, o meglio
ancora dei loro cuori". La cosa più importante era però che
quelle donne "erano state per giorni e giorni al capezzale dei
feriti; non si ritraevano davanti alle fatiche più estenuanti, né
agli spettacoli o alle funzioni più ripugnanti, né dinnanzi al
pericolo, dato che gli ospedali erano bersaglio delle bombe
francesi". Anche la
stampa dell’epoca volle fare la sua parte, incolpandola di fare
alzare la febbre ai pazienti con la sua bellezza. I gazzettisti
francesi, in particolare, velenosamente criticarono quelle donne
pietose che rincuoravano e curavano anche i loro connazionali
feriti. Padre Bresciani, un gesuita molto noto all’epoca, le chiamò "svergognate,
che tenean luogo del demonio tentatore al capezzale di quegli
infelici..." e definì la Belgiojoso "sfacciata ed impudente".
La
Belgiojoso faticò non poco a reperire i locali dove poter accogliere
e curare i feriti, effettuando vari sopralluoghi in chiese e
conventi. Alla fine mise in piedi ben dodici ospedali militari tra
cui quello ampio nel Quirinale e organizzò il primo corpo di
infermiere volontarie. Si occupò anche del sostentamento dei malati,
chiedendo con insistenza al Triumvirato di continuare a pagare il
soldo ai militari feriti. Tante e tali furono le sue critiche al
governo provvisorio, che Mazzini la definì "un vero tormento".
Fu lei
ad assistere amorosamente Goffredo Mameli nella sua agonia
all’Ospedale della Trinità dei Pellegrini, dove era entrato per una
medicazione e un breve ricovero. Ma sembra che, nella concitazione
del momento, gli fosse stato estratto dalla gamba un proiettile,
dimenticando però lo stoppaccino, ossia la garza contenente la
polvere da sparo, provocando la cancrena. Quando la Belgiojoso se ne
accorse, le sue urla si udirono per tutta la corsia. Nemmeno
l’amputazione della gamba riuscì a salvare il giovane poeta, che
spirò tra le braccia della principessa il 6 luglio. Proprio in quei
giorni Cristina scrisse in un lettera all’amica Jaubert: "Per
quanto sia grande la vostra immaginazione, non vi raffigurerete mai
la realtà dolorosa della mia vita durante i bombardamenti di
Roma...Potevo addormentarmi, sapendo di non ritrovare vivi, al mio
risveglio, tutti coloro che con voce flebile la sera mi avevano
augurato una notte tranquilla? Potevo prevedere quante mani avevano
stretto la mia per l’ultima volta? Quanti lenzuoli rovesciati sul
guanciale mi avrebbero annunciato alla vista del mattino, un martire
in più?"
La
Repubblica Romana cadde il 3 luglio, e dopo circa un mese la
Belgioioso dovette lasciare la città, avvertita da un prete a cui
aveva salvato la vita che un fascicolo che la riguardava era sul
tavolo di un cardinale, con la scritta "sentimenti irreligiosi".
Le accuse più ingiuste e
infamanti, però, furono quelle di furti e di malversazione
nell’amministrazione delle ambulanze.
di Cinzia
Dal Maso e Antonio
Venditti |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
|
LA
LAPIDE A VIA DELLA LUNGARETTA NE RICORDA LA TRAGICA MORTE |
|
Un’eroina trasteverina:
Giuditta Tavani Arquati
Nella storia di Roma antica e recente si distinguono numerose figure
femminili che hanno partecipato con fermezza e coraggio al complesso
fenomeno culturale della guerra. Tra le eroine rinascimentali, non
si può dimenticare Giuditta Tavani Arquati, della cui tragica morte
è appena caduto l’anniversario.
Era nata a Roma
nel 1836 e visse a Trastevere, dove sposò nella chiesa di San
Crisogono Francesco Arquati, di umile condizioni, da cui ebbe molti
figli. A causa di ristrettezze economiche, la famiglia fu costretta
a trasferirsi a Venezia in cerca di lavoro, ma tornò ben presto a
Roma.
I
convulsi avvenimenti del 25 ottobre 1867 sono efficacemente narrati
nel suo recente volume ""Donne e Guerra. Dire, fare, subire"
(Elsa di Mambro Editore, 300 pagine, euro 19,90) da Fiorenza
Taricone, docente di Storia delle Dottrine politiche e di Pensiero
politico e Questione femminile presso l’Università di Cassino.
 "Nella
fabbrica di Giulio Ajani alla Lungaretta, capo delle cospirazioni di
Trastevere, quaranta patrioti fra cui l’Arquati, accompagnato dalla
moglie e un figlio, si erano riuniti per organizzare una rivolta",
riferisce la Taricone. "Nella
fabbrica di Giulio Ajani alla Lungaretta, capo delle cospirazioni di
Trastevere, quaranta patrioti fra cui l’Arquati, accompagnato dalla
moglie e un figlio, si erano riuniti per organizzare una rivolta",
riferisce la Taricone.
Purtroppo ci fu una spiata. L’edificio fu circondato da trecento tra
zuavi e gendarmi. "I patrioti, asserragliati, presero le armi e
Giuditta prestava aiuto soccorrendo i feriti, porgendo le munizioni.
Quando, invece dell’intervento di altri patrioti sopraggiunsero
rinforzi zuavi – prosegue - la sorte dei combattenti fu segnata e
durò fino a che, mancando le armi, i soldati entrarono abbattendo la
porta". Fu l’inferno: i cospiratori che non erano riusciti a fuggire
vennero barbaramente trucidati. Giuditta, raggiunta da numerosi
colpi d’arma da fuoco, vide il marito e il figlio Antonio, appena
diciassettenne, trapassati da colpi di baionetta con tale foga da
bucare il muro dietro di loro. I carnefici quindi si accanirono su
di lei e la finirono penetrando con le lame più volte nel ventre che
conteneva una nuova vita.
 Terminato
il massacro, gendarmi e zuavi si sedettero alla mensa preparata da
Giuditta e brindarono alla vittoria, in mezzo a tutto quel sangue e
ai cadaveri orrendamente trucidati. Terminato
il massacro, gendarmi e zuavi si sedettero alla mensa preparata da
Giuditta e brindarono alla vittoria, in mezzo a tutto quel sangue e
ai cadaveri orrendamente trucidati.
La
tragedia rimase a lungo nella mente dei romani. Ne fu testimone il
patriota Alberto Mario, che si trovava a Roma il 25 ottobre del
1870, nella ricorrenza del terzo anniversario. "Fino dal mattino –
ricordava - la casa Ajani n. 97 in via della Lungaretta era
fastosamente addobbata a lutto con damaschi neri a fettoni fimbriati
in oro. Nel mezzo dell’addobbo sorgeva un busto naturale di donna
ancora giovane con aspetto e forme di matrona antica; aspetto e
forme che ancora si ravvisano nelle donne trasteverine. Sotto al
busto, un’iscrizione; e più sotto, altre tre. Corone di fiori di
lauro pendevano intorno. Tutta la via della Lungaretta era cosparsa
di foglie d’alloro. Da tutte le abitazioni sventolavano bandiere
tricolori. La porta principale della casa Ajani stava aperta. La
gente v’entrava, visitava gli appartamenti e ne usciva per una porta
laterale che mette in altra contrada. Il giorno 25 non meno di
settantamila persone furono a quella casa, ed altrettante nei giorni
seguenti: Io ci andai due volte ed era una interminabile processione
di pedoni e di carrozze, alcuna delle quali anche di principi
romani. Al vespero del 25 accorsero in corpo l’associazione dei
reduci delle patrie battaglie in colonna di cinquecento, le
rappresentanze dei quattordici rioni portando bandiere a bruno e tre
bande musicali che accrescevano la mestizia universale con musiche
funebri".
La ressa era tale che
Alberto Mario riuscì a entrare nella casa solo il 29 ottobre. Ne
riportò un’impressione fortissima: "dove giacquero trucidati la
Giuditta e il marito e il figlio sorgeva una croce in marmo
vagamente scolpita, dono dei marmisti di Roma: sulla parete
pendevano corone di fiori e di sempreverdi appese dai visitatori.
Vedevansi nell’intonaco della parete i buchi fatti dalle baionette
nel passar da parte a parte i corpi di quei gloriosi infelici e la
parete spruzzata di sangue e larghe macchie sanguigne sul pavimento.
Simili buchi e macchie e colpi di palla proprio al basso della
parete presso al pavimento si vedevano anche nella stanza vicina.
Nel mezzo della quale alzavasi un tumulo ove leggevasi i nomi di
tutti caduti. Il colore tetro degli apparati, le corone, le
iscrizioni, i segni orrendi di quella tragedia e l’immagine viva
della donna sublime, stringevano il cuore".
di Cinzia
Dal Maso e Antonio
Venditti |
|
SPECIALE
RISORGIMENTO -
SPECCHIO ROMANO |
|
UN ARTISTA OLANDESE POSÒ IL PENNELLO PER IMBRACCIARE IL FUCILE |
|
LE MEMORIE ROMANE DI
JAN PHILIP KOELMAN
 Nella
primavera del 1844 un giovane pittore olandese, Jan Philip Koelman,
raggiunse a Roma il suo maestro, Cornelis Kruseman. Non si era
ancora fatto un nome come artista, ma era disinvolto, versatile e
molto dotato. Nato a L’Aia il 10 marzo 1818, si presentava elegante
e di belle maniere, come si vede nell’autoritratto ora nelle
collezioni del comune natale, realizzato nel 1852, in cui appare
sfarzosamente vestito con una mantellina nera dalla fodera color
tabacco, camicia azzurra e cravatta romana. L’antico sarcofago sullo
sfondo, oggi al Museo Nazionale Romano, permette di localizzare la
scena nel parco della villa Celimontana, dove aveva preso dimora la
principessa Marianna d’Olanda, figlia di re Guglielmo I. Ben presto
i suoi quadri furono molto apprezzati, anche per i soggetti
romantici e folkloristici: sono animati paesaggi di Genazzano o di
Subiaco, ma anche soggetti di genere, come una ciociara addormentata
o un gruppo di ragazzini che gioca su uno dei leoni alla base della
scalinata dell’Aracoeli. Nella
primavera del 1844 un giovane pittore olandese, Jan Philip Koelman,
raggiunse a Roma il suo maestro, Cornelis Kruseman. Non si era
ancora fatto un nome come artista, ma era disinvolto, versatile e
molto dotato. Nato a L’Aia il 10 marzo 1818, si presentava elegante
e di belle maniere, come si vede nell’autoritratto ora nelle
collezioni del comune natale, realizzato nel 1852, in cui appare
sfarzosamente vestito con una mantellina nera dalla fodera color
tabacco, camicia azzurra e cravatta romana. L’antico sarcofago sullo
sfondo, oggi al Museo Nazionale Romano, permette di localizzare la
scena nel parco della villa Celimontana, dove aveva preso dimora la
principessa Marianna d’Olanda, figlia di re Guglielmo I. Ben presto
i suoi quadri furono molto apprezzati, anche per i soggetti
romantici e folkloristici: sono animati paesaggi di Genazzano o di
Subiaco, ma anche soggetti di genere, come una ciociara addormentata
o un gruppo di ragazzini che gioca su uno dei leoni alla base della
scalinata dell’Aracoeli.
Nella
città eterna c’era anche il fratello minore di Jan Philip, Jan
Hendrik. Pittore anch’egli, specializzato in minuscoli ritratti su
avorio o in piccole composizioni a olio o acquerello, una sorta di
souvenir di lusso per stranieri in visita a Roma, aveva sposato una
vedova di tredici anni più anziana di lui, la miniaturista Enrica
Fioroni. Aveva il suo studio in un antico convento, in via dell’Olmata
86, vicino a Santa Maria Maggiore. Quando, nel 1851, gli sposi si
trasferirono con il figlio Romolo nella casa che avevano acquistato
nei pressi, anche Jan Philip andò ad abitare con loro.
I due
fratelli, liberali e pieni di fervore, furono testimoni dei
concitati avvenimenti che videro proclamare la Repubblica Romana e
tentarne l’eroica difesa, fino al tragico epilogo. Si arruolarono
nel corpo dei volontari e collaborarono attivamente alla resistenza
alle truppe francesi presso Porta San Pancrazio.
Durante
la sua lunga permanenza a Roma, Jan Philip Koelman aveva tenuto un
diario che in un seguito rielaborò per quanto riguarda il suo
periodo più interessante, quello cioè che va dal 1846 al 1851. Tali
memorie furono pubblicate a puntate in una rivista settimanale
liberale, "De
Nederlandsche Spectator", in due serie: "In
Roma", uscita nel 1863, e "La
presa di Roma", del
1865. Nel 1869 furono pubblicati in due volumi dall’editore Thieme.
L’edizione italiana, a cura di Maria Luisa Trebiliani, è del 1963,
per l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.
Nei due volumi,
appassionanti come un romanzo, il pittore narrava con dovizia di
particolari gli episodi che si erano svolti davanti ai suoi occhi
attenti e interessati, dall’animatissimo carnevale degli artisti
alle grotte di Cervara, all’illuminazione della cupola di San
Pietro, alle cerimonie pontificali sotto Gregorio XIII o
ai disordini che accompagnarono l’uccisione del ministro Pellegrino
Rossi, il 15 novembre del 1848.
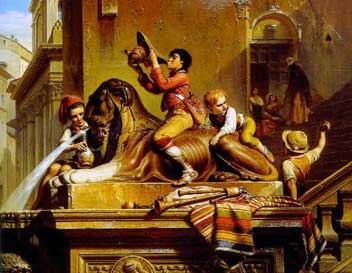 Particolarmente
significativo il secondo volume, nel quale il pacifico pittore
abbandonava il pennello per imbracciare il fucile in nome della
libertà, affascinato come molti altri stranieri dalla figura
carismatica di Garibaldi. Certo, non avrebbe mai rinnegato
completamente la sua indole e se pure partecipò a qualche fatto
d’arme, gli capitava sovente di mettersi ad eseguire schizzi e
disegni nell’infuriare della battaglia. Di certo la sua sensibilità
lo portò a cogliere particolari che sarebbero rimasti altrimenti
ignorati. Straordinarie le descrizioni dei protagonisti dell’epopea
garibaldina, come per Ugo Bassi, con la tonaca nera in groppa a un
cavallo bianco, che assisteva feriti e morenti senza paura sotto il
fuoco nemico o per Andres Aguyar, il moro di Garibaldi, Ercole di
color ebano su un cavallo nero, che faceva pensare a un’ombra.
Travolgenti le pagine dedicate all’assalto al casino dei Quattro
Venti, trasformato in un cratere che vomitava fuoco e lanciava in
alto un mare di scintille e tizzoni ardenti. Particolarmente
significativo il secondo volume, nel quale il pacifico pittore
abbandonava il pennello per imbracciare il fucile in nome della
libertà, affascinato come molti altri stranieri dalla figura
carismatica di Garibaldi. Certo, non avrebbe mai rinnegato
completamente la sua indole e se pure partecipò a qualche fatto
d’arme, gli capitava sovente di mettersi ad eseguire schizzi e
disegni nell’infuriare della battaglia. Di certo la sua sensibilità
lo portò a cogliere particolari che sarebbero rimasti altrimenti
ignorati. Straordinarie le descrizioni dei protagonisti dell’epopea
garibaldina, come per Ugo Bassi, con la tonaca nera in groppa a un
cavallo bianco, che assisteva feriti e morenti senza paura sotto il
fuoco nemico o per Andres Aguyar, il moro di Garibaldi, Ercole di
color ebano su un cavallo nero, che faceva pensare a un’ombra.
Travolgenti le pagine dedicate all’assalto al casino dei Quattro
Venti, trasformato in un cratere che vomitava fuoco e lanciava in
alto un mare di scintille e tizzoni ardenti.
Colma
di tristezza l’ultima parte delle memorie, nella quale si
tratteggiava efficacemente il clima di angoscia e insicurezza che si
respirava a Roma dopo l’entrata delle truppe francesi, tra furti,
aggressioni e soprusi di ogni tipo.
Nel
1857 il Koelman tornò in patria e nel 1861 divenne professore di
disegno all’Accademia di Belle Arti dell’Aia. Si dedicò alla
scultura, erigendo il monumento celebrativo del cinquantenario della
liberazione dell’Olanda dal dominio francese. Morì il 16 gennaio del
1893, a settantacinque anni.
di Cinzia
Dal Maso |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
|
OMAGGIO
ALLA SCRITTRICE E GIORNALISTA AMERICANA AL FATEBENEFRATELLI |
|
L’IMPEGNO DI MARGARET
FULLER
NELLA ROMA RISORGIMENTALE
 Il
23 maggio 1810 nasceva a Cambridgeport, vicino Boston, Margaret
Fuller, la scrittrice e giornalista americana impegnata per
l’emancipazione femminile e in prima linea nell’organizzazione e
nella gestione degli ospedali nel breve e glorioso periodo della
Repubblica Romana del 1849. Un dagherrotipo del 1846 ce la mostra
elegantemente vestita, con i capelli raccolti sotto la nuca in un
chignon e l’espressione assorta. Il
23 maggio 1810 nasceva a Cambridgeport, vicino Boston, Margaret
Fuller, la scrittrice e giornalista americana impegnata per
l’emancipazione femminile e in prima linea nell’organizzazione e
nella gestione degli ospedali nel breve e glorioso periodo della
Repubblica Romana del 1849. Un dagherrotipo del 1846 ce la mostra
elegantemente vestita, con i capelli raccolti sotto la nuca in un
chignon e l’espressione assorta.
Per celebrare il suo duecentesimo compleanno,
si è tenuto il
seminario"Margaret Fuller Ossoli, le donne e l’impegno civile
nella Roma risorgimentale",nella Sala Assunta dell’Ospedale
Fatebenefratelli, ossia in quella stessa corsia che la vide
assistere i feriti senza distinzione di patria e di credo politico e
religioso, ancor prima che nascesse la Croce Rossa.
Ha
introdotto il seminario Mario Bannoni, in rappresentanza di Laurie
James, presidente del Comitato Usa per il Bicentenario di Margaret
Fuller Ossoli. Sono quindi seguiti i saluti di David Mees, addetto
culturale dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America e di Jaroslaw
Mikolajewski, direttore dell’Istituto polacco di Roma. Anna Maria
Cerioni, della sovraintendenza ai beni culturali del comune di Roma,
si è soffermata sulle memorie che la nostra ci ttà
ha dedicato alle donne dell’epoca risorgimentale: dalla targa sulla
dimora di Anita e Giuseppe Garibaldi, in via delle Carrozze 59, ai
busti di Colomba Antonietti sul Gianicolo e di Giuditta Tavani
Arquati in via della Lungaretta, alla targa apposta a 150 anni dalla
morte di Margaret Fuller sulla facciata del palazzo dove abitò, in
piazza Barberini 2. ttà
ha dedicato alle donne dell’epoca risorgimentale: dalla targa sulla
dimora di Anita e Giuseppe Garibaldi, in via delle Carrozze 59, ai
busti di Colomba Antonietti sul Gianicolo e di Giuditta Tavani
Arquati in via della Lungaretta, alla targa apposta a 150 anni dalla
morte di Margaret Fuller sulla facciata del palazzo dove abitò, in
piazza Barberini 2.
L’intervento di Cristina Giorcelli, direttore del Dipartimento di
Studi Euro-americani dell’Università degli Studi di Roma Tre, ha
riguardato "Margaret Fuller, un’intellettuale e una
realizzatrice" e
quello di Marco Severini, docente di Storia del Risorgimento presso
la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Macerata, "Novità
storiografiche sulla Repubblica Romana".
Quindi Enrico
Luciani, presidente dell’Associazione A. Cipriani e direttore del
sito www.comitatogianicolo.it, ha illustrato la "Difesa di Roma
del 1849. Memoria e territorio".Antonio Santoro, Brigadiere
Generale Medico della direzione generale della sanità militare e
docente presso l’Università di Firenze, ha parlato di "Operatività
sanitaria militare nel 1849", insieme con Federica Dal Forno.
Ginevra
Conti Odorisio, ordinaria di Storia delle dottrine politiche presso
l’Università degli Studi Roma Tre, ha ricordato "Le donne del
1848", a cominciare da Harriet Martineau, che seppe porre
l’accento sull’incompiutezza della democrazia americana, in cui
permaneva la schiavitù dei neri e le donne obbedivano a leggi che
non avevano contribuito a fare, per proseguire con Cristina
Trivulzio di Belgiojoso, che dedicò alla causa italiana anche i suoi
beni e sostenne per prima il diritto alla neutralità dei feriti.
 L’ultimo
intervento è stato quello di Fiorenza Taricone, dell’Università
degli Studi di Cassino, che si occupa da anni del difficile nesso
tra donne e guerra, e ha riguardato "Il patriottismo femminile
nel Risorgimento". La studiosa ha ricordato le parole di
Vittorio Cian:"bisogna che noi signori uomini abbiamo coraggio di
confessare che, senza volerlo, solo spinti dal nostro istinto e
dalle nostre abitudini di maschi sopraffattori, nello scrivere la
storia abbiamo fatto e continuiamo a fare un po’ troppo la parte del
leone... Bisogna che abbiamo pure il coraggio di rivederla questa
storia scritta da noi e di riconoscere col fatto che,
quanto più si estendono e si approfondiscono le indagini sul nostro
Risorgimento, più vediamo balzar fuori figure di donne". Il
Risorgimento e la storia della Repubblica Romana, poi, ha continuato
Fiorenza Taricone, ci danno modo di avvicinarci a un concetto che
c’è sempre stato, quello del travestitismo, pervenutoci come atto
d’amore. "Non dico che Colomba Antonietti non si sia vestita da
uomo per stare vicino al marito, ma dico che attraverso l’amore
privato è passato l’amor patrio. L’amore è stato l’occasione per
costruire un concetto di cittadinanza attiva". L’ultimo
intervento è stato quello di Fiorenza Taricone, dell’Università
degli Studi di Cassino, che si occupa da anni del difficile nesso
tra donne e guerra, e ha riguardato "Il patriottismo femminile
nel Risorgimento". La studiosa ha ricordato le parole di
Vittorio Cian:"bisogna che noi signori uomini abbiamo coraggio di
confessare che, senza volerlo, solo spinti dal nostro istinto e
dalle nostre abitudini di maschi sopraffattori, nello scrivere la
storia abbiamo fatto e continuiamo a fare un po’ troppo la parte del
leone... Bisogna che abbiamo pure il coraggio di rivederla questa
storia scritta da noi e di riconoscere col fatto che,
quanto più si estendono e si approfondiscono le indagini sul nostro
Risorgimento, più vediamo balzar fuori figure di donne". Il
Risorgimento e la storia della Repubblica Romana, poi, ha continuato
Fiorenza Taricone, ci danno modo di avvicinarci a un concetto che
c’è sempre stato, quello del travestitismo, pervenutoci come atto
d’amore. "Non dico che Colomba Antonietti non si sia vestita da
uomo per stare vicino al marito, ma dico che attraverso l’amore
privato è passato l’amor patrio. L’amore è stato l’occasione per
costruire un concetto di cittadinanza attiva".
In
conclusione, le ricerche e gli approfondimenti di Mario Bannoni su
"Gli anni italiani di Margaret Fuller", che dopo la caduta
della Repubblica Romana salpò per gli Stati Uniti. A poca distanza
dal porto di New York la nave colò a picco e la Fuller perse la
vita, insieme con il marito, il conte Giovanni Angelo Ossoli, e il
figlioletto.
di Antonio
Venditti e Cinzia
Dal Maso |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
|
SPIRÒ ALL’OSPIZIO DEI
PELLEGRINI IL 6 LUGLIO DI 160 ANNI FA |
|
Gli ultimi
giorni di Goffredo Mameli
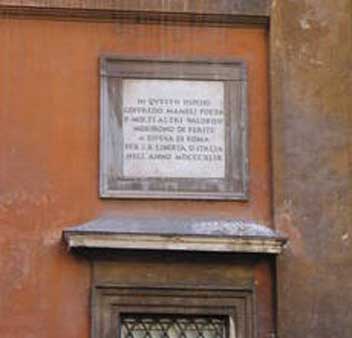 In
piazza della Trinità dei Pellegrini, nel rione Regola, accanto alla
chiesa omonima, sorse nel 1625 un grandissimo ospizio, costruito per
offrire assistenza ai fedeli che accorrevano a Roma durante il
Giubileo di quell'anno. Nel refettorio nobili e cardinali lavavano i
piedi dei pellegrini. Nel 1940 l’ospizio fu in gran parte demolito e
oggi ospita alcuni uffici. La facciata, a due piani, ha finestre
semplicemente riquadrate e un portale con ai lati due finestre
architravate con davanzali e mensoloni sottostanti e due cassette
marmoree per elemosine. Sopra la finestra a sinistra del portale,
una targa marmorea ricorda che "In questo ospizio Goffredo Mameli e
molti altri valorosi morirono di ferite a difesa di Roma per la
libertà d'Italia nell'anno MDCCCXLIX".
Infatti, durante i
durissimi scontri che decretarono la fine della Repubblica Romana,
l’ospizio era stato trasformato in ospedale militare. Il 3 giugno,
durante i combattimenti sul Gianicolo, l’autore dell’Inno d’Italia
fu ferito inavvertitamente da un commilitone, un bersagliere di
Luciano Manara, alla gamba sinistra. Lo portarono per una
medicazione e un breve ricovero all’ospizio dei Pellegrini. Ma fu
curato tardi e male. Il medico Agostino Bertani non lo vide che 16
giorni dopo, quando la situazione si era tremendamente aggravata. Lo
assisteva la bella veneziana Adele Baroffio, innamorata di lui, ma
gli fu vicino fino alla fine anche la principessa Cristina Trivulzio
di Belgiojoso, che tanto si prodigò per l’organizzazione dei
soccorsi ai feriti di quei giorni. A quanto pare, durante le prime
cure, nella concitazione del momento, era stato estratto dalla gamba
di Goffredo un proiettile, ma vi era stato dimenticato lo
stoppaccino, ossia la garza contenente la polvere da sparo, che
avrebbe provocato la cancrena. Quando la Belgiojoso se ne accorse,
le sue urla si udirono risuonare per tutta la corsia. Fu decisa
l’amputazione della gamba, ma nemmeno questa riuscì a salvare il
giovane poeta, che divorato dalla febbre a volte recitava nel
delirio i versi di "Fratelli d’Italia". Come riferisce lo storico
inglese George Macaulay Trevelyan, nelle ultime notti la principessa
gli leggeva Dickens alla fioca luce di una candela. Il 6 luglio di
160 anni fa, spirò tra le braccia della Belgiojoso. Aveva 22 anni.
di Cinzia
Dal Maso |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
|
LA SUA
DIVISA DA GENERALE È ESPOSTA A CASTEL SANT’ANGELO |
|
FRANCESCO STURBINETTI,
SENATORE DI ROMA

Dal lato del giretto scoperto di Castel Sant’Angelo che si affaccia
con splendida vista sulla basilica di San Pietro, nell’Armeria
Superiore, è stata sistemata una piccola porzione dell’antica
collezione d’armi del Castello che dal 1925, anno di costituzione
del "Museo Artistico e Militare", è andata progressivamente
crescendo.
In una
vetrina della prima sala, dedicata all’esercito pontificio e a
quello italiano dell’Ottocento, è esposta l’uniforme blu di
Francesco Sturbinetti, che fu Senatore di Roma e generale della
Guardia Nazionale durante la Repubblica Romana del 1849.
Nato a
Roma nel 1807, avvocato della Sacra Rota, aveva preso parte al
movimento per le riforme sotto Pio IX. Durante il primo ministero
laico dello Stato Pontificio fu prima ministro dei Lavori Pubblici,
poi della Giustizia.
Dopo la
caduta della Repubblica Romana, fu escluso dall’amnistia pontificia.
L’aver votato, nell’assemblea costituente del ’49, l’abolizione del
potere temporale dei Papi gli costò l’esilio. Poté tornare in patria
solo il 7 settembre del 1857, con l’imposizione però di soggiornare
a Frascati. Il 7 novembre dello stesso anno fu ricevuto in udienza
da Pio IX, che si mostrò cordiale e affettuoso. Sturbinetti morì a
Frascati nel 1865, ad appena cinquantotto anni e fu sepolto a Roma,
nella navata destra della chiesa dei SS. Giovanni e Paolo. La lapide
ricorda il perdono pontificio: "Abreptus et exsul studio rerum
novarum anno MDCCCXLIX, reditus veniam a pontifice maximo consecutus
est".
di
Annalisa Venditti |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
|
CON LA
SUA ARTE FU IL PRINCIPALE INTERPRETE DELL’EPOPEA RISORGIMENTALE |
|
IL PITTORE - SOLDATO GEROLAMO INDUNO
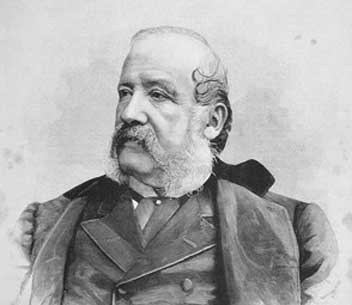 Gerolamo
Induno, fratello minore di Domenico, era nato a Milano il 13
dicembre 1825. Aveva frequentato l’Accademia di Brera dove, dal 1839
al 1846, era stato allievo di Luigi Sabatelli. Gerolamo
Induno, fratello minore di Domenico, era nato a Milano il 13
dicembre 1825. Aveva frequentato l’Accademia di Brera dove, dal 1839
al 1846, era stato allievo di Luigi Sabatelli.
Fin dal 1845 aveva esposto i suoi primi dipinti
alla mostra braidense: studi dal vero, alcuni ritratti e una Scena
dai Promessi Sposi.
Dopo aver partecipato ai moti antiaustriaci del
1848, si era rifugiato con il fratello ad Astano, in Svizzera,
quindi si trasferì a Firenze, dove si arruolò come volontario sotto
il comando del generale Giacomo Medici, con il quale, nel 1849,
partecipò alla difesa di Roma assediata dai francesi del generale
Oudinot, eseguendo molti schizzi e scene riprese dal vero.
Definito da Garibaldi uno dei più "intrepidi e
valorosi combattenti di Roma", Gerolamo Induno fu impegnato
nell’occupazione del Vascello. Il
22 giugno, per ordine di Garibaldi, due compagnie del generale
Medici tentarono da villa Spada di impadronirsi della casa Barberini,
all’interno di villa Sciarra, nel luogo oggi intitolato al
volontario belga Adolfo
Leduq. I patrioti riuscirono a penetrare nella casa, ma
dovettero ritirarsi dopo una furiosa mischia nel cortile e nell e
stanze. Durante quell’operazione, in cui perse la vita Giacomo
Venezian, Gerolamo Induno fu gravemente ferito da 27 colpi di
baionetta e cadde da una terrazza. Due commilitoni lo raccolsero in
fin di vita ed Enrico Guastalla lo portò sulle sue braccia. Fu
curato all’ospedale dei Fatebenefratelli, diretto dalla giornalista
americana Margaret Fuller Ossoli. Una volta guarito, fu nominato
sottotenente e rimase qualche tempo a Roma. Grazie alla
protezione del conte Giulio Litta, riuscì a tornare a Milano e negli
anni che seguirono espose a Brera alcune opere di tema
risorgimentale che ricordavano gli eventi che lo avevano visto
protagonista a Roma, come "La difesa del Vascello", "Porta San
Pancrazio dopo l’assedio del 1849" o "Trasteverina colpita da una
bomba". e
stanze. Durante quell’operazione, in cui perse la vita Giacomo
Venezian, Gerolamo Induno fu gravemente ferito da 27 colpi di
baionetta e cadde da una terrazza. Due commilitoni lo raccolsero in
fin di vita ed Enrico Guastalla lo portò sulle sue braccia. Fu
curato all’ospedale dei Fatebenefratelli, diretto dalla giornalista
americana Margaret Fuller Ossoli. Una volta guarito, fu nominato
sottotenente e rimase qualche tempo a Roma. Grazie alla
protezione del conte Giulio Litta, riuscì a tornare a Milano e negli
anni che seguirono espose a Brera alcune opere di tema
risorgimentale che ricordavano gli eventi che lo avevano visto
protagonista a Roma, come "La difesa del Vascello", "Porta San
Pancrazio dopo l’assedio del 1849" o "Trasteverina colpita da una
bomba".
Dal 1854 al 1855 aveva partecipato alla
campagna di Crimea, militando nel corpo dei bersaglieri di
Alessandro La Marmora in qualità di pittore-soldato ed eseguendo
disegni, studi e resoconti per immagini. Al ritorno in patria quegli
schizzi diventarono quadri pieni di sentimenti patriottici, molto
apprezzati dalla critica. Tra questi, "La battaglia di Cernaia", che
gli era stata commissionata dallo stesso Vittorio Emanuele II.
Nel 1855 ottenne un grande successo
all’Esposizione Universale di Parigi. In seguito espose alcuni
dipinti di vario tipo, dalla veduta al ritratto, sia a Milano che a
Firenze.
Nel 1859 si arruolò come ufficiale
garibaldino dei Cacciatori delle Alpi, continuando a dipingere e a
prediligere i temi patriottici e confermandosi come il principale
interprete dell’epopea risorgimentale. Alle rappresentazioni di tono
aulico, come "La battaglia di Magenta", alternò soggetti più intimi
o di genere: "Un grande sacrificio" (l’addio della madre del
garibaldino), "La partenza del coscritto", "Triste presentimento".
Famoso fu "La battaglia della
Cernaia", acquistato da Vittorio Emanuele II. Molto apprezzati anche
il "Legionario garibaldino alla difesa di Roma" o "Episodio
dell’assedio di Roma del 1849", forse realizzato alcuni anni dopo.
 Il
5 maggio del 1860 Garibaldi salpava da Quarto per la Sicilia. Anche
se Induno, dopo tante battaglie, non era fisicamente tra i Mille,
partecipò idealmente all’impresa traducendo in pittura le cronache
dei giornali e i racconti dei reduci. In un’atmosfera velata dal
rimpianto, anche l’arte storica o celebrativa si apriva al
sentimento, come ne "L’imbarco dei Mille a Quarto", dove
l’attenzione si sofferma sugli episodi del garibaldino che bacia il
figlio o della moglie che piange per la partenza del marito. Il
5 maggio del 1860 Garibaldi salpava da Quarto per la Sicilia. Anche
se Induno, dopo tante battaglie, non era fisicamente tra i Mille,
partecipò idealmente all’impresa traducendo in pittura le cronache
dei giornali e i racconti dei reduci. In un’atmosfera velata dal
rimpianto, anche l’arte storica o celebrativa si apriva al
sentimento, come ne "L’imbarco dei Mille a Quarto", dove
l’attenzione si sofferma sugli episodi del garibaldino che bacia il
figlio o della moglie che piange per la partenza del marito.
Negli anni Sessanta dell’Ottocento era ancora
impegnato in dipinti celebrativi, da "L’ingresso di Vittorio
Emanuele II a Venezia" a "La morte di Enrico Cairoli a Villa Glori",
ma prese parte anche a grandi imprese decorative, come le Allegorie
di Firenze e di Roma e nella rinnovata stazione Ferroviaria di
Milano o il sipario del teatro di Gallarate. Intanto la sua arte
subiva un’evoluzione verso una pittura dalla pennellata quasi
virtuosistica e con soggetti di gusto neosettecentesco,
esemplificata da "La partita a scacchi" e "Un amatore di antichità".
Dopo una lunga malattia, morì a Milano il 19
dicembre del 1890.
di Cinzia
Dal Maso |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
|
Da schiavo di Montevideo a luogotenente
dell’Eroe dei due Mondi |
|
Andrea Aguyar, il Moro di Garibaldi
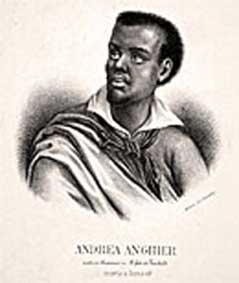 Tra
gli eroi caduti nel 1849 nella strenua difesa della Repubblica
Romana contro i francesi del generale Oudinot, spicca una figura
alquanto singolare; è Andrea Aguyar, il moro di Garibaldi. Non
cercatene l’immagine tra i busti del Gianicolo, perché non c’è. Ben
poche tracce restano del suo passaggio, breve ma significativo,
nella Città Eterna: il suo nome figura nell’elenco dei patrioti
sepolti nell’ossuario garibaldino e gli è dedicata la rampa che
collega Monteverde con viale Trastevere, la scalea Andrea il Moro. Tra
gli eroi caduti nel 1849 nella strenua difesa della Repubblica
Romana contro i francesi del generale Oudinot, spicca una figura
alquanto singolare; è Andrea Aguyar, il moro di Garibaldi. Non
cercatene l’immagine tra i busti del Gianicolo, perché non c’è. Ben
poche tracce restano del suo passaggio, breve ma significativo,
nella Città Eterna: il suo nome figura nell’elenco dei patrioti
sepolti nell’ossuario garibaldino e gli è dedicata la rampa che
collega Monteverde con viale Trastevere, la scalea Andrea il Moro.
Era nato a Montevideo da genitori africani
schiavi come lui. Era stato liberato con la proclamazione della
repubblica uruguayana e da allora non aveva voluto più lasciare
Garibaldi, che lo nominò luogotenente del suo Stato Maggiore. Andrea
non sapeva scrivere, ma montava a cavallo come pochi e lasciava
tutti senza parole quando faceva roteare in aria il lazo con cui
riprendeva, come un gaucho, i cavalli disarcionati ch e fuggivano
nella battaglia. Il suo aspetto erculeo lo faceva sembrare un
principe di ebano, con denti bianchissimi che scopriva ridendo. Era
sempre avvolto in un gran mantello nero e armato di lancia con una
banderuola rossa.Quando Garibaldi si fermava a riposare, Andrea
toglieva la sella al suo cavallo, che trasformava in un letto per
l’Eroe, posto sotto una tenda improvvisata piantando in terra la sua
spada e la sua lancia e gettandovi sopra il mantello. Non conosceva
la paura e più di una volta salvò la vita a Garibaldi. Solo in
un’occasione forse il suo coraggio non sarebbe bastato a difendere
l’eroe. Nella battaglia di Velletri, Garibaldi dominava il
combattimento dall’alto di una vigna, quando si accorse che i suoi
lancieri, spaventati, perdevano terreno. Scese precipitosamente a
cavallo dalla collina per andare a rincuorarli, seguito da Aguyar,
ma il suo cavallo inciampò, lo sbalzò di sella e gli rovinò sopra,
intrappolandolo. Fu un attimo: molti soldati borboni accorsero per
farlo prigioniero, ma dalle siepi uscì una nuvola di quei ragazzini
tra i dodici e i sedici anni che formavano la cosiddetta brigata dei
monelli. Tutti insieme, come indiavolati, si gettarono sui soldati e
maneggiando abilmente le loro baionette, li costrinsero alla fuga. e fuggivano
nella battaglia. Il suo aspetto erculeo lo faceva sembrare un
principe di ebano, con denti bianchissimi che scopriva ridendo. Era
sempre avvolto in un gran mantello nero e armato di lancia con una
banderuola rossa.Quando Garibaldi si fermava a riposare, Andrea
toglieva la sella al suo cavallo, che trasformava in un letto per
l’Eroe, posto sotto una tenda improvvisata piantando in terra la sua
spada e la sua lancia e gettandovi sopra il mantello. Non conosceva
la paura e più di una volta salvò la vita a Garibaldi. Solo in
un’occasione forse il suo coraggio non sarebbe bastato a difendere
l’eroe. Nella battaglia di Velletri, Garibaldi dominava il
combattimento dall’alto di una vigna, quando si accorse che i suoi
lancieri, spaventati, perdevano terreno. Scese precipitosamente a
cavallo dalla collina per andare a rincuorarli, seguito da Aguyar,
ma il suo cavallo inciampò, lo sbalzò di sella e gli rovinò sopra,
intrappolandolo. Fu un attimo: molti soldati borboni accorsero per
farlo prigioniero, ma dalle siepi uscì una nuvola di quei ragazzini
tra i dodici e i sedici anni che formavano la cosiddetta brigata dei
monelli. Tutti insieme, come indiavolati, si gettarono sui soldati e
maneggiando abilmente le loro baionette, li costrinsero alla fuga.
Quattro giorni dopo
l’arrivo di Anita a Roma, Andrea fu colpito da una bomba nei pressi
di Santa Maria in Trastevere. Grondando sangue, riuscì a gridare:
"Viva le repubbliche d’America e di Roma!" Fu portato nella vicina
Santa Maria della Scala, a quel tempo adibita a ospedale, dove
spirò.
di Cinzia Dal Maso |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
|
Durante il suo esilio fiorentino
sposò la pittrice Ida Botti |
|
Felice Scifoni, letterato e patriota
 Felice
Scifoni era nato a Roma nel 1802. Divenuto notaio, si affiliò alla Carboneria.
Fu socio dell’Accademia Tiberina, che aveva tra i fondatori Giuseppe Gioachino
Belli, di cui divenne amico. Fu arrestato per aver partecipato, in Romagna, ai
moti del 1831. Due anni dopo fu costretto ad andare esule a Firenze, dove
partecipò alla stesura del "Dizionario biografico universale" dell’editore
Passigli. Qui sposò Ida Botti (1812 – 1844), una valente pittrice allieva di
Giovanni Salvagni, specializzata nei generi dei ritratti e delle nature morte.
Ritrasse alcune nobildonne, tra cui Maria Mercede di Bonilla e Matilde
Bonaparte, figlia di Gerolamo Re di Vestfalia, fratello di Napoleone, consorte
dal 1841 del principe e collezionista Anatolio Demidoff. Il suo autoritratto è a
Palazzo Pitti.
Nel 1846, grazie
all’amnistia di Pio IX, Scifoni poté tornare nella sua città. Nel 1849 fu
Deputato alla Costituente romana e il suo sostegno alla Repubblica fu così
deciso che dopo la restaurazione del governo pontificio dovette andare in esilio
in Francia. Non ci rimase molto, a causa della sua ferma opposizione a Napoleone
III. Si trasferì a Torino e collaborò con Maurizio Guigoni e con la sua Società
editrice italiana, pubblicando opere di esponenti democratici di spicco.
Nel 1866, sebbene
versasse in ristrettezze economiche, rifiutò una cattedra universitaria per non
prestare giuramento alle istituzioni monarchiche. Infatti, ancora nel 1876 si
dichiarava mazziniano.
Tornò a Roma dopo
la breccia di Porta Pia. Nel 1871 scrisse una storia dell’Italia antica e, dopo
il 1873, ottenne l'ufficio di bibliotecario del municipio.
Morì nella sua
città nel 1883.
di
Cinzia Dal Maso |
|
SPECIALE RISORGIMENTO
- SPECCHIO ROMANO |
|