
|
La nascita si fa ricollegare a S. Gaetano da
Thiene, nel 1517 |
|
Nel
presepe romano la vita dei popolani
I
viaggiatori stranieri dell’Ottocento nei diari e impressioni di
viaggio tracciarono colorite pagine, descrivendo usi, costumi e
tradizioni
 Si
vuole che il più antico presepe a Roma sia quello di Arnolfo di
Cambio (1240-1302) in S. Maria Maggiore. Non si conoscono documenti
sui presepi nei secoli XV e XVI. La consuetudine si fa risalire al
1517, riferendola a San Gaetano Thiene. Si
vuole che il più antico presepe a Roma sia quello di Arnolfo di
Cambio (1240-1302) in S. Maria Maggiore. Non si conoscono documenti
sui presepi nei secoli XV e XVI. La consuetudine si fa risalire al
1517, riferendola a San Gaetano Thiene.
Una notizia del 1614 rende noto che un certo Fra Jacono romano donò
alle monache di Morlupo il “Bambino et tutti suppellettili del
Presepio”. Inoltre, nel 1617 il diarista Vaiena annota che a Roma e
nel Lazio l’uso del presepe era diffuso nelle chiese e nei conventi.
Documentata è l’attività presepista del Bernini per i Barberini.
Con l’avvento
del barocco si svilupparono i presepi in Roma, popolati dalle
figurine, scolpite in legno, poi in creta, provenienti dalla scuola
napoletana, portate da viaggiatori e mercanti. Nacquero così i
concerti da presepe come la “Natività” del Corelli, o i mottetti del
Nannini.
Cardinali e
prelati si dedicarono alla costruzione di colossali presepi e molti
palazzi nobili ebbero un salone con la volta e le pareti dipinte a
calotta celeste con nubi e con la bocca-scena, in cui durante le
feste natalizie si innalzava il presepe.
I presepi
romani nel secolo XVIII avevano raggiunto nelle chiese un fasto ed
uno splendore tale da dover essere disciplinati dalle autorità
ecclesiastiche per gli eccessi del popolo chiassoso e la loro
smodata decorazione. Si giunse perfino a stabilire il numero delle
lampade che dovevano illuminarli, come riferisce un decreto del 7
settembre 1733 di mons. Sacripanti.
Ricca è la
documentazione del presepe a Roma nel secolo XIX, di cui i
viaggiatori stranieri nei loro diari hanno lasciato colorite
descrizioni.
Meno ricco e
affollato di quello napoletano, il presepe romano dell’Ottocento,
costruito in sughero e muschio, rappresenta la vita del popolo:
compaiono il pizzicagnolo, la trattoria «Dar Turco», con cucina
romana, i gendarmi, gli zampognari, i pastori ciociari e molisani,
“Pasquino” e i re Magi in carrozzella. Le scenografie si
arricchiscono del fondale, dei monti e alberi. Alcuni presepi sono
innalzati su portici, terrazze e loggette con lo sfondo naturale del
cielo. Si utilizzano misture di colore racchiuse in globi di vetro
che, mediante specchi metallici, rifrangono la luce delle fiammelle
dei ceri e dei lumi ad olio: la musica popolare è affidata agli
strumenti a fiato dei pastori discesi dalle montagne abruzzesi.
L’uso di
allestire il presepe si diffonde fra tutti i ceti sociali che fanno
a gara nel costruirne con pezzi modellati da modesti scultori o dai
lavoranti delle piccole fornaci trasteverine. Dalle nove del mattino
al tramonto iniziava la visita ai presepi: i committenti, dopo aver
sparso all’ingresso della casa o della bottega qualche foglia di
alloro, appendevano sulla porta una corona di mortella.
Il presepe dell’Aracoeli, che primeggia su tutti, prese la forma
attuale nel 1851 con i disegni di Luigi Poletti. Poiché le statue
erano cadenti - si salvavano soltanto quelle della Vergine e di San
Giuseppe, oltre alle teste del bue e dell’asinello - i frati si
rivolsero al duca Pio Grazioli, che possedeva il proprio palazzo lì
accanto. Il duca sul finire del 1860, affidò allo scultore Luigi
Ceccon l’incarico di scolpire dodici statue a grandezza naturale per
un compenso di settecentoventi scudi, mentre padre Francesco da
Codogno si era assunto l’incarico
di
trasformare lo sfondo della grotta di sughero in una gloria che
potesse accogliere i piccoli cantori con i loro strumenti musicali.
Le statue, sei
pastori e i Re Magi ciascuno con un valletto, furono rivestite di
abiti ricchi e sfarzosi. Lo “sfondo” del presepe fu distrutto nel
1887, in seguito ai lavori per il monumento a Vittorio Emanuele Il.
Le vecchie quinte di sughero, perse nel restauro del 1957, furono
sostituite dalla grotta in cemento ideata da Nino Delle Site.
Dinanzi al
Santo Bambino, con le fasce ricoperte di gioielli, si alternavano,
su di un piccolo palco, bambini e bambine, per recitare poesie in
suo onore. Al presepe era collegata la tradizione dei sermoni e la
benedizione del S. Bambino dall’alto della scalea sul popolo romano,
in ginocchio e in adorazione.
I padri di San
Francesco a Ripa gareggiavano con i confratelli capitolini. Il loro
presepe ebbe vita regolare solo dal 1769. Al cielo, ottenuto con
tendoni dipinti, si aggiunsero scene di boschi, monti e capanne,
l’Eterno Padre. Una gloria imponente sovrastava la Grotta. Le
bacchettine di vetro a tortiglione dette “cresce cala”, in continuo
movimento dietro il Bambinello, simulavano il getto dell’acqua delle
fontane; le lontananze erano rese con una serie di specchi nascosti
tra il muschio e il sughero. La principessa Maria Maddalena Borromei
Altieri cucì i vestiti di San Giuseppe, della Vergine e del Bambino
Gesù.
Oltre il Tevere
un caratteristico presepio, “a giorno”, attirava i curiosi: era
quello costruito dal 1827 dall’industriale del mosaico Giuseppe
Forti, sulla Torre degli Anguillara. In primo piano era la Grotta in
sughero e dai crepacci si scorgeva il paesaggio artificiale fino al
parapetto, da cui si vedeva lo sfondo al naturale con in lontananza
i colli Albani.
Con lo stesso
sistema era stato costruito un altro presepio da un calzolaio, che
nel 1802 si visitava nel Rione Regola.
Con l’avanzare
del secolo la popolarità dei presepi si fa più frequente; la scalea
dell’Aracoeli nelle feste natalizie brulicava di folla e di
venditori, S. Andrea della Valle dal 1846 fu meta dello stesso
afflusso. Nello stesso anno il canonico Vincenzo Pallotti aveva
ottenuto dalla famiglia Torlonia nove grandi figure in dono, opera
di Pietro Cantagalli, che formavano l’unica scena dell’Epifania.
Per soddisfare
le continue richieste delle figure popolari, i vasai, vascellari, i
“bucalettari”, tra i quali deve annoverarsi il padre dei Pinelli,
nei mesi antecedenti il Natale lavoravano di gran lena nelle fornaci
di S. Maria in Cappella.
L’aristocrazia
e la borghesia romana, in gara con la chiesa per offrire alla
cittadinanza la migliore riproduzione della notte santa, appendeva
grandi corone e festoni di mortella sulle porte delle abitazioni per
indicare che la visita del presepe era aperta a tutti.
Sulla fine
dell’Ottocento, lo scultore Baldassarre Surdi diede vita a un
gigantesco presepe, alla cui realizzazione parteciparono artisti di
fama come Cifariello, Monteverdi, Zocchi, Ferrari, Maccagnani. La
prima esposizione avvenne nel 1893 in un padiglione in piazza
Borghese, su un panorama d’eccezione dipinto dal Ballester.
di Antonio
Venditti |
|
|
|
A
Roma il Museo del Presepe:
un’arte che accomuna i popoli
Nel cuore di Roma,
poco distante dai Fori Imperiali, si nasconde un piccolo tesoro di
arte sacra: è il Museo Tipologico Internazionale del Presepio, uno
scrigno di meravigliose Natività realizzate nei materiali più
disparati, provenienti da diverse regioni del nostro Paese e da
tutto il mondo. L’esposizione permanente, curata dall’ "Associazione
Italiana Amici del Presepe", ha sede nei sotterranei della bella
Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta (via Tor de’ Conti, 31 A, tel.
06.6796146).
All’interno del museo sono raccolte sacre rappresentazioni antiche e
moderne di grande interesse storico e documentaristico: una
straordinaria collezione, che supera i tremila pezzi, tuttora in
continua crescita. Come non rimanere a bocca aperta dinanzi a un
presepe trapanese del 1600 interamente composto da piccole
conchiglie? E che dire dei minuti capolavori incastonati nei gusci
di noci? E degli scorci realizzati seguendo a regola d’arte le leggi
della prospettiva? Pupazzi di cartapesta, terracotta, vetro
soffiato, cera, sughero, ceramica, gesso, latta, legno e persino
costruiti con le foglie di mais, il marzapane, la paglia, la mollica
di pane, il piombo e lo stagno, costituiscono la preziosa occasione
per esplorare il significato che la grande festa del Natale ha
assunto durante i secoli nei diversi Paesi del mondo.
La
rappresentazione di quella sacra notte raccoglie, come in un quadro
variopinto, ancestrali aspetti etnici e culturali, colori e
materiali di popoli e terre solo apparentemente lontane, perché
accomunate dalle forti radici del medesimo culto.
E’
possibile ammirare, oltre ai classici presepi napoletani e romani
dalle pittoresche vedute cittadine, anche esemplari provenienti
dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Francia, dalla Germania,
dall’Austria, dalla Cecoslovacchia, dalla Svezia, dall’Ungheria,
dalla Finlandia, dal Madagascar, dall’Equador, dal Perù, dal
Messico. E solo per citarne alcuni. C’è addirittura una sacra
rappresentazione ispirata a "I Promessi Sposi", un presepe
"manzoniano" in cui sono facilmente riconoscibili tutti i
protagonisti del celebre romanzo: Renzo, Lucia, fra’ Cristoforo,
Agnese.
L’
"Associazione Italiana Amici del Presepio", fondata nel 1953 da
alcuni appassionati cultori di questa antica arte col preciso scopo "di
mantenerne viva la tradizione, diffonderla sempre più e studiarne ed
evidenziarne tutti gli aspetti, religiosi, storici, artistici,
folcloristici e tecnici", organizza
durante l’anno mostre e conferenze sull’argomento, oltre ad un
interessante corso di tecnica presepistica.
Il
museo è aperto al pubblico da settembre a giugno (mercoledì-sabato
dalle ore 17.00 alle 20.00) e dal 25 dicembre al 6 gennaio (feriali:
16.00-20.00; festivi: 10.00-13.00 e 16.00-20.00).
di Annalisa
Venditti |
|
|
|
La
chiesa di S. Maria in Aracoeli aspetta il ritorno del Bambinello
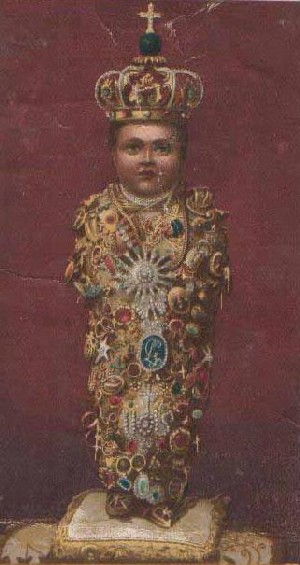 Una
delle sculture sacre più venerate di Roma è stata per secoli il
Bambinello conservato nella chiesa di S. Maria in Aracoeli. Un
religioso francescano l’aveva scolpito a Gerusalemme, forse sul
finire del Quattrocento, da un pezzo di legno d’ulivo dei Gethsemani.
La tradizione vuole che la statuetta, alta circa 60 centimetri,
fosse stata dipinta dalla mano dalla Divina Provvidenza. “La fama
dei suoi miracoli – scriveva il Belli – chiama questo Bambino a
visitare qua e là gl’infermi disperati di salute, e ciò accade
allorché lo stesso corpo di Cristo nell’eucarestia non gli abbia
risanati. I Religiosi zoccolanti lo trasportano in cocchio a passo
lento”. Si credeva che, in caso di grazia, le sue labbra divenissero
rosse, mentre si facevano bianche quando non c’era più speranza.
Padre Casimiro Romano racconta, nelle sue “Memorie storiche”, che
nel 1647 fu rubata ed i frati si videro costretti a sostituirla con
una copia. Una notte, sentirono bussare alla porta del convento,
mentre le campane di Roma suonavano festose. Andarono ad aprire e
trovarono il Bambinello che, da solo, era tornato a casa:
naturalmente, doveva essere stato riportato dal ladro, pentito del
suo gesto sacrilego. La copia venne donata al convento francescano
di Giulianello presso Cori e si trova ancora nella chiesa
parrocchiale del paese.
Da Natale
all’Epifania il Bambinello, stretto nelle fasce in tessuto dorato
tempestate di gemme, doni ed ex-voto, veniva esposto nello storico
Presepe che i frati allestiscono ogni anno dal 1774 nella seconda
cappella a sinistra della chiesa di S. Maria in Aracoeli, ricordato
in un famoso sonetto del Belli: “L’angeli, li somari, li cammèli, /
si li vedete, lì stanno a mijara: / c’è una Grolia che pare la
Longara; / e ce se pò contà li sette celi. Indietro c’è un paese
inarberato, / dove sarta sull’occhi un palazzino, / che dev’èsse la
casa der curato; / e avanti, in su la paja, c’è un bambino, / che
manco era accusì bene infasciato / er fio de Napujone piccinino”.
Ancora il Belli, in un altro sonetto, descrive il Bambino come “un
pupazzo pieno de fiocchetti tempestato de gioje”. Questo Presepe si
distingue per due personaggi veramente insoliti: Augusto e la
Sibilla Tiburtina, in ricordo della leggenda che vuole la chiesa
edificata a seguito di una profezia sibillina ricevuta dal primo
imperatore romano. Davanti al presepe dell’Aracoeli i bambini
recitavano una breve poesia o un piccolo, ma dotto sermone. “Sono
autentiche prediche in grande stile – annotava nel 1853 Ferdinando
Gregorovius – alle quali non mancano nemmeno importanti citazioni”.
Nel 1994 la
statuetta è stata nuovamente rubata, ma da allora nessuno scampanìo
è venuto a rallegrare le notti romane, annunciando il ritorno del
Bambinello: tutte le ricerche si sono rivelate vane. Ancora una
volta, i fedeli si devono accontentare di una copia.
di Cinzia
Dal Maso |
|
DUE SONETTI DEL BELLI DESCRIVONO LA SACRA
RAPPRESENTAZIONE |
"Anche Augusto e la Sibilla
nel presepe dell’Ara Coeli
 Semo
stati a vvedé ssu a la Rescèli / er presepio, ch’è ccosa accusí
rrara, / che ppe ttiené la ggente che ffa a ggara / ce sò ssei
capotori e ddu’ fedeli". Così inizia un celebre sonetto di Giuseppe
Gioachino Belli del 27 dicembre 1932 dedicato a uno dei più belli e
amati presepi romani, quello allestito ogni anno fin dal 1774 dai
frati zoccolanti nella seconda cappella a sinistra della basilica di
Santa Maria in Ara Coeli. Il poeta, per bocca di un popolano,
descrive con toni ammirati e vivaci la ricchezza della sacra
rappresentazione, che ancora oggi attrae un gran numero di fedeli,
disposti a inerpicarsi sui 124 gradini di marmo che portano alla
chiesa. "L’angeli, li somari, li cammeli, / si li vedete, llí stanno
a mmijjara: / c’è una Grolia che ppare la Longara; / e cce se pò
ccontà lli sette sceli". Certo il popolano esagera, parlando di
migliaia di angeli, somari e cammelli e paragonando il fondale a una
delle strade più lunghe e dritte della vecchia Roma. Non mancano
nemmeno gli anacronismi: "Indietro sc’è un paese inarberato / dove
sarta sull’occhi un palazzino, / che ddev’èsse la casa der curato".
Ecco ora la descrizione dell’elemento più importante: "e avanti, in
zu la pajja, sc’è un bambino, / che mmanco era accusí bbene
infassciato / er fío de Napujjone piccinino". Si riferisce al
veneratissimo Bambinello, scolpito a Gerusalemme, alla fine del
Quattrocento, da un religioso francescano, da un pezzo di legno
d’ulivo dei Gethsemani. Secondo una pia tradizione, la statuetta,
alta circa 60 centimetri, sarebbe stata dipinta dalla mano dalla
Divina Provvidenza. "La fama dei suoi miracoli – scriveva il Belli –
chiama questo Bambino a visitare qua e là gl’infermi disperati di
salute, e ciò accade allorché lo stesso corpo di Cristo
nell’eucarestia non gli abbia risanati. I Religiosi zoccolanti lo
trasportano in cocchio a passo lento". Si credeva che, in caso di
grazia, le sue labbra divenissero rosse, mentre si facevano bianche
quando non c’era più speranza. Padre Casimiro Romano racconta, nelle
sue "Memorie storiche", che nel 1647 fu rubata ed i frati si videro
costretti a sostituirla con una copia. Una notte, sentirono bussare
alla porta del convento, mentre le campane di Roma suonavano
festose. Andarono ad aprire e trovarono il Bambinello che, da solo,
era tornato a casa: naturalmente, doveva essere stato riportato dal
ladro, pentito del suo gesto sacrilego. La copia venne donata al
convento francescano di Giulianello presso Cori e si trova ancora
nella chiesa parrocchiale del paese. Semo
stati a vvedé ssu a la Rescèli / er presepio, ch’è ccosa accusí
rrara, / che ppe ttiené la ggente che ffa a ggara / ce sò ssei
capotori e ddu’ fedeli". Così inizia un celebre sonetto di Giuseppe
Gioachino Belli del 27 dicembre 1932 dedicato a uno dei più belli e
amati presepi romani, quello allestito ogni anno fin dal 1774 dai
frati zoccolanti nella seconda cappella a sinistra della basilica di
Santa Maria in Ara Coeli. Il poeta, per bocca di un popolano,
descrive con toni ammirati e vivaci la ricchezza della sacra
rappresentazione, che ancora oggi attrae un gran numero di fedeli,
disposti a inerpicarsi sui 124 gradini di marmo che portano alla
chiesa. "L’angeli, li somari, li cammeli, / si li vedete, llí stanno
a mmijjara: / c’è una Grolia che ppare la Longara; / e cce se pò
ccontà lli sette sceli". Certo il popolano esagera, parlando di
migliaia di angeli, somari e cammelli e paragonando il fondale a una
delle strade più lunghe e dritte della vecchia Roma. Non mancano
nemmeno gli anacronismi: "Indietro sc’è un paese inarberato / dove
sarta sull’occhi un palazzino, / che ddev’èsse la casa der curato".
Ecco ora la descrizione dell’elemento più importante: "e avanti, in
zu la pajja, sc’è un bambino, / che mmanco era accusí bbene
infassciato / er fío de Napujjone piccinino". Si riferisce al
veneratissimo Bambinello, scolpito a Gerusalemme, alla fine del
Quattrocento, da un religioso francescano, da un pezzo di legno
d’ulivo dei Gethsemani. Secondo una pia tradizione, la statuetta,
alta circa 60 centimetri, sarebbe stata dipinta dalla mano dalla
Divina Provvidenza. "La fama dei suoi miracoli – scriveva il Belli –
chiama questo Bambino a visitare qua e là gl’infermi disperati di
salute, e ciò accade allorché lo stesso corpo di Cristo
nell’eucarestia non gli abbia risanati. I Religiosi zoccolanti lo
trasportano in cocchio a passo lento". Si credeva che, in caso di
grazia, le sue labbra divenissero rosse, mentre si facevano bianche
quando non c’era più speranza. Padre Casimiro Romano racconta, nelle
sue "Memorie storiche", che nel 1647 fu rubata ed i frati si videro
costretti a sostituirla con una copia. Una notte, sentirono bussare
alla porta del convento, mentre le campane di Roma suonavano
festose. Andarono ad aprire e trovarono il Bambinello che, da solo,
era tornato a casa: naturalmente, doveva essere stato riportato dal
ladro, pentito del suo gesto sacrilego. La copia venne donata al
convento francescano di Giulianello presso Cori e si trova ancora
nella chiesa parrocchiale del paese.
Da
Natale all’Epifania il Bambinello, stretto nelle fasce in tess uto
dorato tempestate di gemme, doni ed ex-voto, veniva esposto nel
Presepe. Purtroppo nel 1994 la statuetta è stata nuovamente rubata,
ma stavolta non è tornata a casa: tutte le ricerche si sono rivelate
vane. Ancora una volta, i fedeli si devono accontentare di una
copia. uto
dorato tempestate di gemme, doni ed ex-voto, veniva esposto nel
Presepe. Purtroppo nel 1994 la statuetta è stata nuovamente rubata,
ma stavolta non è tornata a casa: tutte le ricerche si sono rivelate
vane. Ancora una volta, i fedeli si devono accontentare di una
copia.
Il
Belli aveva parlato di altri personaggi del presepe dell’Ara Coeli
in un altro sonetto del gennaio dello stesso anno: "Er boccetto in
perucca e mmanichetti / è san Giuseppe spóso de Maria. / Lei è
cquella vestita de morletti / e de bbroccato d’oro de Turchia".
Continua il popolano: "Cuello a mezz’aria è ll’angelo custode / de
Ggesucristo; e cquelli dua viscino, / la donna è la Sibbilla e ll’omo
Erode. / Lui disce a llei: «Dov’ello sto bbambino / che le gabbelle
mie se vò ariscòde?». / Lei risponne: «Hai da fà mórto cammino»". In
questo antico presepe ci sono infatti due personaggi veramente
insoliti, che non sono però Erode e la Sibilla, come credeva il
protagonista del sonetto. Si tratta di Augusto e della Sibilla
Tiburtina, posti a ricordo della leggenda medioevale secondo la
quale la chiesa sarebbe stata edificata in seguito alla profezia
ricevuta dal primo imperatore di Roma. A quest’ultimo la Sibilla
avrebbe annunciato la nascita di Cristo, mostrandogli l’altare del
figlio di Dio.
Davanti
al presepe dell’Aracoeli i bambini recitavano una breve poesia o un
piccolo, ma dotto sermone. "Sono autentiche prediche in grande stile
– annotava nel 1853 Ferdinando Gregorovius – alle quali non mancano
nemmeno importanti citazioni".
di Cinzia Dal Maso e Antonio Venditti |
|