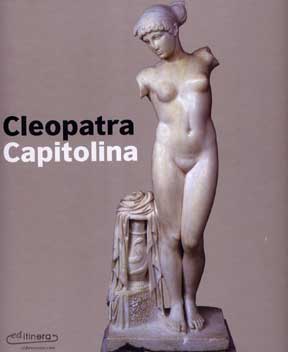 Nel
1874 veniva rinvenuta a Roma, lungo l’odierna via Ugo Foscolo,
nell’ambiente sotterraneo di una villa di origine tardo
repubblicana, una splendida statua in marmo di Paro, copia di un
originale tardo ellenistico, un nudo femminile a cui Carlo Ludovico
Visconti diede il nome di Venere Esquilina: identificazione che le
sarebbe rimasta addosso a lungo, nonostante piccole imperfezioni del
corpo e del viso, oltre a elementi propri del mondo egizio, la
rendessero alquanto improbabile. Solo nel 1955 Licinio Glori,
cultore di storia e di linguistica, nel testo di una lettura tenuta
all’Accademia dei Lincei e pubblicata in proprio, proponeva di
riconoscere nella donna quella famosa Cleopatra VII che nel 46 a.
C., ad appena 23 anni, aveva raggiunto Cesare a Roma con il neonato
Cesarione, frutto del suo amore con il dittatore: una felice
intuizione che non avrebbe però avuto un seguito negli anni
successivi, fino al suo rilancio nel 1994 da parte di Paolo Moreno
su nuove e solide basi, grazie a stringenti confronti e puntuali
analisi del tessuto storico. I risultati non si sono fatti
attendere: nel 2006 la scultura veniva accolta con tutti gli onori
ad Amburgo, quale protagonista della mostra "Kleopatra und die
Caesaren", prima di tornare nella sede "storica" del Palazzo dei
Conservatori.
Nel
1874 veniva rinvenuta a Roma, lungo l’odierna via Ugo Foscolo,
nell’ambiente sotterraneo di una villa di origine tardo
repubblicana, una splendida statua in marmo di Paro, copia di un
originale tardo ellenistico, un nudo femminile a cui Carlo Ludovico
Visconti diede il nome di Venere Esquilina: identificazione che le
sarebbe rimasta addosso a lungo, nonostante piccole imperfezioni del
corpo e del viso, oltre a elementi propri del mondo egizio, la
rendessero alquanto improbabile. Solo nel 1955 Licinio Glori,
cultore di storia e di linguistica, nel testo di una lettura tenuta
all’Accademia dei Lincei e pubblicata in proprio, proponeva di
riconoscere nella donna quella famosa Cleopatra VII che nel 46 a.
C., ad appena 23 anni, aveva raggiunto Cesare a Roma con il neonato
Cesarione, frutto del suo amore con il dittatore: una felice
intuizione che non avrebbe però avuto un seguito negli anni
successivi, fino al suo rilancio nel 1994 da parte di Paolo Moreno
su nuove e solide basi, grazie a stringenti confronti e puntuali
analisi del tessuto storico. I risultati non si sono fatti
attendere: nel 2006 la scultura veniva accolta con tutti gli onori
ad Amburgo, quale protagonista della mostra "Kleopatra und die
Caesaren", prima di tornare nella sede "storica" del Palazzo dei
Conservatori.
Ora Moreno approfondisce e amplia
nell’elegante volume "Cleopatra Capitolina" (Editinera, 84 pagine
riccamente illustrate, 29 euro), con testo in italiano e inglese,
l’analisi della scultura, "eseguita nella prima età imperiale a
guisa della statua dell’amata che Giulio Cesare aveva dedicato il 46
a.C. nel tempio di Venere Genitrice, dominante il nuovo Foro".
Collocazione di alto significato religioso e politico, che venne
rispettata da Ottaviano quando completò il tempio di Venere e il
Foro che prendeva il suo nome da quello del padre adottivo.
 L’archeologo
si sofferma sul tipo statuario, quindi analizza i dettagli
fisionomici, accostando il volto della scultura a monete e ritratti
della regina e scoprendone i tratti comuni: "il triangolo delle
guance, il naso dal dorso largo, il cui contorno si continua nel
sopracciglio appena arcuato tra la fronte bassa e l’occhio
dall’apertura stretta e allungata. Inconfutabile – continua lo
studioso – la peculiarità del labbro inferiore, carnoso e sporgente
rispetto a quello superiore, che è sottile e serrato: il prognatismo
ereditato dal primo dei Tolemei, più o meno riconoscibile
nell’immaginario numismatico e monumentale degli epigoni, secondo il
grado di realismo autorizzato dal committente". Accurata è la
descrizione della pettinatura, articolata in due livelli di lettura,
coerente con i ritratti ufficiali nel coronamento di riccioli sulla
fronte e consapevole del costume privato della regina nel
provvisorio accomodamento della chioma con una fascia prima del
bagno. Lo scultore ha fermato l’attimo in cui Cleopatra, dopo il
lavacro, con "la mano sinistra regge l’estemporanea, pesante
piegatura posteriore della chioma, mentre la destra ha sciolto un
estremo della benda, tirandolo lateralmente. Tra un istante la massa
verrà allentata poiché l’altro capo della fascia rimane appena
fermato trasversalmente sotto il lembo che la mano destra va
sollevando: se ne riconosce l’estremità che scende sui boccoli al
centro della fronte". Geniale il confronto di Moreno tra il largo
nastro e il diadema protocollare d’oro di Cleopatra, a conferma
della ricercata ambiguità dell’artista.
L’archeologo
si sofferma sul tipo statuario, quindi analizza i dettagli
fisionomici, accostando il volto della scultura a monete e ritratti
della regina e scoprendone i tratti comuni: "il triangolo delle
guance, il naso dal dorso largo, il cui contorno si continua nel
sopracciglio appena arcuato tra la fronte bassa e l’occhio
dall’apertura stretta e allungata. Inconfutabile – continua lo
studioso – la peculiarità del labbro inferiore, carnoso e sporgente
rispetto a quello superiore, che è sottile e serrato: il prognatismo
ereditato dal primo dei Tolemei, più o meno riconoscibile
nell’immaginario numismatico e monumentale degli epigoni, secondo il
grado di realismo autorizzato dal committente". Accurata è la
descrizione della pettinatura, articolata in due livelli di lettura,
coerente con i ritratti ufficiali nel coronamento di riccioli sulla
fronte e consapevole del costume privato della regina nel
provvisorio accomodamento della chioma con una fascia prima del
bagno. Lo scultore ha fermato l’attimo in cui Cleopatra, dopo il
lavacro, con "la mano sinistra regge l’estemporanea, pesante
piegatura posteriore della chioma, mentre la destra ha sciolto un
estremo della benda, tirandolo lateralmente. Tra un istante la massa
verrà allentata poiché l’altro capo della fascia rimane appena
fermato trasversalmente sotto il lembo che la mano destra va
sollevando: se ne riconosce l’estremità che scende sui boccoli al
centro della fronte". Geniale il confronto di Moreno tra il largo
nastro e il diadema protocollare d’oro di Cleopatra, a conferma
della ricercata ambiguità dell’artista.
Particolarmente interessante il
capitolo dedicato a Cesarione, "Il DNA di Cesare". Proprio a Moreno
va il merito di aver riconosciuto nella statua bronzea di un ragazzo
rinvenuta sotto la sabbia della spiaggia cretese di Ieràpetra le
sembianze del figlio di Cleopatra e Cesare. Puntuali le somiglianze
con quest’ultimo, soprattutto nel ritratto dei Musei di Berlino:
"elementi comuni e inconfondibili sono la bocca larga, le pieghe
scavate delle guance, gli zigomi alti, le grandi orecchie discoste
dal cranio, la stretta apertura degli occhi ravvicinati, soprattutto
il sistema di rughe sulla fronte, inspiegabili nella freschezza
dell’età se non come impronta ereditaria volutamente approfondita
dal plasticatore: due solchi verticali sopra la radice del naso e un
lungo tratto orizzontale".
Dell’argomento si parlerà a Nuova
Spazio Radio (88.150 MHz), nel corso dell’Intervista possibile di
"Questa è Roma", il programma ideato e condotto dalla professoressa
Maria Pia Partisani, in onda ogni mercoledì dalle 13 alle 14 e in
replica la domenica dalle 9.30 alle 10.30.
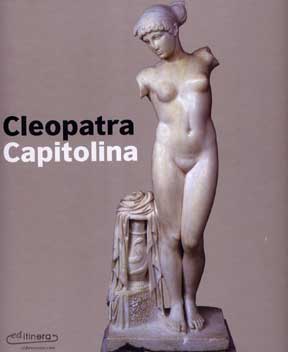 Nel
1874 veniva rinvenuta a Roma, lungo l’odierna via Ugo Foscolo,
nell’ambiente sotterraneo di una villa di origine tardo
repubblicana, una splendida statua in marmo di Paro, copia di un
originale tardo ellenistico, un nudo femminile a cui Carlo Ludovico
Visconti diede il nome di Venere Esquilina: identificazione che le
sarebbe rimasta addosso a lungo, nonostante piccole imperfezioni del
corpo e del viso, oltre a elementi propri del mondo egizio, la
rendessero alquanto improbabile. Solo nel 1955 Licinio Glori,
cultore di storia e di linguistica, nel testo di una lettura tenuta
all’Accademia dei Lincei e pubblicata in proprio, proponeva di
riconoscere nella donna quella famosa Cleopatra VII che nel 46 a.
C., ad appena 23 anni, aveva raggiunto Cesare a Roma con il neonato
Cesarione, frutto del suo amore con il dittatore: una felice
intuizione che non avrebbe però avuto un seguito negli anni
successivi, fino al suo rilancio nel 1994 da parte di Paolo Moreno
su nuove e solide basi, grazie a stringenti confronti e puntuali
analisi del tessuto storico. I risultati non si sono fatti
attendere: nel 2006 la scultura veniva accolta con tutti gli onori
ad Amburgo, quale protagonista della mostra "Kleopatra und die
Caesaren", prima di tornare nella sede "storica" del Palazzo dei
Conservatori.
Nel
1874 veniva rinvenuta a Roma, lungo l’odierna via Ugo Foscolo,
nell’ambiente sotterraneo di una villa di origine tardo
repubblicana, una splendida statua in marmo di Paro, copia di un
originale tardo ellenistico, un nudo femminile a cui Carlo Ludovico
Visconti diede il nome di Venere Esquilina: identificazione che le
sarebbe rimasta addosso a lungo, nonostante piccole imperfezioni del
corpo e del viso, oltre a elementi propri del mondo egizio, la
rendessero alquanto improbabile. Solo nel 1955 Licinio Glori,
cultore di storia e di linguistica, nel testo di una lettura tenuta
all’Accademia dei Lincei e pubblicata in proprio, proponeva di
riconoscere nella donna quella famosa Cleopatra VII che nel 46 a.
C., ad appena 23 anni, aveva raggiunto Cesare a Roma con il neonato
Cesarione, frutto del suo amore con il dittatore: una felice
intuizione che non avrebbe però avuto un seguito negli anni
successivi, fino al suo rilancio nel 1994 da parte di Paolo Moreno
su nuove e solide basi, grazie a stringenti confronti e puntuali
analisi del tessuto storico. I risultati non si sono fatti
attendere: nel 2006 la scultura veniva accolta con tutti gli onori
ad Amburgo, quale protagonista della mostra "Kleopatra und die
Caesaren", prima di tornare nella sede "storica" del Palazzo dei
Conservatori. L’archeologo
si sofferma sul tipo statuario, quindi analizza i dettagli
fisionomici, accostando il volto della scultura a monete e ritratti
della regina e scoprendone i tratti comuni: "il triangolo delle
guance, il naso dal dorso largo, il cui contorno si continua nel
sopracciglio appena arcuato tra la fronte bassa e l’occhio
dall’apertura stretta e allungata. Inconfutabile – continua lo
studioso – la peculiarità del labbro inferiore, carnoso e sporgente
rispetto a quello superiore, che è sottile e serrato: il prognatismo
ereditato dal primo dei Tolemei, più o meno riconoscibile
nell’immaginario numismatico e monumentale degli epigoni, secondo il
grado di realismo autorizzato dal committente". Accurata è la
descrizione della pettinatura, articolata in due livelli di lettura,
coerente con i ritratti ufficiali nel coronamento di riccioli sulla
fronte e consapevole del costume privato della regina nel
provvisorio accomodamento della chioma con una fascia prima del
bagno. Lo scultore ha fermato l’attimo in cui Cleopatra, dopo il
lavacro, con "la mano sinistra regge l’estemporanea, pesante
piegatura posteriore della chioma, mentre la destra ha sciolto un
estremo della benda, tirandolo lateralmente. Tra un istante la massa
verrà allentata poiché l’altro capo della fascia rimane appena
fermato trasversalmente sotto il lembo che la mano destra va
sollevando: se ne riconosce l’estremità che scende sui boccoli al
centro della fronte". Geniale il confronto di Moreno tra il largo
nastro e il diadema protocollare d’oro di Cleopatra, a conferma
della ricercata ambiguità dell’artista.
L’archeologo
si sofferma sul tipo statuario, quindi analizza i dettagli
fisionomici, accostando il volto della scultura a monete e ritratti
della regina e scoprendone i tratti comuni: "il triangolo delle
guance, il naso dal dorso largo, il cui contorno si continua nel
sopracciglio appena arcuato tra la fronte bassa e l’occhio
dall’apertura stretta e allungata. Inconfutabile – continua lo
studioso – la peculiarità del labbro inferiore, carnoso e sporgente
rispetto a quello superiore, che è sottile e serrato: il prognatismo
ereditato dal primo dei Tolemei, più o meno riconoscibile
nell’immaginario numismatico e monumentale degli epigoni, secondo il
grado di realismo autorizzato dal committente". Accurata è la
descrizione della pettinatura, articolata in due livelli di lettura,
coerente con i ritratti ufficiali nel coronamento di riccioli sulla
fronte e consapevole del costume privato della regina nel
provvisorio accomodamento della chioma con una fascia prima del
bagno. Lo scultore ha fermato l’attimo in cui Cleopatra, dopo il
lavacro, con "la mano sinistra regge l’estemporanea, pesante
piegatura posteriore della chioma, mentre la destra ha sciolto un
estremo della benda, tirandolo lateralmente. Tra un istante la massa
verrà allentata poiché l’altro capo della fascia rimane appena
fermato trasversalmente sotto il lembo che la mano destra va
sollevando: se ne riconosce l’estremità che scende sui boccoli al
centro della fronte". Geniale il confronto di Moreno tra il largo
nastro e il diadema protocollare d’oro di Cleopatra, a conferma
della ricercata ambiguità dell’artista.